
Presentazione
Tutte le mattine per tempo, brillasse nel cielo la buona stagione, o infierissero i rigori e le nebbie della cattiva, avreste potuto vederlo camminare verso il Duomo, rasente ai muri, la piccola figura avvolta nel saio da cappuccino, la barba bianca, in testa la calottina di maglia. Tutte le mattine, per 50 anni, ogni giorno, voi avreste potuto trovarlo sempre fedele al suo confessionale, consigliere ricercato, umanamente comprensivo e divinamente paziente, e sempre desideroso di perdonare, di soccorrere, di chiedere a chi poteva in favore di chi non poteva. Tutte le mattine, per 50 lunghi anni. Veramente ai 50 anni ne mancò uno: dal giugno 1944 al giugno 1945. Durante questi 12 mesi, i più duri, i più tristi, i più tormentati del secolo, sareste andati invano al suo confessionale in Duomo: lui non c’era. E’ la storia di quei dodici mesi che e raccolta in queste pagine. Di tutti gli altri anni non c e una riga: rientravano nel ritmo usuale d’ogni giorno, e il ritmo usuale non fa cronaca. Tuttavia proprio da questo anno singolare sorge una luce mite, irradiata da sofferenze indicibili, tutte offerteper amore, che illumina e spiega tutti gli altri 49. Per vivere infatti quei dodici mesi terribili con tale semplicita di cuore e letizia di spirito, bisognava av er superato una lunga e attenta preparazione. Intima pace ed effusa bontà pervadono tutte le pagine di questo breve diario. Non sono virtù dei deboli o dei remissivi, come talvolta si pensa: per dimostrarle nell’ora dei soprusi spietati, quando più nessun diritto della persona è rispettato, neppure quelli primordiali di respirare una boccata d’aria pura e di mangiare un tozzo di pane, mentre si è torturati da un lavoro massacrante, sfiancati dalle malattie e dallo sfinimento, affranti dalla morte dei più cari amici di sventura, quando non appare altra libertà che quella di farsi uccidere, altra speranza che quella di sovravvivere momento per momento, quando si è isolati dal mondo intero senza più alcuna possibilità di comunicare con i propri cari e di ricevere da loro una parola di conforto, dimostrare in tali circostanze tragiche pace e bontà è una vetta eroica a cui nessuno perviene senza una lenta, continua, sistematica ascensione interiore, vincendo ogni volta gli impulsi della sensibilità e dell’egoismo insiti nella natura dell’uomo. Padre Giannantonio vi si era ben allenato: aveva cominciato fin da ragazzo, a 14 anni, quando fuori di casa percorrendo 220 km a piedi per inseguire lo splendido ideale della sua vocazione! Aveva poi continuato, vivendo in tensione la vita di cappuccino, in novizia to a Lovere prima, poi a Roma per gli studi superiori, quindi a Cremona lettore di filosofia, per approdare poi, ancor giovanissimo al confessionale del Duomo di Milano. Qui era rimasto, fedelissimo al suo posto, con quel sorriso d’innocente che infondeva fiducia e ridonava speranza ai suoi amici peccatori. I diari che narrano le sofferenze dei campi di concentramento, oggi, sono numerosi. Tutti convengono nell’esecrazione di quegli inumani metodi di prigionia. Ma ciascuno si differenzia dagli altri, più che per le tristi vicende narrate, per lo stato d’animo con cui l’autore rivive la sua dolorosa storia. Qualcuno, narrando, l ascia trasparire l’odio, il rancore, il desiderio della rivendicazione, il compiacimento dove essa si è finalmente compiuta. Altri, d’ispirazione cristiana, esprimono, pur nell’accettazione della prova, e nella raggiunta capacità di perdonare, la ribellione della coscienza di fronte ai diritti della persona umana sistematicamente ignorati, conculca ti, vilipesi; santa indignazione, vorremmo dire! Questo libro è diverso: l’anima del Padre Giannantonio non sapeva fermarsi ad assaporare le tristezze, a rivangare i torti subiti. La dolce pazienza a lungo esercitata e l’espiazione dei peccati da lui non commessi, la carità allenata a pro tendersi verso tutti i bisognosi e i sofferenti, la sconfinata fiducia nella divina provvidenza (quella fiducia che gli permetterà di dormire placidamente, senza incubi nè sogni paurosi, la prima notte di carcere a S. Vittore), la sete dell’essenziale che rende sopportabile la mancanza di tutto il resto, emergono da ogni pagina di questo diario. Non cercatevi pregi letterari, se non quello di averli trascurati tutti. Era poeta nell’animo, non nelle parole, neppure quando sono ordinate in versi: tuttavia attraverso alla frase dimessa, alla parola umile, quella poesia interiore trapela come un lieve profumo affascinante. Cercatevi invece una testimonianza di vita cristiana e francescana. Lo dice il titolo che egli volle per queste sue memorie: «Nei Lager vinse la bontà». «Di proposito ho voluto lasciare ad altri memorialisti la narrazione del male che gli internati - ed io con loro - hanno veduto e patito, e ho scelto di osservare e riferire i tenui fili di bene che, prima nascosto, poi sempre più manifesto e infine trionfale, finì con il convincermi che veramente anche la bontà è entrata nei campi di concentramento, e n’è uscita, unica fra tutti i prigionieri, adulta, divenuta grande nel dolore e nella morte di milioni di vittime». Chi è buono trova dappertutto un riverbero di bontà. Padre Giannan tonio lo scorge anche nel crudele capo baracca che a Flossenburg sguinzaglia i suoi satelliti armati di bastone per impedire ai prigionieri di consumare in pace il loro misero pasto. Rivedendolo qualche tempo dopo, gli pare di cogliere nelle sue parole "una certa commozione , e commenta: «Forse in fondo al cuore qualche senso di umanità poteva averlo ancora; forse un qualche rimorso di quando in quando lo tormentava. Chi può giudicare?Il Vangelo dice che Dio non spegnerà il lucignolo fumigante...». In compenso non cessa di essere esigente con se stesso, e cerca dentro di sé per scovare le segrete, meno nobili motivazioni di gesti apparentemente limpidi e puri. E a Dachau: improvvisamente si trova di fronte il capocampo; dovrebbe togliersi il berretto e scattare sull’attenti, ma un senso istintivo di innata fierezza prende il sopravvento, e non saluta, rischiando l’arresto immediato. Ma poi si giudica senza indulgenza: «Invero, ripensandoci, mentre credevo di compiere un gesto di fierezza, dovetti costatare d’avere mancato alla carità evangelica, che prescrive di amare quelli che ci perseguitano, e alla perfetta letizia francescana, che fa gioire, sopportando per amore di Dio». E’ stato a lungo pensoso se scrivere o no le memorie delle «sueprigioni». L’averle scritte è il frutto di un sofferto contrasto interiore. «Non vorrei infatti che, rievocando uomini e cose, perdessi la serenità e la obiettività necessarie. E’ facile che un risvegliato risentimento per quello che si è patito o visto patire ne faccia esagerare il racconto, caricando le tinte e oltrepassando i limiti del vero. Purtroppo, anche stando alla sola verità, dovrò dire cose penose e umilianti per la civiltà moderna, ed inumane per tutti i tempi. Meglio sarebbe non rievocare, lasciando tutto nel silenzio dei campi stessi. Ma mi sono chiesto: sarebbe giusto?». E se scrivere bisognava, come arginare il ribo1lire delle passioni? Padre Giannantonio si fer ma, e medita: medita il Fioretto di S. Francesco: «...e uscirà fuori con un bastone nocchieruto e piglieracci per lo cappuccio egitteracci in terra e involgeracci nella neve e batteracci a nodo a nodo con quello bastone; se noi tutte queste cose sopporteremo pazientemente, e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali noi dobbiamo sostenere per lo suo amore, o fra te Leone, scrivi che in questo è perfetta letizia!». Ecco siamo giunti al punto centrale, che ci disvela la profonda personalità di Padre Giannantonio e l’alto valore della sua testimonianza. La grandezza di Padre Giannantonio è di essere stato solamente e integralmente un autentico francescano. Il valore del suo diario sta nella genuina interpretazione francescana della vita e del dolore. Udite ancora le sue parole, e saranno le ultime che riferisco: «Ero e rimanevo a S. Vittore perchè la forza non voleva sentir ragioni... e perchè Iddio disponeva che anch.’io salissi il calvario dell’internàmento in Germania come tanti poveri deportati di ogni classe sociale, per essere testimone e partecipe delle loro sofferenze, ed assisterli, sia pure con l’esercizio clandestino del mio ministero sacerdotale. E di ciò ancora oggi ringrazio Dio». Di là di ogni contingenza storica che l’ha provocato, questo libro esalta un valore perenne e appassionerà l’uomo anche quando non si parlerà più di nazismo, di fascismo e di lavoro forzato e di campi di eliminazione. Il perseguitato solo a motivo della libertà e della carità, il colpevole di fronte a inique leggi ma innocente in termini di umanità, il fascino conquistatore della vittima innocente, la sua capacità, anche nel momento stesso in cui è segregata e in catene, di raggiungere la vera libertà, quella interiore e spirituale, premessa di ogni altra libertà, questi sono gli alti motivi che faranno sempre commoventi, care e benefiche le pagine del diario di Padre Giannantonio da Romallo.
Milano, 2 fe bbraio 1968
Giovanni Card. Colombo Arcivescovo di Milano
Missione delicata e pericolosa
Chi entra nel duomo di Milano per una delle cinque porte della facciata e avanza tra la selva delle colonne, ammirando il duplice maestoso presbiterio, la cupola slanciatissima e le splendide vetrate, e s’inoltra per il largo passaggio che gira intorno al coro, vede, addossati alla parete dell’abside, sette grandi confessionali in stile gotico, finemente lavorati: sono i confessionali dei penitenzieri. Quello che sta nel mezzo, sotto il finestrone centrale, e porta scritta sulla fronte l’indicazione delle lingue che vi si parlano, il confessionale per le lingue estere. Il confessionale che occupo dal 1916, da quando un biglietto del mio superiore provinciale mi chiamava temporaneamente per sostituire un confratello. Confesso che fu per me come un fulmine a ciel sereno. A Cremona, dove allora ero di sede, insegnavo filosofia, nella quale mi ero di fresco laureato all’Università Gregoriana di Roma. Amavo i giovani studenti cappuccini, giovane anch’io non ancora trentenne, e amavo il solitario e tranquillo convento di quella città e la buona popolazione, che ormai conoscevo abbastanza bene. Mi rincresceva di dover cambiare posto ed ufficio, ma il solo desiderio del padre provinciale è sempre un comando. Pochi giorni dopo ero a Milano e incominciavo il mio nuovo compito. Penitenziere è un sacerdote particolarmente impegnato nell’udire le confessioni dei fedeli, con speciali facoltà per i casi di coscienza più gravi, ordinariamente riservati al vescovo o allo stesso romano pontefice. In ogni cattedrale c’è almeno un penitenziere, che di solito è un monsignore del capitolo dei canonici. Il duomo di Milano ne ha sei ed uno di questi è incaricato per la confessione degli stranien. E’ superfluo dire che per ragioni di questo mio ministero in un luogo così centrale e in duomo noto a tutto il mondo, fin dal principio venni a contatto con stranieri di ogni provenienza, non solo con quelli che per motivo d’affari o di studi risiedevano in Milano o in Lombardia, ma anche con quelli che si trovavano di passaggio; e questi erano moltissimi. Nel 1925 ad esempio, primo anno giubilare del secolo, in una sola mattina confessai penitenti di una quindicina di lingue diverse, come tedeschi, francesi, inglesi, polacchi, americani del nord e del sud, armeni, indiani, cinesi e persino una signora australiana. Non che io sia un poliglotta eccezionale, come il cardinal Mezzofanti, ma perché i penitenti stessi parlavano or l’una or l’altra delle lingue da me conosciute. A volte si presentavano autentiche personalità internazionali - davanti a Dio chi è re? -, come un notissimo principe austriaco, un delegato egiziano alla Società delle Nazioni, un famoso campione mondiale di pugilato - era un negro d’America. Particolarmente ricordo l’ammiraglio giapponese Jiamamoto, fattosi cattolico mentre era addetto navale all’ambasciata del suo paese a Roma, che mi lasciò una profonda impressione per la sua pietà, essendosi anche iscritto al terzo Ordine francescano e avendo voluto al battesimo il nome di Francesco. Nei suoi viaggi egli mi ricordò più volte, inviandomi cordiali saluti. Con Jiamamoto, che fece parlare di se durante la seconda guerra mondiale, ebbi lunghe conversazioni sullo stato e l’avvenire della religione cattolica in Giappone, nella quale egli manifestò tutto il suo ottimismo. Ma pure con altri stranieri mi intrattenevo sull’andamento religioso dei rispettivi loro paesi, specialmente extraeuropei e luoghi di missione, apprendendo così interessanti notizie di prima mano. Oltre al ministero in confessionale dovetti attendere, allargando in tal modo la mia missione, agli ammalati stranieri a domicilio, sia in Milano che nelle località vicine. Ciò avvenne s pecialmente durante la prima guerra mondiale, quando i sacerdoti stranieri dovettero lasciare l’Italia. Non che mancassero in città, fra il clero ambrosiano, sacerdoti che conoscessero più di una lingua, ma per la difficoltà di raggiungerli nelle rispettive parrocchie od uffici. Così avveniva che fossi chiamato negli ospedali od anche negli alberghi, accanto a stranieri di passaggio. Una volta fu lo stesso sindaco di Milano a portarmi con la sua macchina all’albergo Gallia per un’ammalata grave, delle isole Filippine, sua conoscente. Altro compito della mia missione era di curare i catecumeni, vale a dire coloro che, appartenendo ad altre religioni, chiedevano di essere ammessi alla religione cattolica. Questi nella massima parte erano protestanti, ortodossi, ebrei, musulmani. Io dovevo istruirli e prepararli al battesimo e infine, per delegazione dell’arcivescovo, battezzarli. Ciò mi dava occasione di continuo contatto con stranieri di ogni provenienza e condizione e, naturalmente, nasceva tra loro e me un certo legame di spirituale paternità che durava anche dopo il battesimo. Con molti di essi sono ancora in relazione personale o epistolare nonostante siano passati oltre quarant’anni dalla loro conversione alla religione cattolica. In proposito potrei rievocare molti episodi. Per me sacerdote era una grande soddisfazione il poter essere utile a tante anime che, diversamente, non avrebbero potuto facilmente compiere le loro pratiche religiose. La più bella e viva impressione che ho sempre avuto è stata quella di toccar quasi con mano l’universalità della fede cattolica, che è ugualmente viva e feconda pur fra genti così diverse, sparse in ogni angolo della terra. Cristo è dappertutto, ma la pienezza del suo regno, della sua luce, del suo amore, della sua grazia santificatrice è nella Chiesa cattolica. Dirò a parte della mia relazione con gli ebrei, che fu la causa immediata della mia vicenda . Ho voluto qui ricordare la mia particolare posizione di penitenziere degli stranieri nel duomo di Milano perché, dati i tempi - due guerre e rivoluzioni da ogni parte - era inevitabile che essa mi esponesse al pericolo di venir sospettato e molestato. Ne ebbi una prova durante la prima guerra mondiale. Una mattina si presentò al mio confessionale una signorina. Veniva regolarmente da qualche tempo e parlava francese. Mi era stata raccomandata in modo particolare dalla superiora del Cenacolo di via Monte di Pietà. Quando essa ebbe finito e se ne era ormai allontanata, una signora gentilissima si fece innanzi al confessionale e, un po’ turbata, mi disse: «Padre, l’avverto che la signorina da lei confessata ora è sul libro nero della polizia controspionaggio. Parla francese, ma è greca. Non vorreri che fosse coinvolto anche lei e andasse incontro a dispiaceri». Conoscevo molto bene quella signora, che parlava, del resto, per diretta conoscenza di cose; era infatti la moglie del presidente del tribunale militare di Milano, colonnello Annibale Anguissola. Donna gentilissima e religiosissima, non poteva certo parlare per qualche sentimento di ostilità verso di me, che ascoltavo regolarmente le sue confessioni. E conoscevo pure, già d’allora, il marito, perfetto gentiluomo e ufficiale valoroso. Ma debbo dire che rimasi un po’ seccato di un tale avviso e risposi: «Non vorrà, signora, che io chieda il passaporto a chi viene a confessarsi. Francese o greca, non m’importa: la signorina è cristiana cattolica. Tocca alla polizia indagare e prendere i provvedimenti del caso. Che se si dubita anche di me, eccomi pronto ad andare al confino!». La signora sorrise. «Caro Padre, rispose, non abbiamo nessun dubbio su di lei. Parlerò con mio marito. Resti tranquillo». Infatti non ebbi alcuna molestia e non credo che ne abbia avute la signorina. Era il buon senso italiano che prevaleva allora e che mi evitò una spiacevo le avventura. Da quel giorno anzi la semplice conoscenza con la famiglia Anguissola si trasformò in una profonda cristiana amicizia, che durò fino alla morte del colonnello, mutilato di guerra, e dell’ottima sua signora, essa pure ormai volata al cielo. Da allora dovevano passare vent’anni perché di nuovo incorressi nei pericoli che la mia missione di penitenziere in lingue estere andava maturando. Essi, alla fine, mi fecero inciampare nella rete dei tedeschi. E però necessario, per inquadrare la mia vicenda, che rievochi alcuni precedenti d’ordine storico e prima di tutto la mia posizione religiosa e morale che mi indusse ad aiutare gli ebrei.
La spada di Arminio
Al confessionale del duomo ebbi modo, in particolare, di vivere da vicino le grandi tragedie delle persecuzioni religiose che infierivano qua e là nel mondo contro la Chiesa cattolica. Ricordo specialmente le persecuzioni del Messico e della Spagna, in seguito alle quali numerosi cattolici furono costretti a fuggire dalla loro patria. Molti di essi, particolarmente spagnoli, giunsero a Milano e vi si stabilirono per lungo tempo, cioè fino al termine delle ostilità e la vittoria di Franco. Naturalmente la loro prima visita fu al duomo e il primo colloquio lo ebbero al confessionale dove si parlava la loro lingua. Se per i messicani bastò la mia assistenza spirituale, per i profughi iberici, ospitati in alcune case popolari vicine al convento dei Cappuccini di Monforte, fu necessario anche un aiuto materiale, poiché molti di essi erano ridotti alla vera miseria. Come si poteva restare indifferenti innanzi a spettacoli tanto dolorosi e non soccorrere quelle povere vittime innocenti dell’odio cieco dei loro tiranni? Potendo comprenderli e parlare con loro la loro lingua, ero pure in grado, più d’ogni altro, di conoscere la loro situazione e sentirne tutto l’atroce di sagio. Essi si mostrarono riconoscenti per quel poco che potei fare e tornati in patria mi scrissero più volte ringraziando. Ma venne un’altra persecuzione, più grave, più feroce, più prolungata, e questa nel centro della civilissima Europa: la persecuzione nazista contro gli ebrei. Infatti, con l’avvento di Hitler al potere - 1934 - furono emanate le cosidette "leggi razziali". Non si lasciarono certo in pace i cattolici, il cléro, i vescovi, le istituzioni religiose, ma l’odio si concentrò contro gli israeliti, semplicemente perché tali, cioè di razza non ariana. Con una ferocia degna del Gran Kan dei tartari, questi sventurati venivano arrestati, deportati e uccisi senza distinzione di sesso e di età, senza nemmeno la maschera di un processo qualunque: era il massacro per il massacro. Il mondo inorridì. I vescovi della Germania levarono subito la loro voce di protesta. Il cardinal Faulhaber, arcivescovo di Monaco, ne trattò in una pubblicazione polemica assai forte; Clemente Augusto Graf von Gallen tenne un discorso di condanna del razzismo, apparso poi in diverse lingue all’estero, che gli meritò la minaccia dell’arresto e della deportazione. Pure il Papa condannò, con una famosa enciclica, le leggi razziali e ogni violenza che esse comportavano. Anche l’esile e mite cardinale Schuster, in un omelia degna di Sant’Ambrogio, tenuta in duomo il 13 novembre 1938, diceva: «E’ nata all’estero e serpeggia un po’ dovunque una specie di eresia, che non solamente attenta alle fondamenta soprannaturali della cattolica Chiesa, ma materializzando nel sangue umano i concetti spirituali di individuo, di nazione e di patria, rinnega all’umanità ogni altro valore spirituale e costituisce così un pericolo internazionale non minore di quello dello stesso bolscevismo». E’ superfluo, continuava il cardinale, che io confuti qui una teoria simile che, isolando le varie razze umane, ponendo questa razza priviligiata di Arminio sopra tutte le altre razze e costituendola datrice di divinità e fondatrice di diritto, può creare domani una religione ed un giure, non semplicemente superiore, ma addirittura avverso alle are ed ai patri lari di tutti gli altri popoli». E condannando «codesta filosofia nordica, che è divenuta teosofia e politica insieme», il santo cardinale si augurava che «il genio dell’italica stirpe e la sapienza del nostro governo» avrebbero evitato alla Patria «questa novella eresia che ci opprime». Il discorso impressionò profondamente gli astanti ed ebbe viva risonanza in Italia e fuori. Mai il cardinale Schuster aveva toccato argomenti di tal genere e con tanta gravità di parola. Ma né «il genio dell’italica stirpe», né «la sapienza del nostro governo» porsero orecchio al monito del presule; si gridò invece al vescovo politicante, ribelle, traditore, e lo si voleva arrestare. Che stava dunque succedendo in Italia perché il prudentissimo arcivescovo di Milano facesse un discorso tanto allarmante? Dopo sedici anni di orgogliosa indipendenza ideologica e politica, il fascismo, rinnegando se stesso, la tradizione e il sentimento italiano, urtante e urtato con tutti - «Molti nemici, molto onore!» -, stava passando armi e bagagli al nazismo, del quale avrebbe accolto anche le criminose ideologie razzistiche. In quegli anni però - 1937-38 - esso non aveva ancora conchiuso con la Germania il noto Patto d’acciaio e Mussolini stesso aveva dichiarato che non c’era motivo di combattere gli ebrei, essendo essi stati sempre ottimi cittadini ed esemplari patrioti. Perciò gli ebrei tedeschi venivano in Italia con la fiducia di essere lasciati in pace; tuttavia la maggior parte di essi veniva di passaggio, diretta verso l’America o l’Inghilterra, perché temevano che Hitler, un giorno o l’altro, avesse ad occupare anche l’Italia. Era naturale che questi profughi, giunti a Milano e visitando il duomo, vedendo sul confes sionale che si parlava tedesco, si accostassero a me per chiedermi delle indicazioni. Benché ebrei, ossia persone tradizionalmente non disposte verso i cattolici e particolarmente verso gli ecclesiastici, in quei momenti per essi tanto pericolosi noi sacerdoti eravamo ancora le persone di cui maggiormente si potevano fidare. Impressionante fu l’ondata di fuggiaschi dall’Austria, quando questa nazione venne occupata dai nazisti. Mi ricordo che una mattina giunse in duomo una famiglia intera di ebrei; proveniente da Vienna: erano terrorizzati e volevano farsi subito cristiani e cattolici. Io risposi che per divenire cristiani bisognava essere convinti ed istruiti. Mi dissero che avrebbero dato una cospicua offerta alla Chiesa. «Peggio che peggio, risposi. La fede, come non si vende, non si compera». Non deve sorprendere, come non sorprese me, che quei poveretti avessero a parlare e a insistere così. Era visibile sul loro volto il terrore e assai volentieri li avrei aiutati; ma partirono subito e non si fecero più vedere. Intanto gli eventi precipitavano. Il 23 marzo 1939 si concludeva tra l’Italia e la Germania il Patto d’Alleanza, chiamato Patto d’acciaio, e il 1° settembre dello stesso anno i tedeschi aggredivano la Polonia e scatenavano la seconda guerra mondiale. Dopo meno di un anno, il 10 giugno del 1940, l’Italia entrava in guerra a fianco della Germania e l’orrendo ballo travolse il mondo. L’ora di Dio era passata invano. Dopo questi fatti, pian piano venne la volta anche degli ebrei italiani o da lungo tempo dimoranti in Italia. Alcuni di questi li conoscevo personalmente da molti anni, essendosi liberamente fatti cattolici ed avendoli io stesso istruiti e battezzati. Era questo, come ho già accennato, un compito del penitenziere in lingue estere. Essi però, pur essendo battezzati, non sfuggivano alle disposizioni emanate dal governo fascita, ormai pedissequo e servo di quello nazista. Potevo io disinteressarmi della loro sorte? Fortunatamente, finché l’Italia fu libera e indipendente, cioè fino all’otto settembre 1943, era facile aiutare gli ebrei italiani, perché il nostro governo non arrivò mai agli eccessi di crudeltà a cui era giunto il nazismo; ma dopo quella data, ossia dopo che i tedeschi presero fulmineamente possesso dell’Italia, fu prima loro cura di braccare, come cani affamati, gli ebrei. Quanti ne trovavano, tanti ne arrestavano e uccidevano. Basterebbe l’episodio di Meina, sul Lago Maggiore, dove diciotto ebrei furono buttati ad affogare nel lago. Le prigioni erano piene di questi poveretti e i treni partivano affollati per la Germania e la Polonia, trasformati alla fine, per la fame e il gas, in convogli di cadaveri. Purtroppo, con la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, le cose si fecero anche peggiori, perché i suoi aderenti fecero causa comune con le SS tedesche nella feroce caccia, non solo agli ebrei, ma anche agli stessi fratelli italiani che non volevano seguirli su questa via di sanguinosa criminalità. Si poteva assistere indifferenti a tale brutale prepotenza? Venne da sé che quanti avevano cuore e coraggio si adoperassero per aiutare e salvare i perseguitati dalla morte. Non si trattava infatti di politica - questa la facevano i partigiani - ma di vera carità cristiana, di senso di umanità. Sorsero così, a centinaia e a migliaia, persone che, con grave loro sacrificio e pericolo, fecero di tutto per sottrarre ai carnefici le vittime designate. Sacerdoti, religiosi, suore, istituti d’ogni genere, avvocati, professori, signorine, pastori di montagna, prima individualmente e poi, spesso, collegati per vie misteriose, si occuparono giorno e notte in quest’opera di salvezza. Quanti ebrei vissero nascosti mesi e mesi nei conventi, nelle case parrocchiali, nei collegi..., e quanti poterono rifugiarsi in Svizzera! Una vera centrale di attività fu l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ma anche il convento cappuccino di Monforte a Milano, con p. Carlo, p. Genesio, p. Romualdo, sarà un giorno dichiarato covo di giudaismo. Tra coloro che si occuparono in quest’opera di salvezza io fui dei più modesti e solo il fatto del mio arresto diede importanza al mio caso. Se ne parlo qui è solo per indicare il vero motivo della mia dolorosa vicenda.
Prime avvisaglie
C he da un giorno all’altro potessi essere arrestato lo presentivo e ne ebbi un primo chiaro avvertimento verso la fine di novembre 1943, quando fui avvisato che in un processo svoltosi al tribunale di Bergamo contro l’avvocato Hans Gudmann era stato fatto il mio nome. L’avvocato Gudmann era un mio caro amico. Nativo di Vienna e sposato con una russa, all’inizio della guerra aveva creduto prudente lasciare la capitale austriaca e trasferirsi a Milano. Egli era un buon cattolico, ma di origine ebraica. Non condivideva le idee naziste e si mostrava attaccatissimo alla sua patria. Io l’avevo conosciuto poco dopo il suo arrivo a Milano e mi legai presto a lui con profonda amicizia. Dopo i bombardamenti dell’agosto 1943 egli era sfollato a Bergamo con la sua signora. E qui venne arrestato e chiuso nelle carceri di S. Agata. La notizia dell’arresto e del processo di Bergamo mi diede qualche apprensione, non perché temessi dell’avvocato, ma perché sapevo che egli teneva nel suo taccuino il mio indirizzo e perché avevamo insieme lavorato alla salvezza di qualche ebreo. Più tardi fu la stessa signora Gudmann che venne a Milano a portarmi la dolorosa notizia e ad esortarmi di mettermi al sicuro; ma, pur ammettendo il pericolo che mi sovrastava, non feci nulla. Continuai la mia vita solita in attesa che gli eventi maturassero. Che però qualcosa di grave mi pendesse sul capo mi fu confermato da due fonti diverse nel gi ro di quegli stessi giorni. Infatti un soldato della Wehrmacht, che abitualmente si confessava da me, prima di allontanarsi mi disse: «Padre, devo salutarla. Con dispiacere non posso più tornare qui a confessarmi: il 2 nostro comando l’ha proibito a tutti» . Si badi che, sia con lui sia con altri, non avevo mai avuto un solo accenno alla guerra e alla politica; e quando mi riferì, senza commenti, le disposizioni del suo comando militare, io mi sforzai di non fare alcuna meraviglia. Nemmeno per sbaglio egli avrebbe potuto riportare qualche mia parola compromettente. Quella informazione era dunque una prova molto chiara che i tedeschi avevano dei sospetti su di me. Più allarmante, perché più precisa e circonstanziata, fu la notizia che ebbi, sempre nel torno di quei giorni, dal superiore del convento dei Cappuccini di Monforte, p. Agantangelo da Milano. Mi fece chiamare d’urgenza e con evidente preoccupazione mi disse: «Caro p. Giannantonio, ho una brutta notizia da darle. Le SS tedesche sono sulle sue tracce. In un processo a Bergamo, nei giorni scorsi, contro un certo avvocato Hans Gudmann, si è fatto il suo nome come complice di non so quale delitto. Occorre lasciare immediatamente Milano e non farsi più vedere finché i tempi non siano cambiati. La notizia è seria perché riferita dal prof. Masseo, comandante dei Volontari della Libertà. Pare che tutti i religiosi di questo convento siano presi di mira, ed io per primo. Forse dovremo seguire il suo esempio e lasciare Milano». La notizia era grave ed allarmante. Tanto più che ai primi di febbraio la signora Gudmann si fece un dovere di tornare a Milano a dirmi che il mio nome era di nuovo stato segnato sulla lista nera della polizia. I tedeschi non scherzavano. Partire! Ma dove andare? In un altro convento cappuccino era pericoloso; le case religiose della città e gli istituti ecclesiastici erano oggetto di perquisizioni ; in case private non mi gradiva. Pensai allora di rifugiarmi presso un parroco amico, a Brusugho, dove fui accolto a braccia aperte; e là tenni una settimana di predicazione. Un’altra settimana la passai presso la famiglia Pasqualini a Milano, in via Abano 6. Avevo però la persuasione che non mi accadesse nulla. E questo, assieme al fatto che, dopo quindici giorni, in duomo si reclamò la mia presenza per i molti stranieri che volevano confessarsi, mi indusse a ritornare. Rimasi tranquillo per parecchi mesi, convincendomi sempre più che le SS mi avevano ormai dimenticato. Ma me ne ero illuso. Ripresi così la mia attività caritativa in favore degli ebrei e di altri perseguitati, usando, naturalmente, maggiore prudenza e non occupandomi che di persone a me ben note o raccomandate da persone sicure. Intanto la polizia incominciava ad arrestare persone del clero. A Crema il confratello p. Prospero da Milano era stato preso e condotto nelle carceri di Cremona; sul comasco e in Valtellina erano stati arrestati don Tavasci, parroco di Piuro, e don Camillo Valotta, parroco di Frontale di Sondalo. A Milano, alla Cardinal Ferrari, era stata fatta una retata di ebrei e con essi fu preso anche il direttore don Paolo Liggeri. A Desio veniva arrestato il direttore del collegio arcivescovile don Mario Bonzi, a Varese don Franco Rimoldi, a Bergamo don Agostino Vismara, segretario dell’Unione sacerdotale diocesana delle Missioni... Dovevo dunque aspettarmi che un giorno o l’altro venisse pure la mia volta. Invece, almeno per allora, mi avvenne soltanto di dovermi sorbire un buon caffè. Una mattina, come al solito, uscito di buon ora per recarmi in duomo, giunto col tram alla fermata di via Tommaso Grossi, scesi ed entrai in galleria Vittorio Emanuele, deserta e oscura come la città. Le poche luci azzurre sembravano lumi per morti in una immensa cappella di cimitero. Benché vi passassi ogni mattina, vedendola così, la ga lleria mi faceva sempre una triste impressione. Chi non sa che in tempo di pace essa è il centro più mondano di Milano, illuminata a giorno dalla sera alla mattina, affollatissima e movimentatissima di gaudenti, di affaristi, di politicanti italiani e stranieri? Ora invece, specialmente la notte, era solo vigilata da guardie tedesche o da militi fascisti. Perciò entrando provai un certo senso di paura, temendo d’incontrarmi con qualcuna di esse, tanto più che a quell’ora perdurava il coprifuoco. Non ero ancora giunto al centro della galleria, quando, nel profondo silenzio, sento risuonare dei passi pesanti e cadenzati nel braccio che mette in piazza del duomo. Era evidentemente un militare. Ci siamo, pensai. Era infatti un milite fascista. Aveva il cappello d’alpino, la camicia nera, i calzoni grigi, le scarpe da montagna, il mitra e la pistola. Poiché veniva verso di me, cercai di evitare l’incontro frontale; ma egli si avvicinò e con piglio burbero mi disse: «Padre, venga a prendere un caffè». «Grazie, risposi. L’ho preso poco fa in convento». «Venga a prenderne un altro». «Grazie infinite. Noi non usiamo andare negli esercizi pubblici, salvo che per qualche necessità». «Se non usate, disse con tono autoritario, quasi di comando, userà questa volta. Venga!» E senza dir altro mi prese per un braccio e mi condusse nell’allora Caffè Campari, situato all’inizio della galleria. Lo seguii non senza trepidazione, convinto che dopo il caffè, o anche senza quello, sarei finito in prigione. Invece, sorbito in silenzio il caffè - che era veramente dolce e aromatico -, quel milite, cambiando d’improvviso atteggiamento ed espressione, mi prese la tazza, la depose sul banco e, stringendomi la mano mi disse sorridendo: «Grazie, Padre, che ha accettato il mio caffè. Io voglio bene ai Cappuccini. Sono stato in servizio in Africa, specialmente all’Asmara, e potei constatare quanto bene essi fanno laggiù sia agli italiani si a agli indigeni. Conosco molti Padri. Sono sempre stato accolto da loro con bontà e cordialità». Alzò la mano e mi salutò con gentilezza. Io ringraziai ed uscii, sorpreso e felice che la mia paura avesse un così lieto epilogo.
Il dono di Sant’Antonio
Fu il 13 giugno 1944 che i nodi per me vennero al pettine. Quel giorno, si sa, è la festa di Sant’Antonio e un po’ anche la festa mia, perché dei due santi, di cui porto il nome, ho scelto a mio patrono speciale il grande taumaturgo francescano. Quella mattina infatti celebrai la cosidetta messa conventuale con particolare solennità e al termine di essa, come di uso, i confratelli in sacrestia mi porsero gli auguri. A mezzogiorno poi ero atteso a completare la festicciola in refettorio, dove si sarebbe dispensato il silenzio, aggiungendo al solito pasto qualche specialità in onore del santo e del suo protetto. Mi recai quindi in duomo con animo lieto e sereno, ben lontano dall’immaginarmi ciò che mi sarebbe accaduto in quello stesso giorno. Dopo circa un’ora che stavo in confessionale, ecco venirmi davanti un signore italiano e chiedermi cortesemente: «Scusi; è lei, reverendo, il p. Giannantonio?» «Si, sono io, risposi». «Avrei da parlarle un momento; può uscire?» «Vengo subito». Appena fui uscito, sempre con un fare gentile, mi disse: «E’ pregato di venire al comando tedesco per una informazione. E’ qui vicino e tra una mezz’ora può essere di ritorno». Io compresi subito che ero arrestato. Mi balenò il pensiero di fuggire entrando in sacrestia, infilando il sottopassaggio e rifugiandomi in arcivescovado; ma non mi arrideva la vita del fuggitivo, ricercato dalla polizia. D’altra parte pensai essere più conforme alla mia dignità di sacerdote affrontare con coraggio il giudizio sul mio operato, sperando nell’aiuto di Dio. Decisi di andare al comando tedesco. Avvertii mons. penitenziere maggiore di riferire a S ua Eminenza e ai miei Superiori quanto mi stava accadendo, e, raccomandandomi alla Madonna delle Grazie, quella accanto alla sacrestia dei canonici, seguii il bravo servo delle SS. Fuori della porta laterale del duomo era ferma una automobile grigia con dentro una SS in divisa e un signore in borghese. Episodio gentile: mentre stavo per salire in macchina una signora, certa Colombo Teresa, mia conoscente e terziaria francescana, non comprendendo ciò che avveniva, mi salutò e mi diede cento lire per i poveri. (In quel momento il più povero ero io, che avevo solo un biglietto del tram per tornare in convento). Quei pochi soldi furono tutto il mio patrimonio fino a Flossenburg in Germania, dove anch’essi mi furono tolti. Pochi minuti dopo mi trovavo all’albergo Regina, in via Silvio Pellico. Qui era la sede centrale del comando delle SS. Da questo luogo partivano gli ordini di perquisizioni, arresti, deportazioni, fucilazioni, massacri. Se la parola non fosse troppo forte in bocca a un sacerdote, che è anche figlio di S. Francesco, direi che l’albergo Regina era un covo di assassini, tanto più criminali quanto più coperti di legalità. Tra i più famigerati, se non tra i più autorevoli personaggi di questo comando, era il maresciallo Kock (da non confondersi col capitano dello stesso nome, italiano, italianissimo e forse peggiore). Era lui, il maresciallo Kock, che spesso decideva ed eseguiva personalmente gli ordini del comando. E fu lui che, in divisa di SS, mi attese fuori del duomo e mi accompagnò all’albergo, nel suo ufficio. Naturalmente io non lo conoscevo, e forse per questo non mi diede molta soggezione quando, seduto dietro un largo tavolo incominciò ad interrogarmi. Il dialogo si svolse in tedesco. «Conoscete voi l’avvocato Hans Gudmann?» «Si, lo conosco, - risposi - è un mio buon amico». Il maresciallo alla mia risposta si animò e proseguì: «Allora conoscete anche questa signora (e mi mostrò la carta d’identità di una donna), e glielo ha dato lei questo falso documento». «No, non la conosco questa signora e non ho nè falsificato nè dato questo documento.» «Ma lei è accusato di aiutare gli ebrei. E’ vero?» «Si, è vero. Come penitenziere nel duomo per gli stranieri ho l’ufficio di istruire e di battezzare chi da altra religione vuol entrare nella Chiesa cattolica, qualunque sia; quindi anche gli ebrei». «Che c’entrano gli ebrei col confessionale? Lei ha abusato delle sue funzioni sacerdotali». «In confessionale non ho fatto della politica, ma della carità». «Chi le ha detto di far questo? il cardinale?» Il cardinale non mi ha detto niente. Egli ha raccomandato a tutti i sacerdoti di aiutare i bisognosi e i perseguitati». «Allora qualche monsignore?» «No, nessun monsignore!» «Ma lei ha avuto certamente dei complici». «Certo, c’è sempre qualcuno che aiuta a fare del bene». «Mi dica chi è costui o costoro». «Questo non lo dirò mai, perché voi tedeschi giudicate un delitto ciò che è per noi un’opera buona». «Lei ha tradito la patria». «Io non ho tradito la patria, perché in Italia non vi sono mai state leggi contro gli ebrei; le avete portate voi dalla Germania». «Ebbene se non parla, tengo lei responsabile di tutto». «Io mi prendo tutta la responsabilità». «Ma guardi che sarà mandato in campo di concentramento». «Andrò in campo di concentramento». «In campo di concentramento potrà essere fucilato». «Quando sarò nelle vostre mani, farete di me quel che vorrete. Una lezione per voi tedeschi, che chiamate tutti gli italiani traditori: ecco un italiano che non tradisce nessuno, neppure dinanzi alla vostra minaccia di fucilazione». Il maresciallo Kock, che per tutto l’interrogatorio si era mantenuto calmo, a questa mia ultima uscita fece un gesto da annoiato e non disse una parola. Subito dopo ordinò una ispezione in convento e volle eseguirla egli stesso, assistito da altri due funzionari. Non avendo nulla di comprome ttente, salvo un piccolo involto con documento di stato civile e religioso di una signora ebrea convertita, datimi in custodia alla vigilia del suo interna-mento in Bassa Italia ad opera di delatori italiani, condussi il maresciallo nella mia cella e gli consegnai l’involto sigillato. Non trovando altro, si ritornò all’albergo Regina e qui esaminarono il contenuto, con evidente delusione; poi mi si presentò il verbale da firmare. Contento che l’interrogatorio fosse terminato e non mi fosse sfuggita alcuna parola che compromettesse altri, io firmai senz’altro il documento. Forse ho fatto male a non leggerlo, ma per ogni eventualità ci tengo a dichiararlo. Dopo di che il maresciallo, con gesto imperioso diede ordine che fossi tradotto a San Vittore, le famose carceri di Milano. E venne egli pure ad accompagnarmi. Uscendo dalla stanza con la piena convinzione di essere condannato a non so quale castigo, mi accostai all’interprete italiano e, battendogli la mano su la spalla: «Caro giovanotto, gli dissi, che i tedeschi mi abbiano arrestato, ed ora mi mandino chi sa dove, non mi meraviglia; ma che un italiano come lei si presti a dar loro buon gioco in queste losche faccende, questo, si, mi fa vergognare di essere italiano». Il poveretto mormorò tra i denti una scusa e abbassò la fronte. Al secondo cancello delle carceri stavano attendendo alcune suore, tra cui la superiora, suor Enrichetta. Questa, che mi conosceva per essere io stato già, in parecchie circostanze, a confessare i detenuti e le detenute, vedendomi arrivare accompagnato dalle SS, esclamò: «Ma come, padre, anche lei?» «Si, anch’io, superiora. Sono venuto tante volte a esortare alla pazienza i poveri carcerati; ora vengo a esercitarla io stesso». Che cosa avrebbe detto, povera suora, se avesse potuto prevedere ciò che sarebbe successo a lei stessa pochi mesi più tardi? Compiute le pratiche d’ufficio matricola, venni assegnato alla cella 72 del I Raggi o, Il piano, dove mi condusse il sergente delle camicie nere, Manfredini. Confesso che, rimasto solo in quel sordido sgabuzzino, ebbi un momento di depressione. Ma durò poco. Mi misi a pregare con ardore che Dio mi desse la grazia di affrontare qualunque vicenda con fortezza e serenità. E mi sentii subito rinfrancato nello spirito e fidente in Lui. Erano le ore quattro del pomeriggio. E la festa di Sant’Antonio? Altro che pranzo allegro in convento in onore del santo! o auguri e brindisi per il mio onomastico! S. Antonio me l’aveva fatta davvero. Fame, umiliazione, prigione e chissà cosa di altro in seguito: ecco il dono che non mi aspettavo. Ma pure fu un dono e un grande dono, degno del celeste taumaturgo.
«Qui dentro siamo tutti galantuomini»
Chi non ha avuto la sorte, come l’ho avuta io, di essere ospite a San Vittore, potrà forse gradire una breve descrizione di questo famoso carcere e del suo funzionamento sotto il dominio tedesco. Entro il perimetro di un alto muraglione, con viadotto e torrette per le sentinelle, sorge il grande e massiccio fabbricato a forma di stella. Il centro di questa stella è costituito da una rotonda, la cui volta si eleva oltre il tetto dell’edificio. Essa serve come punto strategico per la vigilanza dei detenuti e anche come cappella, avendo nel centro un altare dove, di quando in quando, si celebra la S. messa. Nelle pareti della rotonda si aprono sei grandi androni (detti "Raggi" perché divergono come i raggi di una ruota o di una stella), alti dal suolo fino al quarto piano, larghi una ventina di metri e lunghi circa un centinaio, ciascuno dei quali riceve luce da un finestrone aperto nel fondo. Le celle sono disposte nelle pareti laterali degli androni, in quattro file una sopra l’altra, cioè al pian terreno, primo, secondo e terzo piano. Quelle dell’ultimo, più che celle, sono stanzoni dove i detenuti veng ono rinchiusi senza distinzione alcuna, a venti o trenta per volta. Due scale portano a ciascun piano superiore e alle ringhiere interne, che girano tutt intorno all’androne e danno accesso alle singole celle, segnate con un numero progressivo. L’uscio è di legno pesante, foderato con lamine di ferro, e, all’altezza delle spalle di un uomo, ha una specola di circa 20 cmq. dalla quale si può spiare nell’interno. Una cuccetta di ferro fissata al muro, con un pagliericcio e una grossa coperta grigia, è tutto l’arredamento. La cella riceve la scarsa luce da una fessura posta in alto e ben difesa da un’inferriata, per cui il detto «vedere il cielo a scacchi». Stando nella rotonda si può osservare con un colpo d’occhio tutto il pian terreno e tutte le singole celle dei diversi piani. Gli androni o raggi sono riservati agli uomini. Le donne hanno un reparto a sé, con entrata propria, congiunto con la portineria e all’alloggio delle Suore, loro assistenti. Altre celle speciali sono sistemate nei sotterranei per le punizioni di rigore. Dicono che siano orribili, ma, per grazia di Dio, io non le ho neppur viste. Tutto l’aspetto del carcere, anche come fabbricato, spira tristezza e squallore. Dei sei Raggi i tedeschi ne avevano messi a disposizione per i detenuti politici tre: il I, il V, e il VI. Nel primo venivano chiusi detenuti in aspettativa di esser smistati. Nel V i più pericolosi, con gravi accuse o condanne sul capo, predestinati ad essere vittime delle rappresaglie (per ogni tedesco ucciso venivano fucilati dieci italiani). Al VI Raggio finalmente stavano coloro che, più o meno, avevano dato fastidio alle SS o ai neofascisti, venivano addetti ai lavori interni del carcere, come alla cucina, al forno del pane, alla lavanderia, al guardaroba, alla biblioteca, a scopare ecc. Naturalmente questi ultimi godevano di una certa libertà di movimento e potevano facilmente procurarsi dall’esterno quanto d esideravano. Militi fascisti avevano incarichi di vigilanza. I secondini, tutti italiani, dovevano rispondere del comportamento di ciascun detenuto in cella e nei diversi momenti della giornata. errore di San Vittore era il caporale delle SS Franz che, come vedremo, faceva bene la sua parte di aguzzino quale ispettore di disciplina in tutti i Raggi politici. Ritornando alla cella 72 e a quelle prime ore del mio arrivo, mentre stavo ripensando ormai con calma ai casi della giornata e almanaccando su ciò che mi poteva riservare il prossimo avvenire, ecco aprirsi la specola dell’uscio e un ragazzo di quindici o sedici anni affacciarsi dicendo: «Padre, la saluta don Franco Rimoldi e le manda a mezzo mio queste ciliege e questo pezzo di pane. Io sono Pierino Spada che sto al Raggio VI, dove si trova anche don Franco, coi lavoratori». E subito scomparve per timore di essere sorpreso dalle SS. Mangiai volentieri quel pane e quelle ciliege, perché avevo fame davvero; e mi diede un gran sollievo il sapere che fra i detenuti politici vi era un altro sacerdote. Io non conoscevo don Franco Rimoldi, ma doveva essere di buon cuore se, appena seppe del mio arrivo, pensò a me. Non contento pero di aver mandato il ragazzo, una mezz’ora più tardi volle venire egli stesso e, aperto l’uscio (era d’accordo col secondino, che gli aveva dato la chiave), entrò in cella e, chiusa la porta, mi abbracciò affettuosamente. Era vestito in borghese. «Ben venuto, caro padre cappuccino», mi disse; «io sono don Franco Rimoldi, di cui le ha detto il ragazzo poco fa, assistente all’oratorio di Varese. Abbia pazienza qualche giorno e poi verrà anche lei coi lavoratori, al Raggio VI, dove son io, e godrà una certa libertà. Ci faremo buona compagnia. Anche qua dentro c’è da far del bene». Poi in fretta tornò fuori e richiuse l’uscio. Fu un nuovo e più vitale ossigeno per il mio morale. Don Franco ed io, infatti, ci facemmo ottima compagnia per quasi tutto il tempo d el mio soggiorno a San Vittore, fin quando cioè egli fu confinato a... Cesano Boscone, nell’«Ospizio S. Famiglia», sotto la vigilanza di mons. Moneta, il cui cuore, come è noto, era più grande del suo ospizio. Come potei constatare più tardi, don Franco godeva tra i detenuti politici un grande ascendente. Di statura quasi gigantesca, sempre sereno e sorridente, alla pietà e allo zelo sacerdotale univa una perspicace avvedutezza e un impavido coraggio. Egli aveva salvato numerosissimi ebrei e connazionali perseguitati facendoli riparare in Svizzera. Le SS, con tutta la loro astuzia, non riuscirono mai a coglierlo in fallo e, nonostante gli avessero sequestrato strumenti e carte compromettenti, nell’interrogatorio egli diede tali spiegazioni da passare quasi per vittima. Perciò, invece di essere deportato, fu liberato da San Vittore e confinato a Cesano Boscone, dove, in quei tempi, stava meglio che a casa sua. Prima di sera ebbi una terza visita molto significativa. Era costui un uomo anziano, evidentemente di condizione civile. Egli guardò dentro dalla specola e disse in tono vibrato: «Coraggio, padre. Sono anch’io come lei, un detenuto. Non si vergogni di essere in questo luogo. Qui dentro siamo tutti galantuomini». E scomparve. Chi l’avrebbe detto? Era l’avvocato Dante Frezzati di Milano, fervido comunista. Di lui feci in seguito più intima conoscenza nella biblioteca del carcere, dove si stette insieme qualche settimana. Quella sua dichiarazione di galantomismo dei detenuti politici mi riuscì molto gradita. Si sentiva in lui la fierezza di essere perseguitato per la ribellione contro lo straniero. In quel momento parlava in lui non il comunista, ma il patriota, l’uomo onesto, il senso di umanità. Non vi è come la comune sventura che faccia dimenticare le avversioni di parte. Dopo il rancio, che mi fu portato dagli addetti alla distribuzione e che trovai abbastanza s aporito, non avendo il breviario per recitare l’ufficio divino, in ginocchio dissi le preghiere della sera e mi misi a letto. Cosa strana! Nonostante le sconcertanti e penose vicende della giornata, mi addormentai placidamente e riposai tutta la notte, senza incubi e sogni paurosi, rassegnato a fare la volontà di Dio qualunque essa fosse. E svegliandomi al mattino, accorgendomi di essere, invece che nella cella del convento, in quella della prigione, ricordai le parole del buon comunista Frezzati: «Qui dentro siamo tutti galantuomini»; e quelle di don Franco: «Anche qui dentro possiamo fare del bene».
«Un caso particolarmente grave»
Quel mattino, dopo la prima notte di carcere, attendevo qualche altra novità a mio riguardo: o d’essere ulteriormente interrogato o cambiato di cella o altro. Rimasi invece chiuso nel mio sgabuzzino, dove mi portarono i pasti alle ore fissate e dove, durante la giornata, ebbi parecchie visite dandestine, oltrechè di don Franco, di altri «galantuomini» del Raggio VI, sempre - s’intende - molto brevi e solo attraverso la specola. Trascorsi così anche il giorno seguente. Ma io ero ansioso di sapere che cosa fosse accaduto fuori di San Vittore, in convento, in duomo, in città, quale impressione avesse suscitato il mio arresto e come venisse interpretato. Qualcuno dei detenuti mi disse che ormai in Milano se ne parlava molto. Il terzo giorno, era il 16 giugno, ecco venire alla specola della mia cella un detenuto, non ricordo se don Franco o altri, e mostrarmi il Corriere della Sera, edizione del pomeriggio, dandomi a leggere la seguente notizia:
L’arresto di un Frate
«E’ stato tratto in arresto a Milano il cinquantottenne cappuccino Giannantonio Agosti per aver favorito abusando della sua funzione sacerdotale, ebrei ed elementi ostili allo Stato. L’arrestato, i1 quale per 27 anni tenne un confessionale nel duomo, ha ammesso di aver consegnato, con l’aiuto di unfalsificatore di documenti, il cui nome egli non ha voluto indicare, false carte di identità ad ebrei. Egli ha pure confessato che gli accordi avvenivano in confessionale. Inoltre nella sua abitazione è stata rinvenuta la corrispondenza con numerosi ebrei, il che prova che l’Agosti ha favoreggiato, in modo inconciliabile colle leggi dello Stato, gli ebrei aiutandoli a trasferire all’estero il loro patrimonio e a fuggire. Si tratta di casi particolarmente gravi che meritano di essere esemplarmente puniti, anche per il buon nome del clero».
Era evidentemente un comunicato delle SS tedesche dell’albergo Regina. La notizia del mio arresto, colla rispettiva motivazione, veniva così diffusa al pubblico, dentro e fuori Milano. Perché? Altri sacerdoti, ben più importanti di me, erano stati catturati e nessun giornale ne aveva parlato. Pensai che fosse per rispondere indirettamente alle critiche di coloro che erano venuti a conoscenza del mio arresto in duomo. Bisognava pur giustificare in qualche modo un gesto così audace; e perciò osarono affermare che proprio in duomo, anzi in confessionale, si svolgevano i miei appuntamenti clandestini e la mia attività criminosa, insistendo particolarmente sull’abuso - da parte mia - della funzione sacerdotale. Anche il maresciallo Kock aveva insinuato, nell’interrogatorio, la stessa accusa e certo era lui l’ispiratore del comunicato. Si affermava poi che nella mia abitazione era stata rinvenuta la corrispondenza con numerosi ebrei e che questa era la prova che li avevo favoreggiati aiutandoli - ecco la mia grave colpa! - a trasferire all’estero il loro patrimonio. Se la prova del mio favoreggiamento fosse stata tale corrispondenza, io sarei risultato innocentissimo, perché, come dissi parlando della perquisizione delle SS, nella mia cella al conve nto non fu trovato nessun documento compromettente. Ma io avevo confessato, questo si di aver aiutato gli ebrei per carità cristiana. Ciò però non era inconciliabile con le leggi dello Stato, come avevo fatto notare al maresciallo Kock, durante l’interrogatorio. I tedeschi in Italia erano semplicemente occupanti; la Repubblica Sociale Italiana era una loro finzione. E se anche uno Stato legittimo avesse fatto delle leggi come quelle portate dai tedeschi nella nostra patria, in coscienza si potevano e si dovevano trasgredire per non essere complici dei massacri che tali leggi ordinavano. A parte le insinuazioni e la menzogna della numerosa corrispondenza cogli ebrei, due cose mi fecero piacere nel comunicato poliziesco: primo, che vi fosse ben delineata l’accusa, cioè per ave rfavoreggiato gli ebrei ed elementi ostili allo Stato (quindi grazie a Dio, nessun crimine morale); secondo, che vi fosse apertamente affermato che io non avevo voluto indicare il nome del falsificatore di documenti. Questo particolare era un chiaro avviso a coloro che avevano lavorato con me, nel caso che anch’essi fossero arrestati come sospetti miei complici, di non lasciarsi intimidire se si fosse detto loro che io avevo rivelato i loro nomi. Ma in cauda venenum. Il comunicato poliziesco terminava con la dichiarazione che il mio caso era uno dei più gravi e meritava di essere punito esemplarmente, anche per il buon nome del clero. Conoscendo il modo di agire delle SS non potevo dubitare della gravità della mia situazione. Il bravo maresciallo Kock me lo aveva fatto capire: o campo di concentramento o fucilazione o l’uno e l’altra. Ma in quelle ultime righe vi era pure chiara la minaccia di rincrudire la persecuzione contro il clero, s’intende, per il buon nome dello stesso clero. Era un monito per l’alta autorità diocesana e per lo stesso cardinale, che vigilassero per impedire il ripetersi di casi come il mio. Più tardi infatti il maresciallo Kock si presentò ripetute volte al convento cappuccino di Monforte in cer ca di altri frati ritenuti colpevoli del mio crimine, come p. Carlo, p. Genesio, p. Romualdo ed altri, ma la presenza di spirito del portinaio frate Cecilio e dei singoli interessati mandò a vuoto ogni suo tentativo. Anche in un altro senso il mio caso divenne particolarmente grave, cioè per la pubblicità che ad esso si volle dare. I milanesi non sono tanto corti d’ingegno da non saper leggere tra riga e riga quello che le SS volevano nascondere. La maggior parte del pubblico, come venni a sapere in seguito, accolse la notizia con dolorosa sorpresa. Ci fu perfino una mano gentile, rimasta ignota, che depose nel mio confessionale in duomo un gran mazzo di garofani rossi, considerandomi martire della persecuzione tedesca. Ah!... martire mancato! Molti s’interessavano per liberarmi. Non parlo dei miei superiori che fecero di tutto per avvicinare le SS dell’albergo Regina, ma ebbero un’accoglienza brutale. Tentarono una seconda volta, tramite un certo sig. Campofregoso, alto impiegato della ditta Borletti di Milano. Come tale egli aveva molto a che fare con le SS e, conoscendo a perfezione la lingua tedesca, ne divenne apparentemente un loro buon amico, ma, d’accordo coi capi della Resistenza, faceva il doppio gioco in favore dei nostri perseguitati. Un bel giorno, discorrendo con un capitano delle SS all’albergo Regina, chiese con simulata indifferenza: «E di quel frate che c’è a San Vittore che intendete fare? E’ un individuo alla buona, incapace di fare il politicante, che non si meritava tanta paura da parte vostra. Potete liberarlo quando volete!» «Quel frate?», rispose il capitano, «quel frate meriterebbe di essere immediatamente fucilato!» E troncò il discorso. Niente da fare; la missione era fallita. S.E. il card. Schuster si degnò intervenire personalmente in mio favore tentando la via diplomatica. Convocò in arcivescovado il console tedesco e chiese a lui di intervenire presso l’ambasciatore germanico, perché a sua volta trattasse l’affare con l’alto comando delle SS in Verona. Il console promise e promise anche l’ambasciatore al console, ma le cose andarono per le lunghe ed io frattanto venni deportato in Germania. Così neppure l’interessamento del cardinale ebbe esito positivo. Particolare efficacia avrebbe dovuto avere un altro intervento: quello del cappellano della comunità cattolica tedesca, mons. Krey, ma esso pure andò a vuoto. Monsignore mi conosceva bene; più volte mi aveva invitato sia alle feste religiose, sia alle feste nazionali della comunità. Molti dei suoi fedeli erano miei penitenti in duomo, e spesso avevo assistito i suoi ammalati all’ospedale. Cercò di fare ogni possibile per liberarmi, assicurando le autorità tedesche che ero sempre stato loro buon amico. Inutilmente! Mostratosi vano ogni tentativo di ottenere la mia liberazione con mezzi onesti e pacifici, vi fu chi ricorse ad argomenti d’altro genere: il denaro e la forza. Due famiglie di miei carissimi amici, ciascuna per proprio conto, offersero di pagare una rilevante somma alle SS se mi avessero lasciato fuggire. Queste furono incorruttibili. Forse si aspettavano prezzi d’affezione se tanto stentavano a vendermi... perché mi consta che, in altre circostanze, lasciarono libera una persona a me ben nota dietro lo sborso di qualche milione. E siamo a un tentativo eroico. Un gruppo di giovani, incipienti partigiani, capeggiato dal figlio d’una famiglia a me molto cara, concepì il disegno di dare l’assalto alle prigioni e strapparmi a viva forza dalle mani delle SS. In questo senso mi fecero pervenire un biglietto, raccomandandomi di tenermi pronto. Risposi subito per la stessa via che non intendevo prestarmi affatto a un progetto sì tanto temerario, che avrebbe fatto spargere sangue; e, ricordando la frase di don Fr anco, aggiunsi: «Anche in prigione si può fare del bene». Si vuole di più? Il mio caso divenne addirittura internazionale. Radio Londra, venutane a conoscenza, non so se prima, o dopo la pubblicazione del Corriere della Sera, narrò l’episodio del mio arresto elogiando il povero frate e il bene che faceva. A Radio Londra rispose Radio Roma dicendo di me tutto il male possibile. Conclusione: ero e rimanevo a San Vittore perché la forza non voleva sentir ragioni... e perché Iddio disponeva che anch’io salissi il calvario dell’internamento in Germania come tanti poveri deportati di ogni classe sociale, per essere testimone e partecipe delle loro sofferenze ed assisterli, sia pure con l’esercizio clandestino del mio ministero sacerdotale. E di ciò ancora oggi ringrazio Dio. Fu certo il periodo più intenso e più pieno della mia vita religiosa, l’unico forse in cui mi pare di aver vissuto integralmente la vita francescana nella povertà, nella sofferenza e nell’amore... con perfetta letizia.
Prigione allegra...
Dopo sei giorni di permanenza nella cella 72 del I Raggio delle carceri di San Vittore, fui traslocato al VI Raggio, tra i lavoratori, alla cella 112. Questa disposizione se mi tolse dall’isolamento, mettendomi in numerosa e interessante compagnia e in una relativa libertà interna, mi costò anche un grave sacrificio. Dovetti cioè svestire l’abito cappuccino e indossare la divisa dei detenuti a righe bianche e scure. Era la prima volta nella mia vita religiosa che lasciavo il saio di s. Francesco e tornavo in calzoni: e che calzoni! E’ ben vero che l’abito non fa il monaco, ma esso è sempre un simbolo e un richiamo della vita abbracciata ed io l’ho sempre avuto molto caro. Questa spogliazione, che durò per tutto il tempo del mio internamento, non fu l’ultima pena della dolorosa vicenda. Prima però di togliermi l’abito, un sergente delle SS mi con& shy;dusse nel primo cortile, a destra dell’atrio, e, fattomi appoggiare con le spalle al muro, mi appuntò sul petto un cartello sul quale, in grande, era stampato il mio nome: Giannantonio Agosti, e poi mi fotografò. Bisogna ammirare la prudenza e previdenza delle brave SS, che pensavano alla possibilità di una mia fuga e al modo più sicuro per rintracciarmi. Così figuravo ormai nell’archivio fotografico dei delinquenti. In compenso della perdita dell’abito potei riprendere la celebrazione della Santa Messa. Erano sei giorni che non salivo l’altare. Ogni mattina don Franco, mio capo e maestro, mi svegliava prima della levata comune e si andava insieme alla cappella delle Suore. Ciò continuò regolarmente durante tutta la mia permanenza a San Vittore. Le SS o non si accorgevano o fingevano di non vedere per riguardo alle Suore. Alla Santa Messa intervenivano, oltre le Suore, un buon numero di detenute politiche, tra le quali c’erano tre Suore Poverelle del Palazzolo con a capo suor Donata, superiora del grande Istituto, la signora Carla Ucelli, moglie dell’ing. Guido Ucelli, la signora Montanelli, moglie del noto giornalista, e parecchie altre persone. Il veder quelle donne in carcere sotto l’incombente minaccia della deportazione in campo di concentramento, faceva davvero impressione. Esse dimostravano coi fatti che il valore italico non era ancor morto, ma la loro condizione mostrava anche in tutta la sua gravità lo stato di servaggio cui gli italiani erano ridotti. Certe mattine portavamo clandestinamente la comunione ai degenti in infermeria e anche ai compagni del nostro reparto che la desideravano. In infermeria potei conoscere, fra gli altri, il signor Gasparini di Bergamo, uno dei 15 fucilati a piazzale Loreto, e il giornalista Indro Montanelli, i quali pure un giorno ricevettero la comunione. La comunione ai compagni di reparto era sempre tanto commovente. Ci si raccoglieva nella cell a di don Franco o nella mia e con grande cautela, perché non ci vedessero le guardie o qualche detenuto male intenzionato, si distribuiva la comunione in fretta. Poi ciascuno dei comunicati si ritirava altrove per il ringraziamento. Vi era sapore di catacombe e presentimento di non lontano martirio... Ricordare tutte le conoscenze e amicizie fatte nel tempo che rimasi nel VI Raggio di San Vittore sarebbe troppo lungo. Vi erano rappresentate tutte le classi sociali, tutte le condizioni e tutte le idee: alti ufficiali dell’esercito, avvocati, professon, grossi industriali e molti operai e contadini; cattolici, socialisti, liberali e comunisti, gente di tutti i partiti o senza partito. Sacerdoti eravamo soltanto don Franco ed io; ma parecchi vi erano stati prima e molti vennero dopo, anzi uno vi morì. Ognuno dei detenuti aveva la sua particolare imputazione, ma nessuno confidava all’altro il vero motivo del suo arresto, perché era convinzione comune che vi fossero tra noi molte spie, che avrebbero potuto aggravare di molto la posizione degli accusati. Alla domanda: «perché sei stato arrestato?», si usava rispondere: «perché ho rubato una bicicletta». Il che equivaleva a dire: «non interessarti dei fatti miei». Per parte mia non avevo bisogno di una simile cautela, perché i tedeschi stessi, come ho accennato, si erano incaricati di far sapere al gran pubblico i motivi del mio arresto. Nonostante queste prudenze e diffidenze, piano piano molti segreti si venivano a sapere nell’intimità dell’amicizia. Sarebbe bello fare la raccolta degli episodi che vennero a mia conoscenza; in essi la generosità e l’eroismo dei protagonisti rifulsero di luce vivissima; farebbero onore a tutto il popolo italiano. S’intende che non tutti meritavano la stessa ammirazione. Fra tanto numero mon potevano mancare i borsaneristi, i valutari e perfino i ladri e i traditori della patria. Un giorno vennero portati dentro u na sessantina d’individui: una vera retata. Liete accoglienze da parte nostra ormai anziani di carcere. Pensavamo a un’intera formazione di partigiani colti in un’imboscata. Sapete chi erano? Gli eroi del latte condensato! Tutti assieme avevano formato una combriccola per la vendita del latte alla borsa nera. Un’altra volta capitarono una decina di camicie nere con un giovane che si diceva ufficiale dell’esercito. Quest’ultimo raccolse subito la simpatia dell’ambiente, mentre le camicie nere erano autentici partigiani, vestitisi così per potersi più liberamente adunare in convegni segreti, mentre il finto ufficiale era il traditore che li aveva denunciati ai tedeschi. Per cui ho imparato una cosa e cioè che non tutti quelli che si vantavano di essere stati valorosi patrioti e martiri della libertà hanno le carte in regola. Per il trattamento non ci si poteva proprio lamentare nel carcere. Il vitto era discreto: pastasciutta e risotto alternativamente a mezzogiorno e a sera, caffè nero la mattina, pane a volontà. La domenica ci davano una porzione di carne col contorno. Per i vecchi e ammalati, ogni giorno, vitto speciale consistente in minestra e carne con verdura. Il giudicare chi fosse ammalato o vecchio spettava naturalmente al medico, e il dott. Gatti in ciò si mostrava assai comprensivo. Inoltre arrivavano dall’esterno, per cura dei familiari e del C.L.N., certi pacchetti forniti di ogni ben di Dio: financo bottiglie di quelle buone, che si consumavano generosamente tra gli amici. Ho già detto sopra che il Raggio VI accoglieva i detenuti politici destinati al lavoro. Veramente che lavoravano erano pochi, ossia quelli assegnti a particolari uffici, come pulizia del carcere, cucina, guardaroba, bagni, forno del pane, ecc. La maggior parte si può dire che appartenevano al dopolavoro, cioè all’ozio nelle celle del pianterreno. In queste si chiacchierava, si giocava alle carte, si fumava, si leggeva il gio rnale, si discuteva soprattutto di politica. Io fui destinato alla biblioteca col compito di tenere in ordine i libri e ripararli quando occorresse e distribuirli a chi li desiderava, portandoli io stesso ai detenuti isolati degli altri raggi. Mi accorsi ben presto che anche la biblioteca era... un dopolavoro, naturalmente per intellettuali. Vi trovai già addetti tre autentiche personalità: il gen. Zambon, aiutante in campo del principe ereditario, il gen. Robolotto, comandante dei bersaglieri e l’avv. Frezzati. In seguito vennero sostituiti dal col. Rossi, addetto alla famiglia reale, dal col. Ratti, attualmente generale comandante di divisione, e dal sig. Marrone, impiegato del comune di Varese. Ma ciò che più di tutto sollevava l’animo era la compagnia e l’affetto di tanti buoni amici. Ne ricorderò solo alcuni, per non essere troppo prolisso e anche perché, a dire il vero, di molti ho dimenticato il nome, e non potrei nemmeno consultare i registri del carcere, essendo essi scomparsi nei giorni della liberazione. Il primo a meritare particolare ricordo è il sig. De Bortoli, nativo veneto e residente a Varese, piccolo industriale di mobili, uomo di una bontà e generosità veramente ammirevoli. Aiutava tutti di sua borsa, ne sosteneva il morale dando esempio di serenità e pazienza cristiana nel sopportare la mala sorte. Fortunatamente potè sfuggire alla deportazione e tornare al suo lavoro. Altro il sig. Ugo Miorin, direttore tecnico dello stabilimento Bergomi di Milano. Fu arrestato perché cercò di salvare i suoi operai dalle razzie tedesche. Venne con me in Germania e per grazia di Dio sopravvisse ai disagi dell’internamento. Uomo compitissimo, di carattere calmo e sereno, profondamente cristiano, mi fece ottima compagnia. A questi devo aggiungere l’ingegnere Ucelli, il grande industriale degli stabilimenti Riva di Milano, marito, come già dissi, della signora Ucelli, chiusa nel repart o femminile; l’avvocato Giuseppe Sala, presidente generale delle conferenze di San Vincenzo per la Lombardia; l’avv. Bianchi, mezzo socialista, ma più cristiano; i due bravi cuochi, Baffi e Barbin, che si vantavano di essere comunisti, ma in realtà erano assai buoni e generosi nell’aiutare tutti. Nè posso dimenticare la guardia carceraria e infermiere Pergola, un siciliano schietto, generoso, pieno di spirito, che teneva allegri tutti col suo arguto eloquio meridionale e sapeva fare un vero apostolato cristiano tra i detenuti. Verso la fine del mio soggiorno in San Vittore conobbi pure il sacerdote don Massa di Genova, allora cappellano delle carceri di quella città e attualmente parroco, col titolo di monsignore, di San Pietro alla Foce, splendida chiesa da lui stesso edificata in questo dopoguerra. Questo degnissimo sacerdote era stato arrestato per aver consegnato a una detenuta politica, a nome del figlio, personalmente, 300 lire e, a mezzo di una guardiana, un pacchetto di biscotti. Egli mi fece ottima compagnia dopo la partenza di don Franco; il suo zelo e la sua esperienza mi furono di grande ammaestramento. Scrisse egli pure i ricordi della sua breve ma penosa vicenda, dai quali traspira tutta la sua anima sacerdotale. Venne liberato ai primi di agosto 1944. Tutti gli altri che non nomino li porto nel cuore, perché i compagni di sventura non li posso dimenticare mai.
…ma non troppo
A ricordarci, però, che eravamo a San Vittore e che il nostro destino poteva decidersi tragicamente da un giorno all’altro, vi era l’ineffabile Franz e un pauroso susseguirsi di avvenimenti che ricorderò più sotto. Caporale delle SS, Franz era il sovraintendente della disciplina del carcere per quanto riguardava i detenuti politici. Alto, tarchiato, grossolano, dallo sguardo sempre bieco, questo poliziotto d’occasione o di professione era il vero tipo dell’aguzzino. Spesso irrompeva all’improvviso, seguito da un enorme cane lupo, stringendo tra le mani uno staffile, pronto ad usar questo e ad aizzar quello contro chiunque avesse trovato fuori regola anche in cose da nulla. Al suo apparire, chi di noi l’avesse scorto, ne dava l’allarme ai compagni con la parola d’ordine: - Piove -, e tutti ci si ritirava o ci si mostrava intenti ai propri affari. A voler caratterizzare quest’uomo, basti ricordare come una volta, avendo scoperto nella cella di un detenuto un pezzetto di pane bianco, bastonò talmente a sangue il povero disgraziato, che questi, al culmine della disperazione, tentò di suicidarsi, ma ne venne impedito dai camerati. Venutone a conoscenza, l’ineffabile Franz lo incluse tra i quindici fucilandi a piazzale Loreto. Un’altra volta uccise addirittura, a percosse, un ebreo, colpevole di tenere nascosti alcuni gioielli, che avrebbe invece dovuto consegnare in portineria. Ma più che lo stesso Franz, a turbare la nostra spensieratezza concorse un seguito di avvenimenti tragici. Arrivò in carcere la notizia che a Greco un gruppo di operai aveva ferito un tedesco. Sapendo che ad ogni tedesco ucciso sarebbero stati fucilati dieci italiani, si attendeva che per un tedesco ferito almeno due o tre italiani avrebbero dovuto subire la fucilazione. Naturalmente gli ostaggi eravamo noi di San Vittore e qualcuno di noi doveva pagare. Invece furono fucilati tre operai dello stesso luogo dell’attentato, i quali forse erano innocentissimi. Un poco più tardi, per un fatto simile, accaduto non so dove, ben cinque operai vennero messi al muro. Le cose, dunque, si mettevano piuttosto male. Non era possibile pensare che le SS per vendicare i ripetuti attentati, continuassero a uccidere soltanto dei civili, non certo tutti colpevoli, e forse appena sospetti, mentre avevano in carcere tanti ostaggi quanti erano i detenuti politici, già designati a essere vittime di tali rappresaglie. Perciò noi, vedendoci continuamente esposti a questo pericolo, facevamo voti che gli operai, o chi per loro, fossero più prudenti. Le gravi conseguenze, di fatto, non tardarono a farsi sentire nel carcere. Verso i primi di luglio un gruppo dei nostri, compresi il generale Robolotto, il colonnello Marini e il famoso finto generale Della Rovere, furono mandati al campo di Fòssoli, presso Carpi. Questo campo era poco conosciuto da noi, ma si pensava che l’esservi destinati fosse quasi la salvezza: anzitutto perché in quel campo non doveva esservi pericolo di pagare per gli altri; e poi perché, essendo in Italia, si evitava la deportazione in Germania. Ma non passarono molti giorni che venne, proprio dal campo di Fòssoli, la tragica notizia della fucilazione inflitta a una settantina di internati, fra i quali parecchi di coloro che vi erano appena giunti da San Vittore, non esclusi i tre sopranominati. Era un grave colpo al nostro coraggio, già tanto compromesso. Ma motus in fine velocior; dicevano i latini. Il 10 agosto la morte entrò di nuovo a San Vittore a scegliere le sue vittime. Era la volta dei 15 fucilati di piazzale Loreto. Non dimenticherò mai la notte dal 9 al 10 di quel mese. Eravamo ormai tutti chiusi nelle celle, e non si era che al primo sonno, quando fui svegliato da un cupo martellare, dal fondo del V Raggio. Ebbi l’impressione che si trattasse d’un allestimento di casse funebri. Non si trattava invece che di una grande tavola da installarsi sul luogo dell’ esecuzione, per affiggervi un monito alla cittadinanza. Alle due circa della stessa notte si udirono passi cadenzati lungo le ringhiere ed uno stridìo di catenacci qua e là alle porte delle celle, compresa quella accanto alla mia. Poi un silenzio tombale. Avevano prelevato i quindici sventurati che vennero fucilati al mattino nella famosa piazza Loreto. Giuntaci dopo poche ore la notizia dell’esecuzione, fu per tutti noi u na vera angoscia. Si piansero i compagni uccisi, tra cui il signor Gasparini di Bergamo, a me tanto caro, e si pensò al pericolo di egual sorte che sovrastava su ciascuno di noi. Infatti altri dieci vennero isolati in attesa di prossima fucilazione al minimo incidente che si fosse verificato in città. La spada di Damocle oscillava sul nostro capo, appesa a un tenuissimo filo.
La mamma di San Vittore
Ho accennato al mio incontro, nell’atrio del carcere, con sr. Enrichetta, superiora delle suore addette al reparto donne; e ho pure detto che la conoscevo da tempo. Per tutto quello che vidi di questa mirabile suora durante la mia permanenza a San Vittore e per quello che seppi esserle accaduto poi, sarebbe una lacuna imperdonabile se non parlassi di lei in questi miei ricordi. Suor Enrichetta fu chiamata la Mamma di San Vittore e con questo titolo, dopo la sua morte, è apparso uno stupendo profilo steso dallo scrittore Claudio Sartori come introduzione al Diario, da lei lasciato, del suo arresto e della sua prigionia. Veramente, come nota il Sartori, tutte le suore di San Vittore in quel periodo così difficile e pericoloso si meritarono la più viva ammirazione e riconoscenza dei detenuti politici. «Piccole, poche suore, pallide, smunte, perse nella grande aureola inamidata, nascoste nella sottana grigia, informe sotto il mezzogiro del grande grembiule nero, che andavano e venivano, inebriate forse da questo incanto dell’aria di San Vittore (l’aria misteriosa di bontà che si sentiva aleggiare, in contrasto con la ferocia degli aguzzini). E, rese forse un poco incerte, sbagliavano così spesso di reparto, sconfinavano nei reparti maschili, nei reparti tedeschi, e si agitavano tanto, quasi prese dal vento, e facevano tante cose che parevano senza senso, che il carcere pareva pieno di suore, ché se ne trovava sempre qualcuna in ogni angolo, in ogni momento. E rano dodici in tutto. Ma anche questo doveva essere un incanto del luogo: parevano mille. E bastava aver bisogno di una di loro, per trovarsela d’accanto, Franz ne aveva sempre una di scorta. E non sapeva che farsene. Ma se la trovava sempre lì. E il suo cane non abbaiava». Il Sartori parla di sr Maria Grazia, di sr Gasparina, di sr Radegonda, di sr Onorina; ma erano tutte uguali: timide e coraggiose, semplici come colombe, avvedute come serpenti, secondo il detto evangelico, perché sapevano farla alle stesse indemoniate SS. Uscivano, continua Sartori, per recarsi in chiesa alle funzioni, o a far la spesa per la loro casa, e portavano fuori i messaggi più gravi. Incontravano i membri del Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia (C.L.N.A.I.), gli uomini più ricercati dalle polizie di ogni colore, andavano, mandavano a indirizzi sconosciuti avvertimenti e note di salvezza; ricevevano, a recapiti fissi, denari, viveri, indumenti. E li portavano dentro, tornando imbottite di ogni sorta di cose e di posta di tutte le specie, aiutate esternamente in modo particolare da una consorella, sr Beniamina, superiora della Fanciullezza abbandonata, della stessa tempra e coraggio che esse dimostravano. Se io ebbi possibilità di comunicare più volte, mediante bigliettini, con i miei confratelli, lo devo appunto a queste meravigliose donne, votate a Dio e alla Patria con i più grandi rischi della loro stessa vita. Ma chi era l’anima di tanta generosa e pericolosa attività di quel piccolo gruppo di suore? Dopo Dio, era appunto quella che fu chiamata la Mamma di San Vittore, mamma non solo delle prigioniere comuni o dei bimbi da esse nati in carcere, ma anche di tutti i detenuti politici: suor Enrichetta Maria Alfieri. Al tempo cui mi riferisco - 1944 - non era più giovane, ma neppur molto vecchia. Rilevo dalla biografia del Sartori questi dati. Era nata a Borgo Vercelli il 23 febbraio 1891. Ebbe giova&s hy;nissima la vocazione di consacrarsi a Dio e, seguendo l’esempio di due zie e di una cugina, si fece suora di carità fra le cosiddette Bigie di Vercelli, un ramo fresco e vitale della congregazione delle Suore di Carità di San Vincenzo dette le Cappellone. Da suora studiò e fu diplomata maestra. Ma si ammalò presto e dovette stare a letto per ben quattro anni. Fu decisa la sua andata a Lourdes il 24 agosto 1922. Non ebbe la grazia della guarigione, ma quella della più perfetta rassegnazione. Il 5 febbraio 1923 riceveva i sacramenti dei moribondi, assistendo la messa in camera; ma il 25 dello stesso mese, anniversario della nona apparizione della Madonna di Lourdes, sr Enrichetta guarisce improvvisamente e scende in cappella a ringraziare la Madre celeste. Poco più tardi fu trasferita a Milano nella comunità addetta alle carceri di San Vittore, dove era superiora sua zia sr Elena, altra figura di suora stimatissima e amatissima nell’ambiente del carcere e fuori. Io la conobbi fin d’allora, poiché andavo a confessare i carcerati comuni e a far qualche predica al reparto donne. Modesta, gentile, delicata, serviva in chiesa, portava a tavola il caffè, era il braccio destro della zia superiora. E quando questa fu trasferita altrove, sr Enrichetta fu fatta superiora al suo posto, essendo ormai ben preparata e capace di guidare la piccola comunità. Figura angelica, dal volto sempre sorridente di un sorriso mesto per il riflesso dei dolori in mezzo ai quali si trovava, luminosa di una luce soprannaturale, ispirava bontà e fiducia. Le suore erano felici di obbedirla e di seguirne gli esempi. Il personale italiano del carcere ne aveva altissima stima e gareggiava nel favorirla in tutti i modi possibili. Gli stessi tedeschi subivano il suo fascino e, infine, furono vinti dalla sua bontà, come il lupo di Gubbio da S. Francesco. Franz le concesse un giorno, come ella ricorda ne l piccolo Diario, che fosse sospesa la deportazione, ormai decisa, di una madre ebrea, che aveva un bambino alla mano ed era in attesa di un altro. Mamma di tutti e per tutti, pensava non solo a quelli che erano in carcere, ma anche ai parenti, agli amici, ai compagni di essi, ricercati e in procinto di arresto. Fu per questa sua attività che un giorno si vide perduta, andando a finire in una cella di rigore, nel buio sotterraneo di San Vittore, la cella dei topi. Ecco il racconto che ne fa il Sartori. «Aveva accettato di portare un avvertimento ai fratelli di una carcerata. Non potendo andare di persona mandò una guardiana a portare un suo biglietto alla famiglia Ucelli, che abita poco distante da San Vittore, perché qualcuno s’incaricasse della missione. Gli Ucelli erano persone fidate a tutta prova. Mentre la signora Carla e il marito, oltre che d’altro, s’occupavano di aiutare il passaggio clandestino degli ebrei in Svizzera, Bona, la figlia maggiore, a loro insaputa aveva ospitato nelle stanze di servizio la redazione del giornale clandestino il Ribelle. La guardiana non trova in casa nè la signora Carla nè Bona (conosciuta come Anna) e consegna il biglietto alla giovane moglie del figlio Ucelli. Questa, impressionata dell’urgenza del messaggio, non attende il ritorno della cognata e della suocera e si reca lei stessa all’indirizzo indicato. Ma, poco pratica, ché la sua recente maternità l’aveva tenuta discosta dal movimento della Resistenza, non s’avvede che ad accoglierla è gente della questura e cade nel tranello che le vien teso. Le conseguenze furono normali per i tempi: arresto della signora Ucelli, della guardiana e della madre superiora di San Vittore, fra la costernazione generale». Il seguito della vicenda è raccontata da sr Enrichetta nelle Memorie da lei scritte per obbedienza a liberazione avvenuta. In esse la suora, con la semplicità di una bambina, ma in modo assai vivo e drammatico, descrive il terrore provato nel vedersi buttata nella cella dei topi mentre porta indosso una quantità di biglietti e di preziosi che, scoperti in una visita di controllo, avrebbero aggravato enormemente la sua imputazione. Trova conforto nella preghiera e straccia minutissimamente la corrispondenza clandestina gettandone i pezzi in un oscuro corridoio cieco attraverso un buco di finestra. Scongiura il Signore che le risparmi la visita delle SS per salvare i preziosi da consegnare a persona fidata. Dopo momenti di relativa tranquillità e rinnovate trepidazioni, viene tolta, in giornata, dal sotterraneo e chiusa in una cella del Reparto Isolati in attesa dell’interrogatorio. Suore, personale, detenuti politici considerano il suo arresto un fatto gravissimo. Si parla di fucilazione, di deportazione in Germania. Interviene il cardinale e mons. Bicchierai. Intanto il medico la obbliga a stare a letto per ritardare l’interrogatorio e l’inevitabile condanna. Invece, dopo alcuni giorni, miracolosamente, viene ordine di scarcerazione e internamento in un convento del bergamasco, a Grumello, presso l’istituto Palazzolo. Qui è ricevuta da madre Donata, superiora, che già era stata ospite di San Vittore, sotto la custodia di madre Enrichetta. Breve terribile dramma, ma a lieto fine. Qualche mese più tardi sarà lasciata libera di rientrare nella casa della sua congregazione a Brescia, dove resterà fino al termine della guerra. Dopo la liberazione, ritornato il sereno e la pace - pace relativa, specialmente per San Vittore - madre Enrichetta viene rimandata a Milano, alle stesse carceri e allo stesso ufficio di superiora. Non più detenuti politici della Resistenza, non più i tedeschi, ma i fascisti e i banditi, tra cui il famoso Barbieri, ella trova alloro posto. Madre Enrichetta riprese la sua missione serenamente, con dolcezza e bontà, tornando ad essere, come prima e più di pri& shy;ma, la Mamma di San Vittore, ma più affinata dalle prove subite. Quando, nel 1951, si ammalò - morì infatti alle ore 15 del 22 novembre - ed io l’andai a visitare per l’ultima volta e consolarla con la benedizione, giaceva sul letto nella celletta a pian terreno, ed era sfinita. Quella stanza appunto, vicino alla cappelletta, dove, durante il mio soggiorno in carcere, mi aveva tante volte portato, dopo la santa messa, il caffelatte e le notizie più recenti dell’esterno. Benchè conscia della gravità delle sue condizioni, pallida e smagrita fino ad impressionare, conservava l’indimenticabile sorriso, che un tempo era sempre velato di mestizia ed ora invece soltanto gioia e felicità. Era felice di morire. E chi non lo sarebbe dopo una vita come la sua, tutta consacrata al bene, generosamente ed eroicamente? Per lei infatti possiamo dire che anche a San Vittore vinse la Bontà.
Da San Vittore a Bolzano
Il 12 agosto ci avvertirono che per la festa della Assunzione della Vergine un sacerdote, in rappresentanza del cardinal Schuster, avrebbe celebrato all’altare della rotonda. Infatti la mattina del 15 agosto varcò la soglia di San Vittore mons. Bicchierai, il fido abile diplomatico «trait d’union» fra il cardinale e le autorità tedesche. I detenuti del VI Raggio vennero adunati nella rotonda e androni adiacenti; quelli isolati degli altri raggi potevano assistere dalle rispettive celle attraverso una leggera apertura della porta. Servii io stesso la messa a monsignore. Mentre indossava i sacri paramenti mi avvertì che era imminente una forte spedizione per i campi di concentramento in Germania e che ci tenessimo quindi preparati. Al Vangelo tenne un breve discorso molto prudente per la presenza delle SS e dei loro interpreti, ma sufficientemente chiaro per dirci di star di buon animo, che le sorti volgevano decisamente a nostro favore. Durante la santa messa ebbi il compito di portare la comunione ai dieci isolati, e non so dire la pena che provai vedendo quei poveretti, tutti ostaggi e tutti giovani, sotto l’incubo dell’orrenda aspettativa. Pensai naturalmente alle loro mamme, che certo non sapevano nulla, ma che da un momento all’altro potevano ricevere la funesta notiza della loro morte. Il giorno dopo, 16 agosto, si avverò quanto monsignor Bicchierai aveva preannunciato. Alle tre del pomeriggio un ordine secco delle SS, ripetuto di cella in cella dalle guardie, intimò l’adunata generale nell’androne del nostro raggio, dove fummo messi subito sull’«attenti». Apparve il caporale Franz con numerose cartelle che consegnò all’interprete. Era l’elenco dei destinati in Germania. «Rispondete» disse l’interprete, «con la parola hier» (eccomi). «Agosti Giannantonio!» «Presente!» Fui il primo chiamato in ordine alfabetico e risposi chiaro e forte in italiano, cercando di mostrare un po’ di coraggio e un po’ di sfrontatezza per animare i compagni che sarebbero stati chiamati in seguito. I nominativi salirono a cinquecento, più dieci isolati e un forte gruppo di donne: in tutto circa settecentocinquanta. Immediatamente dopo la chiamata ci rinchiusero, pigiati all’inverosimile, nelle celle a pianterreno; e vi restammo così fino a mezzanotte. Quindi ci inquadrarono lungo il primo raggio e nell’atrio, ove ci restituirono quanto ci avevano tolto all’entrata in carcere. Io riebbi le 100 lire ricevute sulla porta del duomo, ma mi fu trattenuto l’abito religioso, che una SS mi aveva sequestrato in cella qualche settimana prima. Esso non mi fu più restituito. Alle cinque del mattino si spalancarono le porte della prigione e rapidamente, sotto la minaccia dei mitra delle SS, questa volta anche italiane, ci fecero salire sopra una decina di torpedoni, ben scortati all’interno e all’esterno da un nugolo di armati. Poco prima delle sei fu dato il via. L a città era ancora immersa nel sonno e le vie quasi deserte. Ebbi l’impressione che il popolo milanese o non sapesse della nostra partenza, o, abituato ormai a ogni violenza dei tedeschi, non si interessasse più della nostra sorte. Il popolo italiano, confuso e diviso da contrastanti partiti e da insipienza di governanti, doveva esperimentare altre sofferenze e tragedie per ritrovare se stesso e insorgere poi eroicamente alla riconquista della sua libertà e indipendenza. Le carceri, gli internamenti, le fucilazioni che continuarono con terribile crescendo, furono il prezzo della liberazione. Scrisse un autentico eroe della Resistenza, caduto in campo di concentramento: «Non vi sono popoli liberati, ma popoli che si liberano». Il convoglio dei torpedoni, percorrendo vie secondarie della città, giunse a piazzale Loreto e per via Padova imboccò la statale di Brescia. Ciò faceva supporre che eravamo in viaggio per la Germania. Era un bene? Era un male? Non potevamo saperlo. Finchè fossimo rimasti a San Vittore c’era, si, il pericolo di qualche rappresaglia, ma restava sempre la speranza che l’intervento di qualche persona autorevole o un qualsiasi fatto bellico o partigiano ci restituisse la libertà. Ora invece eravamo in piena balìa dei nostri aguzzini e solo Dio poteva sapere come saremmo andati a finire. Dovevamo dire a Milano un semplice «arrivederci» o un «addio per sempre?» L’angosciosa incertezza dava al nostro viaggio, che poteva sembrare una gita di piacere, un tono da funerale. Sorpassammo Brescia e Peschiera e si proseguì per Riva lungo la Gardesana orientale. L’occidentale infatti era stata trasformata, nelle sue numerose gallerie, in altrettanti arsenali di guerra. A pochi chilometri dalla cittadina di Garda si fece sosta per comprensibili necessità. Le SS, imbracciato il mitra, ci obbligarono a non allontanarci oltre i dieci passi. Imbarazzante per gli uomini, ciò fu un insulto al pudore delle donne; ma fu solo un saggi o della delicatezza con la quale saremmo stati trattati nei campi di Germania. Verso mezzogiorno si giunse a Riva e un’ora dopo, percorrendo la valle del Sarca e passando per il «Bus de Vela», a Trento. Si sperava che finalmente ci avessero a dare qualche cosa da mangiare, non avendo avuto dal giorno prima nemmeno un bicchiere d’acqua. Invece si proseguì il cammino girando al largo dell’abitato. Qui incominciarono i luoghi a me noti dalla fanciullezza: Lavis, Mezzolombardo, la Rocchetta, imboccatura della valle di Non, mia valle natìa, Laives da cui parte la strada per il santuario di Pietralba, da me visitato la prima volta a nove anni con il povero papà, Monte Roén, il passo della Mendola e altri ancora. Queste fuggevoli visioni e l’incalzare dei ricordi intristivano maggiormente il mio animo. Forse guardavo alla mia terra per l’ultima volta. Finalmente, verso le quattro pomeridiane, eccoci a Bolzano. Il convoglio, imboccata la strada di Merano, si fermò a un chilometro da Gries davanti a un grande steccato. Era il campo di concentramento. Si comprendeva subito che non era un campo di fissa dimora, ma di smistamento o passaggio: Durckgangslager, come lo chiamavano i tedeschi. Vi confluivano da ogni parte d’Italia i destinati all’internamento e dopo qualche settimana venivano rispediti ai diversi campi della Germania, Austria, Polonia, ecc. Nei quindici giorni della mia permanenza vidi arrivare numerosi gruppi provenienti dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Toscana e partire per il Brennero, a varie destinazioni. Il campo era piccolo e ancora in formazione. A fianco dell’entrata una modesta casa era sede delle SS. Nell’interno, al lato destro del cortile, vi era un lungo e basso capannone per gli internati; a sinistra un cascinale rustico per servizi di cucina, magazzini, laboratori, ecc. Sul fondo, un edificio in costruzione, destinato a carcere duro. Il tutto racchiuso in un recinto di legno e filo spina to, con torri, pure di legno, per le sentinelle. Il capannone, un ex garage in tutta muratura con soffitto a volta, era diviso in stanzoni con tramezze che giungevano fino all’inizio della volta, lasciando libera la parte superiore. Noto questo particolare perché utile a capire meglio un episodio che racconterò più innanzi. Capo-campo, alle dipendenze delle SS, era un italiano, proveniente dalle camicie nere, egli pure internato. Ci fece discreta impressione per il suo tratto gentile e comprensivo. Anche gli aiutanti erano italiani, ma più duri e talvolta maneschi. Prima di sera ci assegnarono gli stanzoni, distinti da lettera alfabetica sulla porta d’ingresso. Cinque erano occupati da uomini e due da donne e il piazzale era comune agli uni e agli altri, con una semplice separazione di rete metallica. Io venni destinato, con l’amico Miorin e altri di Milano, allo stanzone A. Qui vidi per la prima volta i cosiddetti castelli, grandi scaffali in legno, lungo le pareti, ripartiti in tavolati disposti uno sull’altro alla distanza di mezzo metro, con sacconi di trucioli. Poichè noi, ultimi arrivati, eravamo ignari dei regolamenti disciplinari, per non incorrere facilmente in penalità, ci facemmo istruire dagli anziani, che furono affettuosi e cordiali. Molti di essi ci furono, non solo compagni di sventura, ma anche amici e fratelli. Da essi, in maggior parte provenienti dal campo di Fossoli, potemmo nei giorni segùenti conoscere la storia genuina dei 67 fucilati di quel campo. In verità dovevano essere 70, ma tre di essi erano riusciti a sfuggire alla fucilazione; uno di essi era il giovane avvocato dott. Teresio Olivelli di Mortara, rettore del collegio Ghisleri di Pavia, presente al campo di Bolzano. Fra le altre care conoscenze fatte in quei giorni ricordo il signor Odoardo Focherini di Carpi, amministratore del giornale L’Avvenire d’Italia, il vivace e intel ligente giovane Magenes della Gioventù Cattolica di Pavia, ora professore all’Università di Pisa, l’ottimo Semeria, floricultore di Sanremo, mio inseparabile compagno quasi fino alla morte. Anche a Bolzano potei constatare che tra gli internati, nonostante le divergenze politiche, fede non ne mancava. Come sacerdote e cappuccino io ero rispettato da tutti. La sera, prima del sonno, si recitavono tre Ave Maria alla Madonna, cui tutti rispondevano con vera devozione. Solo una volta un tizio protestò, ma fu subito zittito da tutti gli altri. L’Olivelli poi, che aveva un grande ascendente su tutti, esercitava un vero apostolato, con l’esempio e con la parola. Aveva fra l’altro introdotta una specie di discussione pubblica con calorosi commenti, su alcuni brani evangelici. Al mio arrivo, unico sacerdote, l’incombenza venne passata a me. Una volta, alla mia spiegazione sull’episodio dei dieci lebbrosi, Olivelli mi chiese di poter aggiungere una piccola riflessione, che mi rivelò tutto il suo animo veramente cristiano: «Potremmo», aggiunse, «applicarci l’episodio evangelico. Perché Dio permette la sofferenza? E perché la nostra presente condizione? Il dolore raffina l’anima e la rende più degna di lui, il Martire divino del Golgota». E l’Olivelli fu davvero consumato nel peggiore dei campi, quello di Hersbruck, un martire della fede e della carità. Di questa singolare figura d’internato, della quale tornerò a parlare più avanti, non voglio qui tralasciare un episodio. Io ero forse l’unico a Bolzano che non poteva spendere; possedevo le sole 100 lire donatemi nel momento del mio arresto. Ora, tutti i giorni, al campo venivano dei fruttivendoli e si poteva comprare frutta a volontà. A me spiaceva spendere le 100 lire, pensando che ne avrei avuto ben più bisogno in seguito. Olivelli se ne accorse; e, per non umiliarmi, o forse supponendo che altri si sarebbero potuti trovare nelle mie condizioni, ricorse a uno stratag emma. «Facciamo» disse, «una cooperativa frutticola. Mettiamo insieme una somma da parte di chi ha, per comprare la frutta a chi non ha». E da quel giorno io potei gustare, come gli altri, le belle pere e mele dell’Alto Adige. A Bolzano, oltre ai famosi castelli, vi fu un’altra novità: il triangolo rosso, di cui erano fregiati gli anziani e che poco dopo venne applicato anche a tutti noi. Era un distintivo di tela rossa scarlatta, ritagliato a triangolo e applicato alle giubbe. Il triangolo si presentava con la punta in basso; nella parte superiore aveva una striscia bianca e al centro una grande lettera I, che voleva dire: Italiano. Per gli ebrei il triangolo era giallo e senza lettera. Gli internati che erano stati ripresi dopo una tentata fuga, oltre che dal triangolo, erano distinti da un disco rosso e verde applicato a tergo. La cucitura del triangolo rosso sulla nostra giubba fu fatta dalle signore internate ed ebbe quasi un significato eroico e romantico, ricordando il tempo delle crociate, quando le dame attaccavano sul petto dei cavalieri la croce, animandoli ad essere valorosi e augurando loro la vittoria. A me fu la signora Carla Ucelli che, con la gentilezza di una sorella, fece questo singolare servizio. Eravamo arrivati due sole settimane prima e si parlava già di un nostro prossimo trasferimento. Era, infatti, in preparazione una numerosa spedizione e sembrava ormai certo che noi di Milano saremmo stati inclusi al completo. Fu forse per questo che un giorno mi vidi capitare un addetto delle SS con forbici e rasoi. «Padre,» mi disse, «vengo a tagliarle la barba». «Li conosce lei i Cappuccini? Non si tagliano mai la barba». «Si, li conosco. Al convento di Brunico ero solito assistere alla messa; e, quando posso, tornando a casa mia, non tralascio mai la consueta visitina al caro convento... Mi spiace farle torto, padre; ma ho l’ordine di raderle la barba». Poveretto! Era davvero in imbarazzo. E così un altro colpo alla figura del cappuccino. A Milano mi si era tolta la tonaca, qui la barba. Mi tranquillizzai pensando che, se non è l’abito a fare il monaco, neppure è la barba che fa il cappuccino.
Destinazione ignota
Sebbene si sapesse di essere, a Bolzano, in un campo di smistamento, tuttavia si nutriva la speranza e si facevano voti che la nostra permanenza si protraesse a lungo, salvo il ritorno alla libertà. Non si poteva infatti dire che si stesse male. Le SS si facevano vedere di raro. Il capo-campo, italiano e internato come noi, non aveva il coraggio di maltrattarci. C’era sempre la fame, più che a San Vittore, ma ancora sopportabile. Lavori pesanti non ce ne facevano fare. Potevamo stare tutto il giorno all’aria aperta a goderci il sole e a contemplare il magnifico panorama che la conca di Bolzano ci donava. Ma la voce di una prossima partenza ebbe presto conferma, poichè da diverse parti d’Italia affluivano sempre nuovi internati, più numerosi dalla Toscana. Le camerate erano ormai stipate all’inverosimile e si dovettero occupare anche tutti gli angoli del rustico per collocare in qualche modo i sopravvenuti. Necessariamente le SS dovevano pensare a liberare il campo dai primi arrivati e la decisione non si fece attendere. Il 1° settembre si ebbe ufficialmente l’avviso che la partenza era fissata per il 5. La notizia ci turbò profondamente, poichè la nostra sorte era ormai segnata. Se lasciare San Vittore e Milano fu per noi motivo di angosciosa incertezza e di dolorosa nostalgia, questi sentimenti si rinnovarono più intensi al pensiero di dover lasciare l’Italia e affrontare i campi di concentramento in terra straniera e ostile. Diventammo nervosi e taciturni. Alcuni tentarono la fuga dal campo, ma senza fortuna; altri si industriarono a comunicare la notizia della prossima partenza alle proprie famiglie, e solo qualcun o vi riuscì a mezzo degli operai che lavoravano nelle fabbriche della prigione. Alla vigilia della partenza avvenne un fatto che non dimenticherò mai. Era sera tardi ed eravamo già coricati, quando un certo Paggi, non ricordo bene se di Rapallo o di Chiavari, improvvisamente intonò con voce potente il coro di Verdi: Va pensiero... Il capo-campo lo interruppe subito, avvertendolo che era severissimamente proibito cantare inni patriottici. Un momento di silenzio. Poi un coro di mille e mille voci mirabilmente fuse, di bassi profondi e di soprani acuti, di uomini e donne, dalle camerate comunicanti, come al cenno di una bacchetta invisibile, lentamente ma decisamente, attaccò la nota canzone: La montanara. Il canto era così espressivo, così pieno di sentimento da cavar le lacrime. Era l’addio ai nostri cari, alla patria e, per la maggior parte, l’addio alla vita. Era una velata e viva protesta contro la tirannia che ci aveva tolto la libertà e stava per condurci all’esilio e alla morte La mattina del giorno 5 venne l’ordine di deporre la divisa del campo e indossare i vestiti civili. Io riebbi l’abito di cappuccino, inviatomi dai miei confratelli di Milano, poichè il mio, come ho detto, mi era stato sequestrato a San Vittore. Adunati quindi sul piazzale e divisi in squadre fummo avviati a piedi alla stazione. Era pronto un treno di carri bestiame e ci buttarono a sessanta-sessantacinque per ogni carro, sigillando le porte all’esterno. Nel vagone nessuna panca, nessun sedile e poca paglia distesa sul pavimento; in alto un’unica finestrella ben armata di filo spinato. Si era talmente pigiati che solo una decina a turno poteva accoccolarsi per riposare. Nel mio vagone trovai il colonnello Balconi di Pavia, che aveva lasciato a casa la moglie e quattro figli ancora piccoli. Vi era fra gli altri un nipote di Apelius, il noto annunciatore della radio fascista. Solo dopo tre ore di affannoso arrabattarsi delle SS, perc hé tutto fosse in ordine e specialmente che i vagoni fossero ben sigillati, il fischio annunciò la partenza. Lentamente, sferragliando, il treno imboccò la valle dell’Isarco, stretta e selvaggia fino alla Chiusa; passò a monte di Bressanone, attraversò la stazione di Fortezza e giunse a Vipiteno senza soste; salì quindi sbuffando Colle Isarco e giunse verso le 5 pomeridiane al Brennero. Breve fermata durante la quale ci venne distribuita un po’ d’acqua. Lungo il percorso notammo che il treno era tenuto d’occhio da pattuglie di SS motorizzate, che lo seguivano sulla statale. Continuando la marcia in territorio austriaco, dopo lo Anschluss divenuto germanico, si giunse a Insbruck verso le diciotto. Altra breve sosta e poi si riprese il viaggio per Monaco di Baviera. A Innsbruck, a nostra insaputa, il convoglio era stato dimezzato. Parte dei nostri compagni furono avviati verso Mauthausen e in altri campi dell’Austria. Noi arrivammo a Monaco verso le ventidue. La città era in oscuramento e poco o nulla potemmo vedere anche della stazione. Il treno fu deviato su un binario morto e lasciato fermo. Nessuno pensò a darci da mangiare e neppure da bere un bicchier d’acqua. Sempre chiusi nei nostri vagoni, mezzo soffocati per mancanza d’aria, stanchi morti per aver dovuto stare quasi sempre in piedi, con tutto il resto che è facile immaginare in quelle condizioni, ci disponemmo a passare la notte alla meno peggio. Ma verso mezzanotte eccoti un grosso bombardamento sulla città. A decine gli aerei rombavano sopra di noi e le bombe piovevano da ogni parte. Raccomandai l’anima a Dio, e anche i miei compagni di sventura, credenti o no, fecero altrettanto. Veramente anche lungo il viaggio, quando io proponevo la recita del santo rosario, tutti rispondevano con devozione. A Dio piacque che uscissimo da quel furioso bombardamento incolumi. E soltanto dopo potemmo, per poche ore, riposare . Il mattino seguente il treno si rimise in moto verso la Baviera del nord, lentamente, con molte e lunghe fermate. Viaggio doppiamente noioso e per la fame che ci rodeva e per la stretta clausura in vagone con le inevitabili conseguenze di ordine igienico. Dalla finestrella comprendemmo di trovarci nella valle del Danubio. Si notavano le alpi bavaresi e, a certe svolte del treno, a nord le ultime propaggini dei Sudeti. Attraversammo il Danubio a Regensburg, dove sostammo lungamente. Giungemmo poi a Norimberga, dove finalmente ci fecero scendere dal treno per rinchiuderci alcune ore in apposite prigioni nella stessa stazione. Dopo Norimberga il treno fu avviato su una linea secondaria che porta a Weiden nei Sudeti bavaresi, dove passammo la seconda notte. E il dì seguente giungemmo all’ultima stazione di Flossen. Come si potè sapere dutante il viaggio, eravamo destinati al capo di Flossenburg. Flossenburg vuol dire castello o fortezza di Flossen. Il paese, infatti, giace fra due colline, su una delle quali si vedono le rovine di un castello medioevale. Poco prima di arrivare in paese, davanti a una casetta, due bimbi stavano a guardare la nostra sfilata. Il più piccolo alzò la mano per salutarci alla «romana», ma il più grandicello di scatto gli afferrò il braccio abbassandoglielo: «Nein!», gli gridò, «Sie sind Bandften!». «No, sono banditi». Flossenburg è diviso nettamente in due, benchè le case costituiscano un solo agglomerato. Ha due chiese, due cimiteri e due religioni, cattolica e protestante. Fenomeno che si verifica di frequente nella Baviera del nord. Il campo si trova a circa due chilometri più in alto. La strada, montando, segue i margini di una bellissima conca, tutta prati, salvo qualche campicello di patate. Dopo un’ampia svolta si giunge di fronte al campo. V’è una scritta sull’arco della porta: «Arbeiterlager» «Campo dei lavoratori». Dopo l’esperienza dei primi giorni vi si poteva invece scrivere, e ben a ragione, la nota terzina di Dante: Per me si va nella citta dolente, Per me si va nell’eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente (I, 3, 1). Non si può negare agli ingegneri tedeschi il buon gusto nella scelta dei luoghi e nella costruzione dei diversi campi di concentramento. Penso che Hitler e il suo regime intendessero usarne per secoli. Questi campi infatti erano collocati in amenissime posizioni, serviti da strade di prim’ordine (a Flossenburg, oltre a quella nominata, se ne stava costruendo un’altra grande e comoda come un’autostrada) con servizi di acqua e di luce in piena regola, con grandi caserme per le SS e nelle adiacenze ville deliziose, naturalmente in salda muratura, per gli ufficiali. L’unica parte cadente erano le baracche costruite in legno. Oltre alle accennate prerogative, a differenza degli altri, il campo di Flossenburg, data la sua posizione in mezzo a monti a oltre mille metri, circondato da bellissime pinete, si poteva considerare il campo di concentramento di villeggiatura. Era per intero cinto da un’alta duplice rete di filo spinato, alternata ogni cento metri da torrette per le sentinelle. Lungo il ripiano della sella sorgevano edifici in muratura e diverse baracche adibite ad uffici amministrativi, a officine e servizi pubblici. Poi, più discoste, alcune altre baracche di smistamento, di quarantena e, al termine della sella, il crematorio.
Intermezzo
Venendo una volta santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Angeli con frate Lione a tempo di verno, e il freddo grandissimo fortemente il crucciava, chiamò fra te Lione, il quale andava innanzi, e disse cosi: «O frate Lione, avvegnadiochè li frati minori in ogni terra diano grande esempio di santità e di buona edifìcazione, nientedimeno iscrivi, e nota diligentemente, che non e ivi perfitta letizia». E andando santo Francesco piu oltre, il chiamò la seconda volta: «O frate Lione, benche ’1 fra te minore illumini i ciechi e distenda gli attratti, caccia li demoni, renda l’udire ai sordi, l’andare agli zoppi, il parlare ai muto li, e, ch’è maggior cosa, risusciti i morti di quattro dì scrivi che non e in ciò perfetta letizia». E andando un poco, gridò forte: «O frate Lione, se ’1 fra te minore sapesse tutte le lingue e tutte le scienze e tutte le scritture, sicchè sapesse profetare e rivelare non solamente le cose future, ma eziandio gli segreti delle coscienze e degli animi, scrivi che non e in ciò perfrtta letizia». Andando un poco più oltre, santo Francesco chiamò ancora forte: «O frate Lione, pecorella di Dio, benchè il frate minore parli con lingua d’Angelo e sappia i corsi delle stelle e le virtù delle erbe, efossongli rivelati tutti li tesori della terra, e conoscesse le virtù degli uccelli e de’ pesci e di tutti gli animali e degli uomini e degli albori e delle pietre e delle radici e dell’acque, iscrivi che non e in ciò perfetta letizia». E andando ancora un pezzo, santo Francesco chiamò forte: «O frate Lione, benchè il frate minore sapesse si bene predicare, che convertisse tutti gl’infedeli alla fede di Cristo, scrivi che non e ivi perfettta letizia». E durando questo modo di parlare bene due miglia, fra te Lione con grande ammirazione il domandò e disse: «Padre, io ti priego dalla parte di Dio che tu mi dica dove è perfetta letizia». E santo Francesco sì gli rispose: «Quando noi giugneremo a Santa Maria degli Angeli, così bagnati per lapiova e agghiaccia ti per lo freddo e infangati di loto e afflitti di fame, epicchieremo alla porta dello luogo, e’lportinaio verrà adirato e dirà: «Chi siete voi?» e noi diremo: «Noi siamo due dei vostri frati», e colui dirà: «Voi non dite vero; anzi siete due ribaldi che andate ingannando il mondo e rubando le elemosine de’ poveri; andate via», e non ci aprirà, e faracci istare di fuori alla neve e all’acqua, col freddo e coll a fame, insino alla notte, allora, se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati sosterremo pazientemente senza turbazione e senza mormorare di lui, e penseremo umilmente e caritatevolmente che quello portinaio veramente ci conosca e che Iddio il faccia parlare contra noi, ofrate Lione, scrivi che ivi è perfetta letizia. E se noi perseverremo picchiando, e egli uscirà fuori turbato, e come gaglioffi importuni ci caccerà con villanie e con gotate, dicendo: «Partitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate allo spedale, che qui non mangerete voi, nè albergherete»; se noi questo sosterremo pazientemente e con allegrezza e con buono umore, o frate Lione, scrivi che qui è perfitta letizia. E se noi, pur costretti dalla fame e dal freddo della notte, piu picchieremo e chiameremo e pregheremo per l’a mor di Dio con gran pianto che ci apra e mettaci pur dentro; e quelli piu scandalizzato dirà: «Costoro sono gaglioffi importuni; io gli pagherò bene come sono degni»; e uscirà fuori con uno bastone nocchieruto, e piglieracci per lo cappuccio egitteracci in terra e involgeracci nella neve e batteracci a nodo a nodo con quello bastone; se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali noi dobbiamo sostenere per lo suo amore; o frate Lione, scrivi che in questo è perfetta letizia».
***
Cari miei lettori, vi meraviglierete di veder qui riportato il Fioretto della Perfitta Letizia del Poverello d’Assisi. Bello, direte voi in cuor vostro, meraviglioso; ma che c’entra qui? Eppure c’entra. Prima per me. Giunto ormai con questi miei ricordi all’ingresso nel campo di Flossenburg, dove realmente incomincia la mia odissea e quella dei miei compagni, prima di inoltrarmi nel racconto ho bisogno di rileggere quel sublime piccolo capolavoro di bontà, di pazienza, di eroica sopportazione, di amor di Dio e de l prossimo, tanto più mirabile in quanto sappiano che per S. Francesco fu vita vissuta. Non vorrei infatti che, rievocando uomini e cose, tormenti e tormentatori dei campi di concentramento, perdessi la serenità e l’obiettività necessarie. E’ facile che un risvegliato risentimento per quello che si è patito o visto patire ne faccia esagerare il racconto, caricando le tinte e oltrapassando i limiti del vero. Purtroppo, anche stando alla sola verità, dovrò dire cose penose e umilianti per la civiltà moderna, ed inumane per tutti i tempi. Meglio sarebbe non rievocare, lasciando tutto nel silenzio dei campi stessi. Ma mi sono chiesto: Sarebbe giusto? Anche mons. Johann Neuhàusler, vescovo ausiliare di Monaco, a proposito di Dachau, dove restò prigioniero per ben quattro anni, si è posta questa domanda; ed ha risposto che sarebbe «commettere una nuova ingiustizia contro le vittime dei Lager, la cui ultima parola fu: Ditelo a tutti ciò che hanno fatto di noi!» Sarebbe anche un danneggiare noi stessi, continua monsignore, in quanto ci rifiuteremmo di apprendere i tremendi insegnamenti che escono dall’immane tragedia e ci esporremmo, così, al pericolo di accettare il rinnovarsi di essa in futuro. Se è doveroso rinunciare all’odio e respingere lo spirito di vendetta, se bisogna perdonare - per umana e cristiana carità - a tutti coloro che ci hanno fatto soffrire, non è meno doveroso tener vivo il senso di responsabilità che tutti abbiamo e la visione delle cause che hanno portato a quegli orrori. Per questo scrivo. Del resto, accanto all’ombra vi è sempre la luce. Si può tacere dei tiranni e degli aguzzini, ma è doveroso parlare dell’eroismo delle loro vittime. Per questo scrivo. Moltissimi di essi sono morti, molti altri sono tornati disfatti, pochi ancora in forze o ricuperabili. La fame, il lavoro forzato, i maltrattamenti d’ogni genere, le camere a gas, la fucilazione, hanno seminato stragi spaventose. Quanto si racconta dei campi politici o di eliminazione è sempre al disotto della realtà. Le cose più abbiette, più degradanti e ripugnanti non si possono dire. Solo chi le ha sofferte le ricorda con orrore. Non è dunque per infierire contro gli autori di simili brutalità e crudeltà che rievochiamo la nostra vita nei campi di eliminazione, ma per un doveroso omaggio alle vittime. Motivo ancor più importante. Si è soliti gravare la responsabilità di quanto avvenne in quei campi sul popolo tedesco o sulla Germania in genere. Anche questo non è giusto. La Germania e il suo popolo furono essi stessi vittime di una cricca di violenti razzisti formatisi alla scuola delle dottrine materialiste comuni a quei tempi in tutta Europa e purtroppo ancora imperanti oggigiorno in gran parte di essa. Nazismo e comunismo sono frutti di uno stesso albero. A questa conclusione portò una discussione che ebbi con un autentico comunista intellettuale e che riferirò più avanti. Sarebbe interessante però trattare a fondo questo argomento, perché se è vero che la storia è maestra della vita, dalle sue pagine più brutte se ne dovrebbe cavare lezione per l’avvenire. Non inutilmente S. Paolo dice che l’uomo raccoglie ciò che ha seminato. Se ciò vale in ordine all’individuo per l’eternità, non è meno reale per i popoli e le nazioni nel tempo. E giacché siamo in vena di filosofia della storia, dirò che, dopo tutto, anche i campi di concentramento hanno portato qualche bene: molti internati vi hanno trovato la fede perduta. Messi a tu per tu col dolore e la morte, ritornarono a Dio. Fui testimone di molti casi di conversioni che non sarebbero avvenute senza il passaggio attraverso l’inferno dei campi. Un altro vantaggio fu quello di essersi trovati nello stesso campo cittadini di tutta l’Europa. Dalla comune sorte nel dolore è sorta una fraternità intima tra tutti gli internati europei, ben più efficace al la preparazione dell’Europa Unita che non tutte le arti delle diplomazia. La Provvidenza divina, nel permettere il male, ha sempre di mira di cavarne un bene. Il male è passeggero, il bene è più grande e duraturo.
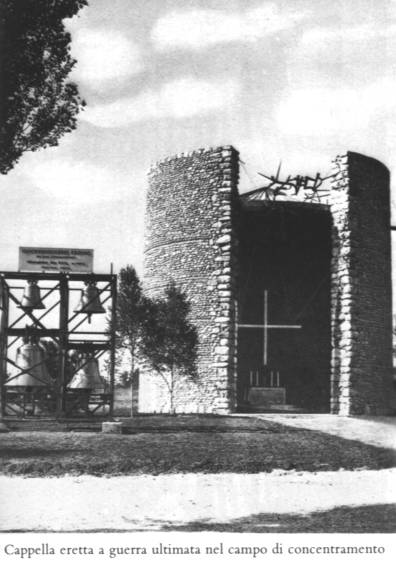
Le prime «delizie» a Flossenburg
Erano forse le ore 9, o poco più, di quell’8 settembre, quando ci trovammo tutti oltre la porta d’ingresso. Il lungo viaggio, nelle condizioni dette, e soprattutto la fame e la sete ci avevano fiaccati all’estremo. Unico nostro desiderio era di mangiare e bere qualcosa e di riposare un poco. Perciò fu spontanea e comune l’esclamazione: «Finalmente siamo arrivati!». Grazie, a quel «finalmente...». Invece di portarci in baracca o lasciarci anche solo sdraiare per terra, dandoci un pezzo di pane e un bicchiere d’acqua, iniziarono le operazioni per l’aggregazione al nuovo campo. Prima operazione: schieramento sull’attenti davanti alla palazzina del comando delle SS. Le SS di Bolzano, che ci avevano accompagnati lungo il viaggio senza incidenti, cioè senza che nessuno fosse loro sfuggito, soddisfatte della compiuta missione, ci consegnarono alle SS locali, che ci sottoposero all’appello nominale, controllo scrupoloso ad uno ad uno, registrazione, ecc... e noi là, in piedi, diritti, due o tre ore in attesa. Seconda operazione: marcia verso il centro del campo e raduno sotto un vasto capannone ricoperto di tende sgargianti. Qui, ordine di spogliarsi e di consegnare i vestiti ad appositi incaricati, che provvidero anche al sequestro di qualsiasi pacco e particolarmente degli oggetti di valore, come denaro, orologi e anelli. Io avevo solamente l’abito religioso. Terza operazione: sfilata attraverso la piazza in veste da paradiso terrestre, per il bagno. Benche si fosse solo ai primi di settembre, data l’altitudine di oltre 1000 metri sul mare, al di là delle Alpi, faceva freddo assai; ma un bagno ci sorrideva. Al bagno, grande sorpresa. Fummo accolti con carezze di bastoni. Otto o dieci incaricati, all’ingresso, o per sollecitarci o per metterci a posto o per nessun motivo, davano a casaccio botte da orbi, che sulla nuda pelle si sentivano di più e lasciavano il segno. Come non ricordare la terzina dantesca: «Caron dimonio, con occhi di bragia... batte col remo qualunque s’adagia» (I, 3,109)? Quarta operazione: ritorno, nelle stesse condizioni di nudità e grondanti acqua, al capannone di prima. Troviamo nuovi vestiti da indossare: una camicia sbrindellata, un paio di mutande vecchie e sdrucite, giacca e calzoni borghesi già indossati da chissà quanti altri deceduti nel campo, e finalmente un paio di zoccoli di legno, tutta roba buttata lì a caso, senza riguardo a misura. Tutti uguali; tutti «barboni» allo stesso modo, direbbero a Milano, anzi peggio; perché, a nostro confronto, i cosiddetti «barboni» (i mendicanti) sarebbero sembrati gran signori. E pensare che tra noi vi erano uomini che a casa loro vestivano in perfetto stile inglese, o la brillante divisa di ufficiale! Era un avvilimento peggiore delle bastonate. Dopo queste operazioni che durarono fino a sera, ci avviarono finalmente alla baracca destinataci. Questa era situata in fondo al campo, nella immediata vicinanza del crematorio e portava il numero 23. Di fianco, alla distanza di pochi metri, vi era la baracca 22. Oltre questa, più staccato e sul lato destro, un edificio in tutta muratura, conteneva i servizi igienici. Una rete metallica recingeva le tre costruzioni e lo spiazzo antistante. Gli ospiti delle due baracche, benché non separati da alcun ost acolo, non potevano liberamente comunicare tra loro e solo alcuni, di sotterfugio, a volte riuscivano a mescolarsi con quelli della baracca vicina a conversare con conoscenti ed amici. Ambedue le baracche servivano di quarantena per i nuovi arrivati, ma la 22 accoglieva di preferenza i più ammalati e voleva essere una specie di infermeria, senza però nè medico nè medicine. L’infermeria vera e propria era un’altra, come vedremo, dalla quale uscivano guariti solo i morti. Come tutte le altre baracche di Flossenburg e come quelle di tutti gli altri campi, anche le nostre due baracche (dovrei usare la parola «blocco», dal tedesco, ma «baracca» è il nostro nome) erano internazionali. In esse si mescolavano prigionieri provenienti da tutte le parti d’Europa; vi erano perfino mongoli, egiziani ed altri, catturati dai tedeschi nelle terre occupate o soldati degli eserciti nemici. Non mancavano neppure gli internati politici della stessa Germania e dell’Austria. Prima del nostro arrivo, a Flossenburg di italiani ce n’erano pochi; la maggior parte di essi venivano di solito inviati a Mauthausen o a Dachau o addirittura ai campi della lontana Polonia. Al nostro arrivo sulla piazzetta antistante la baracca 23, ci sentimmo rivolgere l’esclamazione: «Poveri italiani! Dove siete mai arrivati!» Era un toscano, ormai anziano del campo. Più tardi ne feci la conoscenza personale, ma per poco tempo, perché dovetti partire da Flossenburg. Lo lasciai ridotto a un soffio di vita. Il capo della baracca 23 appena ci ebbe in consegna, ci mise sull’attenti e ci tenne un discorsetto in tedesco, nel quale almeno una decina di volte ricorsero le parole «morte», «fucilazione». Morte a chi non ubbidisce, morte a chi tenta fuggire; fucilazione a chi si ribella «alle legnate»; crematorio a chi ruba (un pezzo di pane); e via di questo passo... Non avendo la maggior parte capito nulla di quel linguaggio - il capo doveva essere un pessimo soggetto, rabbioso c ome un cane, feroce come una tigre (e lo vedrete ai fatti) - si alzò il nostro bravo Olivelli a tradurre quella sfilata di minacce cercando di addolcirle per non scoraggiare ancor più i già avviliti ascoltatori. «Italiani» - egli aggiunse in tono commosso e insieme risoluto - «stiamo disciplinati e pazienti per non dar ad incrudelire contro di noi non mostriamoci vili, pretesto siamo orgogliosi e fieri di essere italiani e cristiani, capaci di soffrire con dignità». Da quel momento Olivelli, per tutto il tempo che rimase con noi a Flossenburg, fu il nostro interprete ufficiale, fu il nostro rappresentante capo, l’idolo di tutti. Egli prese un tale ascendente sugli stessi tedeschi dirigenti, che questi lo rispettavano e lo temevano. A sera ormai avanzata ottenemmo finalmente una fetta di pane, la solita razione che si dava per cena nel campo. Per dissetarci non c’era che l’acqua dei lavabo igienici del gabinetto, che però era corrente e buona. Così stava per chiudersi la giornata dell’8 settembre 1944; ma prima di poter riposare in pace fu un problema trovarsi un posto. La baracca era al completo già prima del nostro arrivo. Noi eravamo parecchie centinaia. I tavolati e i castelli erano già tutti occupati e chi aveva posto, certo non lo lasciava. Dormire all’addiaccio sulla piazzetta era assolutamente impossibile, non tanto per il freddo quanto per le misure di sicurezza: c’era sempre da temere che le SS di guardia infierissero contro di noi. Il capo-baracca però trovò subito una soluzione: su ogni tavolo di due posti ordinò che vi dormissero in sei, tre a capo e tre ai piedi. Si può immaginare come si stesse bene, tanto più che il tavolato era diviso per metà da una traversa, così che, chi era nel mezzo n’aveva tagliata la schiena. Fortunatamente nel posto assegnatomi eravamo solo in quattro, forse per rispetto al grado dei miei compagni, forse per l’età, essendo tutti e quattro fra i più vecchi. Mi trovai a dorm ire, infatti, con due generali del nostro esercito e con un ingegnere. Uno era il generale Armellini, già comandante dell’armata, l’altro il generale Mùller, comandante del presidio di Aosta; l’ingegnere si chiamava Bavasco e, se non sbaglio, era un italo-egiziano. Ci adagiammo alla meglio. Non conoscendo ancora di che idea fossero i miei compagni diletto, prima di chiudere gli occhi, incominciai a mormorare sommessamente le preghiere della sera. Il generale Armellini, accortosi, mi disse: «Padre, preghiamo insieme». Gli altri due si unirono a noi. Ciò mi fece piacere. Ero dunque con tre bravi cristiani, tanto più ammirevoli quanto più distinti per condizione sociale. Quella prima notte però, nonostante la stanchezza, dormii assai poco, turbato da incubi. Ancora sveglio riandavo col pensiero alle diverse tappe della mia odissea: l’arresto in duomo, la prigionia a San Vittore, l’internamento a Bolzano, il viaggio in carro bestiame da Bolzano a Flossenburg e la presente condizione nel campo. In sogno, mi pareva di rivivere or l’uno or l’altro di tali episodi, e mi svegliavo di soprassalto, lieto di ritrovarmi a riposare con amici, ma il letto duro mi richiamava subito alla realtà, peggiore del sogno. Naturalmente la mia tristezza aumentava al pensiero della cattiva condizione di tanti altri disgraziati compagni, per molti dei quali non sapevo quale sorte fosse capitata dopo la nostra separazione avvenuta a Innsbruck. Mi scosse da tale stato agitato e depresso l’ordine secco di levata, che risuonò nella baracca verso le quattro del mattino: Aufitehen! Il grido, ripetuto dai satelliti del capo-baracca, con mia sorpresa era accompagnato da solenni bastonate sulla schiena di chiunque esitasse un momento a balzare a terra. Infilati in fretta e furia calzoni e giacca, fummo buttati sulla piazzetta e messi sull’attenti, in attesa della distribuzione del thè (per modo di dire), bibita nerastra fatta con foglie di ch issà quale albero. Però la prendemmo volentieri perché era almeno tiepida. Questa era la nostra colazione del mattino. Verso le sei vi fu l’appello. Disposti a dieci per dieci, mescolati con gli stranieri, si formavano quadrati di cento con perfetto ordine in modo che le SS venendo a controllarci, in un colpo d’occhio potevano misurarci ed accorgersi se qualcuno mancava. L’appello durò circa un’ora e tutto fu trovato in ordine. Durante il resto della giornata non fummo gran che disturbati. Si osservava ciò che accadeva intorno a noi, quello che facevano gli anziani del campo, si commentava la nostra situazione. Il gruppo che a Bolzano si ridunava in giorno di festa per sentire la spiegazione del Vangelo (fra questi Olivelli, Focherini, Miorin e parecchi altri) decise di recitare tutti i giorni il santo rosario. Più ancora che a Bolzano, dove si era divisi in diverse camerate, qui, raccolti tutti nella stessa baracca e in mezzo agli stranieri, crebbe fra noi la solidarietà e l’intimità fraterna. Passeggiando su e giù per la piazzetta, un bel tipo di milanese, un certo Bonfanti, colpito alla vista del crematorio che fumava abbondantemente ed emanava un odore nauseante di cadavere, esclamo: «Fieu, te là ’n due ’ndrem a finì». «Non fare l’uccello del malaugurio, Bonfanti!», gli risposi io; ma dentro di me sentivo che per molti di noi sarebbe stata veramente quella la fine.

Nell’ingranaggio della morte
Tutto nel campo di Flossenburg era disposto in modo da farci finire al crematorio. Come in certe macchine delle grandi macellerie d’America e d’Europa si mettono le bestie vive e, attraverso lame, imbuti, cilindri, grattuge e altro, le povere bestie escono insaccate, per lo smercio: così i campi di eliminazione, e particolarmente quello di Flossenburg, accogliendo entro la loro cinta gli internati sani e robusti, in poche settimane li riducevano al nulla, a un pugno di cenere, da buttarsi sui campi come concime. Lo spettacolo quotidiano che a noi si presentava era scoraggiante. Nella sola nostra baracca si avevano ogni mattina dagli otto ai dieci morti. Più numerosi nella baracca vicina al n. 22. Non parliamo della cosiddetta Revier (infermeria) che, anzichè per guarirli, pareva fatta apposta per far morire i suoi ammalati. Così proporzionatamente ogni baracca dava il suo contributo. Era l’ingranaggio della gran macchina, che afferrava le vittime e portava a termine la loro distruzione. I morti della notte venivano spogliati e buttati in un angolo della baracca; poi, al mattino, portati al gabinetto, dove già si trovavano nel medesimo stato quelli del giorno prima e, tutti insieme, nudi scheletriti, ammassati come tronchi di legno, attendevano i barellieri che li portassero al crematorio. Ogni giorno verso le dieci, il corteo funebre, girando di baracca in baracca per la raccolta, si stendeva in lunga fila di barelle cariche di due o tre cadaveri ciascuna e si avviava al crematorio. I morti ordinariamente salivano a duecento-duecentocinquanta al giorno. Mi si è chiesto se fossero bruciati anche dei vivi. Non posso affermarlo, ma nemmeno negarlo. Certo vidi qualche volta coi miei occhi tra i morti alcuno che si moveva come fosse vivo. il maggiore Pesapane, che teneva il registro dei morti, non solo ne vide qualcuno muoversi ancora, ma anche lamentarsi con lui di trovarsi fra i cadaveri, destinato al crematorio. Spettacolo pietoso era quello dei moribondi durante la giornata. Con una crudeltà inconcepibile dovevano essere portati fuori dalla baracca al mattino per assiste re all’appello e poi rimanervi tutto il giorno al freddo per essere presenti all’appello della sera. Naturalmente noi compagni non potevamo dare loro alcuna assistenza, se non di sfuggita. Io, come sacerdote, mi accostavo di frequente per dir loro una buona parola e dare l’assoluzione. Generalmente erano forestieri e soprattutto polacchi, quindi cattolici che, sentendo che io ero sacerdote, facevano sorrisi di gioia e cenni di assentimento. Qualcuno domanderà: «Come mai tanti morti?». La fame, sempre la fame, ecco la causa principale. La fame che distruggeva rapidamente l’organismo, minava le forze vitali e apriva la porta a tutte le malattie. Fra queste la peggiore era la dissenteria. Ciò che per noi, nello stato normale di salute, è un semplice disturbo, facilmente guaribile in pochi giorni, nei corpi già sfiniti dalla fame dei poveri internati era una malattia mortale. Pochi si salvavano da essa. In otto o dieci giorni, o al massimo dodici o tredici, mandava la sua vittima al Creatore. Essa inoltre, come ognuno comprende, riduceva l’ammalato ad uno stato miserando, in un sudiciume nauseante per sè e per gli altri. A questo proposito ricordo un italiano di Gorizia, giunto a Flossenburg qualche mese prima di noi, ormai preda alla dissenteria e giacente, quasi moribondo, sulla piazzetta, appoggiato alla parete della baracca. Io mi accostai per confortarlo e gli diedi l’assoluzione. Con me si unì subito un gruppo dei nostri con a capo Olivelli, i quali, in un batter d’occhio, quasi senza che alcuno se ne accorgesse, lo spogliarono, lo pulirono e, di nascosto, poterono cambiargli la biancheria. Egli diede un’occhiata espressiva a tutti, mostrando una gioia infinita e poi disse questa semplice frase: «Sangue mio!». Poco dopo spirò. Come desidererei ricordare il suo nome e portare alla sua famiglia - era padre di sei figli - l’espressione di quello sguardo e il suono di quelle ultime parole! Oltre la dissenteria molt e vittime faceva anche la nefrite. Ad un certo momento uno, anzichè dimagrire, ingrassava e diventava paffuto in faccia. Non c’era da rallegrarsene. Era tutto gonfiore. La fame e la mancanza di vitamine nel cibo scarso e di pessima qualità producevano quel fenomeno. Il processo della malattia era più lento, ma assai difficile a guarire. Non potendosi fare alcuna cura né cambiar dieta, bisognava affidarsi completamente alla Provvidenza di Dio. Il lavoro pesante e forzato era terribile alleato di tutte le malattie. Come si può lavorare, e lavorare sotto la sferza, con lo stomaco vuoto e le forze consumate? Alla baracca n. 23 non si facevano, è vero, grandi fatiche; ma, più tardi, in altre baracche ci costringevano a lavori pesantissimi, che appena i manovali e i facchini ben nutriti possono fare. Vi era però, almeno in apparenza, un certo criterio di scelta nel designare uno a un lavoro piuttosto che a un altro. Un medico delle SS, dopo il bagno, visitava accuratamente, uno per uno, i prescelti e, secondo i risultati della visita, imprimeva sulla fronte di ciascuno,in rosso, il numero uno o due o tre, che volevano dire: atto perlavori leggeri, per lavori ordinari, per lavori pesanti. In pratica i capi-baracca o il capo-campo, non tenevano alcun conto di quei segni, invertendo spesso il loro significato. Non parlo poi, infine, della causa incontrollata e incontrollabile di morte, cioè l’arbitrio del capo-baracca, l’intervento diretto delle SS, gli esperimenti da cavia degli stessi medici. Per lo più questi casi a noi sfùggivano; ma certi decessi di compagni ancora in discreta salute, e morti da un giorno all’altro senza un apparente motivo, non potevano spiegarsi diversamente. Presto o tardi però si veniva a sapere anche ciò che dai capi si cercava di tenere nascosto. Del resto, quanto sto per dire nelle prossime pagine, specialmente sui Transport e del campo di Dachau, mostrerà fino all’evidenza co me si era presi inesorabilmente nell’ingranaggio della morte.
Il capo-baracca 23
La principale responsabilità del crudele trattamento agli internati nei campi di eliminazione tedeschi era certamente delle autorità centrali della grande Germania e particolarmente di Himmler, capo della polizia, uno dei più tristi e spietati figuri del nazismo. Ma anche i dirigenti locali di ciascun campo e in special modo i capi-baracca ne avevano la loro parte. Questi, spesso, eseguendo quanto era stabilito dal regolamento o da ordini superiori, vi mettevano uno zelo così feroce, una cattiveria così crudele, da aggravere all’eccesso la condizione dei poveri internati. Non era la solita rigidità tedesca per la disciplina, ma un sadico gusto di tormentare. I capi-baracca venivano scelti quasi sempre tra i delinquenti comuni e la maggior parte erano autentici ergastolani. Si può quindi immaginare quale bontà d’animo potessero dimostrare. D’altra parte del loro modo d’agire verso i propri soggetti non dovevano rendere conto a nessuno. Il controllo quotidiano delle SS riguardava soltanto i vivi e non i morti. Che questi fossero deceduti per malattia naturale o fatti morire per fame o bastonate, non importava alle SS. Bastava che apparissero nell’eleneco dei morti e la loro partita era chiusa. Né si poteva reclamare per nessun motivo contro il capo-baracca; sarebbero stati guai. Colui che da me e dai miei compagni non sarà dimenticato precisamente il capo-baracca del 23. Ho accennato alle sue prime accoglienze e al discorsetto pieno di minacce del primo giorno. Purtroppo in seguito non si smentì. Proveniva anche lui dall’ergastolo, ma non si sapeva per qual delitto vi fosse stato condannato. La voce più comune era per un assassinio passionale; certo anche nel campo la sua moralità era molto dubbia, particolarmente verso i giovani. Tra questi sceglieva i suoi aiuta nti, che in breve tempo trasformava in altrettanti tirannelli. La sua pazzesca frenesia di ergastolano si può conoscere da alcuni episodi. Una notte, come al solito, tutti più o meno si dormiva e regnava un profondo silenzio; quando a un tratto (saranno state le due) ci scosse un grido rabbioso: «Aufrtehen!». Simultaneamente ecco in mezzo alla baracca agitarsi un gruppo di ragazzotti, gli aiutanti di campo, e con bastoni picchiare di santa ragione quanti giacevano sui tavolati. Credevamo che fosse mattino e tutti balzammo dal nostro giaciglio e uscimmo all’aperto, vestiti in qualche modo. Quando ci accorgemmo dell’ora, ci si domandava che cosa stesse per accadere. Nulla. Mezz’ora dopo venne l’ordine di tornare a dormire. Un’altra volta eravamo adunati sulla piazzetta della baracca in attesa del solito appello. Dopo tre ore che si era sull’attenti un giovane iugoslavo si allontanò un momento dalle file, per una piccola necessità. Al suo ritorno il nostro capo-baracca lo investì come un forsennato e gli diede tante bastonate sulla testa che lo lasciò morto per terra col cranio fracassato. Noi sentimmo un fremito di indignazione, ma era inutile muoversi o protestare. L’assassino, come se nulla fosse, si rimise davanti a noi ad attendere l’appello. Ma un caso che toccò più da vicino noi italiani accadde alcuni giorni più tardi. La fame, che diventava sempre più nera, ci costringeva a cercare qualche cosa da mangiare. Quei pochi che lavoravano in cucina trovavano nelle spazzature ora una radice di rapa, ora una foglia di cavolo mezza secca e mezza marcia, ora una radice di carota o qualche verdura d’altro genere buttata tra i rifiuti. Tutti gli altri cercavano invano anche un solo filo d’erba. Ma un giorno il general Mùller che, come dissi, dormiva con me, ebbe da uno degli aiutanti del capo-baracca, un polacco, quattro piccolissime patate. Nella speranza di poterle cuocere alla stufa (la quale però a rdeva durante il giorno quando noi eravamo fuori baracca, a solo beneficio del capo e dei suoi satelliti) nascose le patatine sotto il saccone del tavolato. Non erano passate che poche ore quando il capo-baracca, frugando a colpo sicuro nel nascondiglio, scoprì le quattro patate, mandando un grido di soddisfazione. Poi chiamò il generale e tenendo in una mano il corpo del delitto e nell’altra stringendo il bastone, incominciò a tempestarlo di legnate finchè fu stanco. Non lo ammazzò di colpo, ma le ferite alla testa furono così gravi che dopo alcuni giorni il generale morì. L’impressione lasciata in noi italiani fu profonda e umiliante. Per così poco si ammazzava un uomo? Così si trattava un generale del nostro esercito? Un sordo mormorio di indignazione si diffuse tra i nostri e qualcuno si lasciò scappare la frase: «Assassino, verrà il tempo che ti ripagheremo!». La minaccia giunse alle orecchie del capo-baracca, il quale, al prossimo appello, la riferì alla SS, naturalmente senza dire il fatto che l’aveva causata. La SS, che non era delle più cattive, commentò semplicemente: «Le mitragliatrici ci saranno anche per gli italiani». Il povero generale Mùller era già il quarto dei nostri morti in sole tre settimane dal nostro arrivo a Flossenburg. Il primo era stato un certo Suardi di Novara, che morì, si può dire, di morte naturale. A Bolzano, dove dormiva al mio fianco, accusava qualche disturbo. Morì ancora giovane, accompagnato dal compianto di tutti; però il suo decesso non sorprese, date le sofferenze del viaggio e tutto ciò che patì al campo. secondo, un certo Insuardi, piemontese di Cuneo, ultrasessantenne, deportato assieme a un fratello, morì quasi improvvisamente per attacco cardiaco. E il terzo a morire fu suo fratello che, sorpreso nella tristezza dal capo-baracca, fu da questi buttato con uno spintone dai gradini dell’entrata nella baracca; cadde battendo la testa sull’ultimo scalino e vi restò. Anche il d olore più sacro era per il pazzo ergastolano un motivo di incrudelire. Un odio speciale egli nutriva per i giudici. Con noi, da Milano, era venuto un certo Urru, nativo sardo, giudice al tribunale di Busto Arsizio. Era giovane, ma già maturo e di sicuro avvenire per la sua intelligenza e prudenza. Quando il capo-baracca lo scoprì gli giurò una persecuzione spietata e certamente la causa principale della sua morte furono i maltrattamenti inflittigli nella baracca n. 23. Qualche volta sembrava che il pazzoide gustasse a tormentarci come il gatto fa con i topi. Già parlai della fame che ci consumava e della spasimante attesa di poter mettere qualche cosa nello stomaco. A mezzogiorno specialmente non si vedeva l’ora che arrivasse il misero rancio, cioè la mezza gamella i crauti rancidi, alla tedesca, per rompere il digiuno che continuava dal giorno prima. Un giorno, mentre si era distribuito in ritardo il rancio e si stava sparsi qua e là sulla piazzetta a consumarlo, ecco il capo-baracca sguinzagliare i suoi satelliti armati di bastone con l’ordine di impedire a tutti la continuazione del misero pasto. Sotto i colpi di bastone cominciò così una tragica e insieme comica danza con le gamelle in mano per più di un quarto d’ora. Si può immaginare come noi stessimo al gioco. Al mio ritorno da Zwickau, ripassando da Flossenburg e alloggiando ancora alla baracca n. 23, lo rividi e mi si mostrò benevolo. Fra l’altro mi parlò un giovane italiano, ricoverato in infermeria, e nelle sue parole mi parve di avvertire una certa commozione. Forse in fondo al cuore qualche senso di umanità poteva averlo ancora; forse un qualche rimorso di quando in quando lo tormentava. Chi può giudicare? Il Vangelo dice che Dio non spegnerà il lucignolo fumigante. Fece però una brutta fine. Rimasto a Flossenburg fino alla venuta degli americani, nelle poche ore di interregno in cui gli internati rimasero liberi, un rus so gli si avventò addosso e lo uccise con trentasette coltellate. Così mi è stato riferito da uno che fu presente al fatto. Io disapprovai la vendetta personale e fui contento che gli italiani fossero rimasti estranei, nonostante le minacce da essi fatte alla vista delle sadiche crudeltà di quel disgraziato. Una riflessione si deve fare, che cioè «chi di spada ferisce, di spada perisce», come dice il Vangelo, e che «non bisogna far male se non si vuol riceverne», secondo il detto popolare. Purtroppo il capo-baracca del n. 23 non fu il solo né in Flossenburg né in cento altri campi della Germania, anche se per me fu il più tipico di quanti ne conobbi; ma ciò dimostra la premeditata e intenzionale organizzazione dei campi di concentramento disposta dal governo nazista, di cui questi ergastolani pazzi erano i degni rappresentanti.
Chi non mangia... lavori!
Ai primi di ottobre, ossia circa un mese da che eravamo nella baracca 23, il nostro gruppo di italiani, venuto da Milano e da Bolzano, al quale si erano aggiunti nel frattempo molti veneti e triestini, fu quasi completamente disgregato e disperso. Parecchi vennero distribuiti fra le diverse baracche dello stesso campo; la maggior parte furono mandati in altri concentramenti, specialmente a Hersbruck e a Kempten. Fra quelli che dovettero ripartire vi furono, con mio grande dispiacere, Olivelli e Miorin, ormai carissimi amici. Io fui tra i rimasti, ma venni traslocato alla baracca 17 e fu come andare lontano mille miglia, perché non ci si poteva incontrare con i vecchi amici né vedere se non per caso e da lontano durante l’adunata per l’appello generale. Con me nella nuova baracca vennero pochi compagni e cioè il generale Barbò, il maggiore Pesapane, un certo Dante Graziani e il triestino Giovanni Bidoli con alcuni altri di cui non ricordo il nome. Il generale Candido Armellini fu destinato alla baracca numero 1, sede degli uffici della direzione del campo. Molti altri, specialmente meccanici, vennero aggregati alla fabbrica dei famosi aerei Messerschmid, nascosta in una galleria adiacente al campo. La nuova baracca n. 17 era alquanto più in grazia di quella n. 23, più ordinati i servizi e meno ingombranti i castelli del dormitorio. Pero, per molti giorni, noi sopravvenuti dovemmo dormire per terra nella cosiddetta Stube, ossia lo spazio interno della baracca, dove avremmo dovuto trascorrere il tempo libero della giornata, ma che in realtà non potevamo usare. Accanto vi era la cosiddetta Revier o infermeria propriamente detta, dalla quale ogni giorno uscivano numerosi morti destinati al crematorio. Proprio in quel tempo vi venne ricoverato il nostro compagno De Giovannini Giuseppe, di Stresa, arrestato, come già dissi, e tradotto a Flossenburg con il figlio diciottenne. Tentai subito di avvicinarlo, ma non mi fu permesso. Morì poco dopo e fu portato al crematorio senza che io lo potessi vedere. Era però un buon cristiano e già a San Vittore si era confessato e comunicato, come pure suo figlio. Nel campo di Flossenburg padre e figlio erano stati separati, e, senza che il primo nulla sapesse, il figlio venne incluso poco dopo in un Transport e spedito non so dove. Neppure lui tornò a casa. Dopo la liberazione mi diedi premura di rintracciare la famiglia a Stresa e vi trovai un giovanotto e tre signorine che ancora aspettavano il padre e il fratello... Mi parve, all’inizio, che il nuovo capo-baracca fosse più umano dell’altro. Realmente non era così manesco, però aveva un cuore duro e insensbile, come il suo collega, nel farci soffrire la fame e il freddo, e assegnandoci ai lavori più pesanti. In modo particolare mostrava sincera antipatia verso di me personalmente avendo saputo che ero frate cappuccino. Se c’era una spedizione di lavoratori per fatiche pesanti, inf allibilmente io ero scelto per il primo, benchè fossi tra i più anziani, ed era ormai proverbiale, mentre si stava adunati nella piazzetta per la scelta, il suo grido: «Kapuziner; heraus!» «Cappuccino, fuori!». Il lavoro variava ogni giorno. Una volta venni mandato con una ventina d’altri a scaricare vari camions di grossi tubi di cemento. Ci venivano caricati sulle spalle e poi via di corsa fino al magazzino, distante un centinaio di metri. Due guardie dislocate in quel tratto di strada, sferza alla mano, erano pronte a colpire chiunque rallentasse il passo. Altra volta per più giorni, insieme a parecchie migliaia di compagni di tutte le baracche, dovetti fare un lavoro simile, ma più pesante. Si andava cioè a portar sassi per la massicciata di una nuova strada che da una città vicina giungeva fino al campo. I sassi si prendevano ai piedi della collina a ridosso del paese di Flossenburg, sulla quale si vedevano le imponenti rovine del castello medievale, alla distanza di circa mezzo chilometro dalla strada in costruzione. Naturalmente venivamo caricati fino all’impossibile e poi, fiancheggiati dalle SS che tenevano il mitra spianato, come sempre quando si era fuori dal campo, percorrevamo il cammino in lunga fila fino alla strada a scaricarvi la nostra soma. Lo spettacolo richiamava scene degli antichi schiavi. Si tornava al campo affranti dalla fame e dalla fatica. Più tardi fui scelto a un lavoro meno pesante, ma più disgustoso. Si andava ad una baracca fuori del campo a confezionare trecce e funi per gli aeroplani. Nella baracca vi erano accumulati a tonnellate impermeabili razziati dalle SS nei paesi occupati. Bisognava strapparli e farne tante fettucce, che venivano poi intrecciate in un’altra baracca. Ma quegli impermeabili, ammonticchiati così alla rinfusa da parecchio tempo, mandavano un tanfo insopportabile. Inoltre, per il dissesto del tetto della baracca, quando pioveva, ed era di frequente, il pavimento diventava un lago di fango e noi tutto il giorno si stava coi piedi in quel fango e con gli stracci addosso inzuppati. Spesso poi vi era la nota macabra di veder sfiniti dei compagi di lavoro, che morivano come cani in mezzo a quel fradiciume. La maggior parte erano russi, che non sapevano altra lingua che la propria e coi quali perciò non era possibile scambiare una sola parola. Soltanto uno di essi parlava stentatamente il francese, ma era un tipo tanto chiuso e arcigno da far passare ogni tentazione di attaccar con lui discorso. In questa baracca, invece, mi feci buon amico un francese di Parigi, il cui nome mi fu sempre ignoto. Era un giovane sulla trentina, delicato, fine, molto malandato in salute. Mi chiese un giorno di dove fossi e quale professione esercitassi. Rispostogli che ero di Milano e che ero frate cappuccino, egli a sua volta mi confidò di essere di Parigi, impiegato, vivente con una sorella e comunista. «Comunista convinto?» gli chiesi. «Convintissimo, padre; idealista, tanto io che mia sorella. Per la propaganda del comunismo entrambi davamo al partito ogni mese metà del nostro stipendio». «Bene» osservai. «Certamente lei è coerente con le sue convinzioni. Tuttavia non so spiegarmi una cosa: come comunista integrale lei sarà certamente anche materialista». «Si, lo sono in pieno». «Ma un buon materialista, non ammettendo anima spirituale ed immortale, Dio e vita futura, considera gli uomini semplicemente come animali, o meglio brani di materia se-movente. Come mai per questi animali e per questi brani di materia lei trova la forza di sacrificare parte del suo stipendio e arrischiare la vita? In questo non mi pare né logico né coerente. Anch’io ho messo a repentaglio la mia vita per gli altri, ma io considero gli uomini qualcosa di più e di meglio che semplici animali, credo che hanno un’anima spirituale e una propria personalità; per me Dio e la vita futura sono una conso lante realtà, credo nel bene e nel male alla luce della ragione e della fede. Non le pare più logico?» «Ma allora lei agisce per interesse della vita futura!». «Certo, anche per questo. Io mi sento nato per la vita, non per la morte. Sacrificarsi per gli uomini come da voi considerati è semplicemente ridicolo. Né mi dica che sia generosità, amore dei fratelli, umanità eccetera... perché queste parole indicano virtù, che per voi non esistono; e, non credendo nel bene e nel male, ma solamente nell’evoluzione cieca della materia, quei termini sono assolutamente privi di significato». «Padre, le sue argomentazioni mi riescono molto interessanti e avrei vivo desiderio di riprendere il nostro colloquio a guerra finita e in ben diverse circostanze. Ho una sorella sposata e residente a Brindisi. Quando passerò da Milano in viaggio per Brindisi, mi accoglierà?». «Non solo, ma sarò ben lieto di averla ospite nel nostro convento per tutto il tempo che vorrà fermarsi a Milano. Speriamo di sopravvivere entrambi a questo inferno». Il poveretto, ormai consunto dall’etisia, otto giorni dopo era portato al crematorio. Era d’animo buono, e Dio certamente gli avrà usato misericordia.
Conoscenze ed amicizie
Il numero sempre più ridotto degli italiani rimasti alla baracca n. 17, mi diede occasione di stringere sempre maggiore amicizia. Carissimo mi divenne il giovane Dante Graziani di Corte Cerro, in provincia di Novara. Maestro di scuola molto intelligente, poeta e scrittore, aveva un’anima grande e un cuor d’oro. Di carattere serio, religioso e patriota ardente, era stato arrestato come partigiano dell’Ossola. In realtà aveva fatto qualche cosa di più del semplice partigiano, mantenendo i contatti fra i gruppi di montagna e il comando partigiano centrale di Milano, usando allo scopo nella segheria paterna una radio emittente clandestina e compiendo viaggi

frequenti dalla plaga di Omegna alla metropoli lombarda. Egli aveva per me le attenzioni affettuose di un figlio. Sopravvisse all’internamento e ora, sposato, vive tranquillamente a Casale Corte Cerro, presso Omegna. Altro amico fu Giovanni Bidoli di Trieste, egli pure comunista e idealista come il francese di cui ho parlato. Dormivamo sullo stesso tavolato e, stante la comunanza di vita e di pene, imparammo a stimarci e amarci a vicenda. Tipo calmo, paziente, quasi timido, si era legato al comunismo ancora diciassettenne ed ora, che era sulla quarantina, non sembrava meno attaccato al partito e alla sua dottrina, della quale tuttavia non parlava mai se non indotto. Già prima della guerra aveva sofferto per le sue idee: fu mandato dapprima al confino nell’isola di Ventoténe e più tardi dovette fuggire all’estero per evitare pene maggiori. Parlava perfettamente il tedesco, il francese, lo spagnolo. Aveva molto buon cuore ed era generosissimo nell’offrirsi per fare un piacere. Ricordo di aver avuto con lui una discussione sul comunismo fatta una sera che stentavamo ad addormentarci. «Caro Bidoli», gli dissi a bruciapelo, «spiegami questo mistero. E’ vero o no che la Germania prima dell’altra guerra era considerata come la più civile e progredita nazione d’Europa?». «Si è vero», rispose. «E come mai è arrivata a tal punto di barbarie da trattare mezza Europa e particolrmente noi internati in modo così inumano?». «Non saprei spiegarlo». «Eppure la spiegazione c’è ed è semplice», replicai. «Quando un popolo perde ogni fede religiosa ed è tutto imbevuto di materialismo, non ha più freni al suo egoismo, non nutre più scrupoli morali. Come l’assassino, per procurarsi danaro, ammazz a cinicamente un uomo, così un popolo massacra altri popoli col pretesto del suo spazio vitale. La vita degli altri, i diritti degli altri non hanno più alcun valore. La Germania è stata prima invasa dalle dottrine soggettivistiche e idealistiche, che negano Dio e i principi religiosi e morali; poi dal materialismo teorico e pratico. Da Kant a Carlo Max e ad Engels il passo fu breve. E’ vero che queste teorie e dottrine si diffusero in tutta l’Europa e furono attuate prima in Russia, ma altrove non ebbero pratica attuazione, perchè i popoli, fortunatamente, di fronte alle catastrofiche conseguenze reagirono. I tedeschi, o meglio i nazisti, andarono fino in fondo, a costo di rovinarsi. Fu forse per loro una triste disposizione quella del protestantesimo, che, possiamo dire, non era che un comunismo colorato di religione». «Giusto, giusto, padre. Mi pare che sia proprio l’unica spiegazione». «Grazie, caro Bidoli. Ma tu che sei comunista, non pensi che in Russia è avvenuta la stessa cosa e per la stessa ragione? E non pensi che se domani trionfasse il comunismo anche presso altre nazioni, tutto accadrebbe come è accaduto in Russia e sta accadendo in Germania? Il materialismo, che è l’essenza del comunismo, porta dovunque le stesse conseguenze, salvo qualche accidentale variazione per il diverso carattere dei popoli. Ne sei persuaso?». «Non so che dire... E pensi, padre, che io fino a 17 anni fui in un collegio di salesiani». E il poveretto restò per un momento come oppresso dal ricordo. Poi aggiunse: «Posso, quando saremo liberi, venirla a trovare a Milano? Mi piacerebbe riprendere con più pace questi discorsi...». Il mio caro Bidoli però non riuscì più a vedere il suolo della patria. Morì colpito dalla rivolverata di un nazista pochi giorni prima della liberazione durante un Transpor. Meno intimità ebbi col generale Barbò, sia per il grado che lo teneva un po’ in distanza, sia per il suo carattere dignitoso e mol to riservato. Conservo però un grato ricordo della gentilezza e della particolare deferenza che mi usava. Aveva tutta la stoffa di un condottiero: risoluto, forte, fiero. M’immagino che soffrisse moltissimo, non tanto per le provazioni e i maltrattamenti, quanto per vedersi ridotto all’impotenza e sottoposto agli schemi degli stessi nostri capi, dopo aver combattuto eroicamente in Russia e altrove come generale dell’esercito italiano. La reincarnazione del fascismo nella Repubblica Sociale Italiana non avrebbe mai dovuto permettere che i suoi soldati, e specialmente gli alti ufficiali, che erano stati valorosi e audaci combattenti, fossero trattati così vergognosamente per il solo fatto di non aver voluto tradire il proprio giuramento al re. Sempre alla baracca n. 17 feci altre conoscenze con stranieri. Ne ricorderò tre che meritano davvero un cenno particolare. Erano tre francesi, che formavano un simpaticissimo terzetto: due di Parigi e uno di Lione. Il lionese era un chierico gesuita; gli altri due membri della J.O.C., ossia Gioventù Operaia Cattolica. Rastrellati da borghesi in Francia, vennero inviati in Germania come operai. In quanto tali, pur assegnati a un campo di baracche, godevano prima e dopo il lavoro di una certa libertà. Si servivano di questa per frequentare un convento di carmelitani, dove un padre teneva conferenze in lingua francese. Dallo stesso padre si confessavano ogni venerdì e ricevevano la comunione. La loro pietà traluceva dall’aspetto sereno, aperto, quasi angelico. Un mattino, sorpresi in convento dalle SS, furono arrestati col padre; e, mentre del padre non seppero più nulla, essi furono mandati in un campo di concentramento politico e poi a Flossenburg. Il chierico gesuita era esemplarissimo, ma molto riservato; uno dei parigini era pio e devoto, ma timido e silenzioso; l’altro parigino, invece, era singolarissimo. Già al primo incontro suscitava le più v ive simpatie. Allegro, vivace, spiritoso, con una parlantina che incantava, pareva godesse infinitamente di trovarsi in un campo di concentramento. Dopo avermi raccontato che a Parigi lavorava molto per la J.O.C., che aveva la fidanzata, anch’essa attivissima nella J.O.C., e che aveva avuto una quantità di peripezie con i tedeschi, uscì d’improvviso in questa esclamazione: Qu’il est beau soufrir pour Jesus! Sembrava un S. Tarcisio. Era delizioso nel prendere in giro il capo-baracca e i suoi satelliti. «Che i tedeschi debbano farla a un parigino!?» esclamava: «Ci rivedremo a Berlino!». Ma il povero ragazzo, dopo qualche settimana, era quasi distrutto. E un’altra volta ripetè: «E’ bello soffrire per Gesù, ma è difficile!». Purtroppo nè lui nè i suoi compagni non videro nè Berlino, nè Parigi, perché, come Bidoli, vennero uccisi pochi giorni prima della liberazione, incolpati di avere un pezzo di pane e scoperti mentre se lo dividevano. Io considero i tre giovani come martiri, in quanto arrestati, internati e uccisi perché sorpresi in convento a compiere pratiche religiose. Nessun atto d’indisciplina, nessuna attività politica aveva giustificato il loro internamento. Il pezzo di pane in loro possesso non poteva essere che una offerta, avuta di nascosto lungo la strada, come non di rado avveniva, da qualche buona donna tedesca. Essi furono tra quelli che vennero con me a Zwickau, dove però, essendo essi assegnati a un’altra baracca e ad un lavoro diverso dal mio, non ebbi più occasione di rivederli.
A Zwickau
Padre, mi disse una sera l’amico Bidoli, si parla di un grosso Transport per domani o dopodomani. «E dove si andrà?». «Verso la Germania del nord». «Brutto segno. Ci allontaniamo sempre più dall’Italia». «Pare si vada in uno stabilimento, perché richiedono meccanici». «Lavorare al coperto e forse al caldo non sarebbe male. Comunqu e noi siamo certamente esclusi». Invece fummo compresi tutti e due. Il giorno dopo vi fu l’adunata generale per la scelta dei candidati al nuovo Transport, ma non badarono se i prescelti erano o no meccanici. Con noi due vennero presi alcuni altri della nostra baracca, tra cui il buon Angelo Semeria di Sanremo e i tre giovani francesi dei quali ho parlato nel precedente capitolo. Il generale Barbò e il carissimo Dante Graziani restarono a Flossenburg. Il primo non l’avrei più veduto, il secondo solo al mio ritorno in patria. Eravamo circa duecento partenti. Dopo l’adunata fummo inviati direttamente alla baracca 24, che si poteva chiamare la pista di lancio dei Transport. Qui ci diedero la divisa zebrata del galeotto; sempre così facevano con quelli che allontanavano dal campo, sia per semplice lavoro come per lunghi viaggi. La ragione era evidente: se alcuno fosse riuscito a fuggire, poteva subito essere riconosciuto, arrestato e riconsegnato all’autorità. Nella nuova baracca conobbi altri italiani arrivati a Flossenburg dopo la nostra spedizione. In particolare ricordo due dottori giunti insieme dal campo di Dachau: il dott. Besana di Milano e il dott. Zanini, medico condotto a Calolzio Corte, vicino a Lecco, nativo di Asolo nel Veneto. Il primo doveva probabilmente essere celibe perché assai giovane, il secondo aveva moglie e due bambini. Un giorno, mentre stavamo riposando sui castelli, un giovane ebreo, sapendo che io ero sacerdote, dichiarò che appena gli fosse stato possibile si sarebbe fatto cattolico. Benché polacco, parlava molto bene l’italiano. A questa dichiarazione il dott. Besana scattò in malo modo: «E io mi farei piuttosto mussulmano. La religione cattolica è semplicemente ridicola». Io lo rimbeccai subito: «Dottore, lei può pensare come vuole, la prego di rispettare, soprattutto in questo momento, le idee mie e di molti altri qui presenti». Egli non reagì e dopo si voltò sul fianco a parlare con altri. Poco dopo mi sentii chiamare dal dottor Zanini: «Padre, la prego, venga subito da me». Appena fui da lui: «Padre, mi confessi. Mi sento tanto male... e voglio compiere il mio dovere prima che Iddio mi chiami, e sarà presto, ne sono tanto certo». Eppure non sembrava molto ammalato... Ascoltai la sua confessione, dopo la quale mi raccomandò, se fossi tornato in patria, di portare la notizia della sua morte alla moglie e al suo confessore, un padre benedettino di Pontida, l’abbazia poco distante da Cololzio Corte. Rilevai subito il contrasto spirituale dei due dottori. Non diminuì tuttavia in me la stima per il dottor Besana. Attribuii quella infelice uscita più allo stato d’animo prodotto in lui dalle circostanze che dall’avversione alla religione cattolica. Forse, come farebbe supporre il cognome era ebreo egli stesso e avrà sentito con disgusto la dichiarazione del correligionario polacco. Del resto anch’egli non conservò rancore per il mio richiamo, poiché, rimpatriati entrambi, mentre il povero Zanini morì davvero, venne a trovarmi al mio convento di Milano. Purtroppo io ero assente e non ebbi più occasione di vederlo. La nostra permanenza alla baracca n. 24 durò poco. Il 25 ottobre fu giorno di partenza. Niente pacchi, niente valige per il viaggio, e come sempre, inquadrati e con le SS ai fianchi, la marcia fu dura e faticosa. Un mese e mezzo di campo ci aveva tutti infiacchiti e depressi. Se infatti l’uscire dal campo ci dava l’illusione di una passeggiata o di una gita allegra con la possibilità di godere un giorno o due di aria libera, l’incognita della meta e di quanto ci aspettava al nostro arrivo al luogo di destinazione ci opprimeva terribilmente. Doppiamente triste fu il distacco dai cari compagni di sventura lasciati al campo. Quanti ne erano morti! E quanti ne stavano per morire?... Scendemmo dal monte passando ai piedi del castello, dove per molti giorni ci avevano caricati di sassi da portare alla nuova strada del campo, e arrivammo alla stazione di Flossenburg. Qui ci attendeva il treno. Appena montati, questo lentamente si mosse. In quale direzione e su che linea si viaggiasse non era possibile sapere, perché chiusi nei vagoni merci, poco o nulla era possibile vedere all’esterno. Il treno proseguì con frequenti e lunghe fermate per lasciare libero il passaggio ai convogli militari che si succedevano l’un l’altro quasi ininterrottamente, dando la sensazione che la Germania fosse tutt’altro che vicina alla sua fine. Finalmente verso le ore quattordici, non so se del primo o del secondo giorno, entrammo in una grande stazione. Smontati dal treno, fummo condotti nella sala d’aspetto attrezzata come una immensa osteria tedesca. La sala era affollata di civili, parte seduti ai tavoli, parte in piedi, fermi o in movimento tra un tavolo e l’altro. Tutti erano forniti di pacchi o fagotti, dai quali estraevano modeste provviste mangerecce, che venivano democraticamente consumate. Il nostro arrivo non destò in loro grande curiosità perché già abituati a simili spettacoli; chi ci degnò di uno sguardo mostrò freddezza e indifferenza, perché agli occhi di tutti noi eravamo dei criminali. Dopo circa due ore si diede il segnale della partenza. Uscendo leggemmo sul frontale della stazione: Zwickau Bahnhof cioè stazione di Zwickau. Capimmo di essere in Sassonia a nord-ovest dei Carpazi, a poche decine di chilometri da Lipsia. Zwickau è una città di circa 130.000 abitanti, al centro del grande bacino minerario della Sassonia del sud e sulla via che dalla Germania dell’ovest porta a quella dell’est, lungo il versante settentrionale dei Carpazi. Oltre a miniere di carbone, possiede molte industrie dislocate alla periferia. Notissima quella dell’Auto-Union, distante dalla città due chilometri circa. Noi eravamo destinati a questo stabilimento. Infatti appena usciti dalla città su una larga via periferica, percorremmo un lungo tratto di strada in aperta campagna e arrivammo a destinazione dopo circa tre quarti d’ora. Entrati nello stabilimento, veramente grandioso, l’ingegnere capo ci passò in rivista e assegnò a ciascuno il posto di lavoro. A me a al Semeria, notata la nostra anzianità (lo stesso ingegnere disse ad alta voce: Sie sind alt = sono vecchi!), fu assegnato il tavolo di controllo dei pezzi per motore. Compiute queste operazioni fummo condotti al campo distante duecento metri dallo stabilimento. Creato esclusivamente per accogliere operai internati addetti all’Auto-Union, era molto ristretto e consisteva in cinque sole baracche, più l’infermeria, le abitazioni delle SS e i servizi. Come ogni altro campo, una rete di filo spinato lo recingeva e la strada stessa, che lo univa allo stabilimento, era fiancheggiata da alti reticolati. Il capo-baracca ci accolse con una certa freddezza, ma senza sgarbi. Era un polacco. Nel complesso la prima impressione fu abbastanza buona. Ci sembrò che la disciplina fosse meno rigida, i capi più umani, il luogo più accogliente e che, pertanto, saremmo stati trattati meglio che a Flossenburg. Ma vedremo subito qual’era la realtà.
Operaio nell’Auto-Union
Il giorno dopo il nostro arrivo incominciammo di fatto il nostro lavoro. Andati allo stabilimento, un operaio tedesco ci indicò un tavolino in mezzo al gran salone delle macchine e ci istruì su quanto dovevamo fare. Mentre gli altri italiani ebbero ciascuno una macchina da sorvegliare e azionare, Semeria ed io dovevamo prendere i pezzi di motore già fatti e compiere su ognuno di essi ben dieci misurazioni con altrettanti strumenti; poi, se trovati regolari e perfetti, imprimervi il timbro di lasciapassare; e, se manchevoli o con qualche difetto, scartarli. Senza la nostra approvazione nessuno poteva m ontarli. C’era da inorgoglirsi della nostra importanza. Con noi però al nostro tavolo lavorava anche un tedesco, il quale in definitiva sarebbe stato il responsabile, ma egli mancava di frequente dal posto e, anche se presente, approvava sempre tutto ciò che noi facevamo. Non parlava mai. In due mesi avrà detto si e no dieci parole. Per noi due poveri vecchi l’ingegnere capo ebbe davvero tanta delicatezza. Io in particolare avevo preso gusto al mio lavoro e il tempo mi passava senza che me ne accorgessi. Ed era abbastanza comodo e abbastanza calmo. Dopo una settimana cambiammo di turno, lavorando la notte. E così il lavoro si alternava settimanalmente dalle sei con una sola semplice sosta a mezzogiorno e a mezzanotte per il magro pasto. Durante il lavoro nessuno ci disturbava. Le SS sembravano scomparse dalla circolazione e il personale civile, purché si lavorasse, non si interessava molto di noi. Solo una notte, essendomi momentaneamente addormentato, venne a svegliarmi una SS, ma fu tanto gentile che non mi fece alcun rimprovero. In caso simile à Flossenburg sarebbero state buone legnate. Anche durante le ore di riposo, sia di giorno che di notte, eravamo lasciati in pace e si poteva dormire tranquillamente. Ma neppure Zwickau era un paradiso. Il brutto veniva dopo il lavoro, rientrati in baracca. Come era logico, per prima cosa bisognava lavarsi mani e faccia. Ma non ci davano nè sapone nè asciugamano, ed era impossibile levare il sudiciume che ci deturpava. All’entrata della baracca un apposito addetto ci squadrava minuziosamente e notando qualche macchia non bene detersa, a bastonate ci rimandava ai lavatoi, e ciò ogni volta che non ben puliti si ricompariva sulla soglia della baracca. Ogni mattina poi e ogni sera, prima di uscire dal campo di lavoro, ci schieravano per due o tre ore sulla piazza centrale al freddo di 10 e 15 gradi sotto zero, ora tenendoci immobili, ora obbligandoci a saltare come rane, ginocchi e gomiti a terra. Pratica già usata dal caporale Franz coi detenuti pericolosi a San Vittore di Milano: un vero tormento. Il nostro capo-baracca era degno emulo di quello della baracca 23 a Flossenburg. Mancando un giorno una scodella di minestra e non trovandosi il colpevole, inflisse a tutta la camerata una singolare punizione. Allineati in cortile, a due a due, il primo, il terzo, il quinto e così via ogni occupante un posto dispari, veniva scelto e punito con dodici staffilate, somministrate con tutto gusto e forza da un nerboruto milite delle SS. Fortunatamente trovandomi al secondo posto schivai quel delizioso trattamento. Un’altra volta invece toccò a me solo qualche cosa di peggio. Ci avevano ordinato di spogliarci di tutta la biancheria per la disinfezione. Immersa in un gran mastello ripieno d’acqua e di non so quali acidi, in meno di dieci minuti fu lavata e stesa. Dopo poco il capo-baracca in persona ci comandò che la indossassimo ancora gocciolante. Io mi permisi, esprimendomi in tedesco, di osservare che era ancora tutta bagnata. Non l’avessi mai detto! Con un forte calcio nel basso ventre mi gettò a terra e poi mi calpestò sullo stomaco e sul ventre con tanta violenza che io credetti giunta la mia ultima ora. A stento mi rialzai e percepii all’inguine un dolore acutissimo, che mi durò più di una settimana. Nonostante tutto, dovetti indossare quegli stracci così bagnati e andare al lavoro per tutta la giornata. Temevo di buscarmi una polmonite alla quale ero purtroppo facilmente soggetto; invece non ebbi neppure un colpo di tosse. La mia disavventura giovò, però, ai miei compagni che, mostrando pronta obbedienza, finsero di indossare i loro panni, ma andarono a nasconderli in baracca. A Zwickau lasciò la vita, invece, per fame e maltrattamenti, un bravo ragazzo di Vigevano, un certo Testori, da tutti ben voluto per il suo buon carattere e per serenità del suo spirito. Con questo ritmo di vicende ora lie te e sopportabili, ora dolorose per non dire tragiche, passammo a Zwickau tutto il mese di novembre e parte di dicembre. I primi giorni di dicembre furono per me particolarmente tristi. Avevo un ultimo amico nel campo, il Semeria, ma anche da quello dovetti separarmi. Ci potevamo vedere poco a causa dei diversi turni di lavoro; tuttavia era confortevole trovarci di quando in quando, fra un turno e l’altro. Gli altri italiani, ridotti di numero, non avevano con me la stessa confidenza. Soltanto il buon comunista Bidoli mi teneva ancora una cara compagnia. Egli, però, aveva bisogno di chiarire le idee per poterci meglio comprendere a vicenda. Son sicuro che, se fosse sopravvissuto, sarebbe diventato un ottimo cristiano, abbandonando utopie comuniste, perché - in definitiva - ragionava con la sua testa ed era di animo retto. Il Semeria, che già a Flossenburg si era lamentato di sentirsi debole, a Zwickau andò sempre peggiorando. Un mattino mi si avvicinò e mi disse: «Padre, non ne posso più. Ho saputo che c’è una tradotta di ammalati per l’infermeria di Flossenburg e domanderò anch’io di esservi incluso». «Non farlo», gli dissi; «sai già che cosa è il campo di Flossenburg». «Si; lo so. Ma non ho più la forza di stare in piedi a lavorare per dodici ore al giorno. Mi sento veramente sfinito». E fece la domanda, che fu accolta; ma andava verso la morte. Rimasto in fabbrica senza compagno, giorno e notte solo al tavolo di lavoro, isolato, posso dire, anche dagli altri italiani della stessa baracca perché ognuno doveva pensare a se, fui preso da una grande malinconia. Mi ricordo che una sera, sentendo suonare le campane di Zwickau - un concerto che pareva quello di un magnifico organo - mi sentii spuntare le lacrime agli occhi. «Era già l’ora che volge al desio...». Che tristezza! Che nostalgia!... e mi misi a pregare. Fortunatamente a ricordarmi chi ero e la missione particolare che dovevo com piere, venne un giorno un internato straniero: un uomo distinto, dalle maniere dignitose e dallo sguardo intelligente. «Perdoni», mi disse, rivolgendomi la parola in francese. «Mi hanno detto che lei è un sacerdote cappuccino. Io sono un avvocato di Parigi. Vorrei confessarmi. Sono venticinque anni che non lo faccio. Può ascoltare la mia confessione? «Volentieri» risposi. E si confessò con grande fede e umiltà. Non lo vidi più. Spero che, se è sopravvissuto, continui sempre da buon cristiano nella sua immensa e babilonica Parigi. Con questo alternarsi di abbattimenti e di conforti era già passato a Zwickau anche il 10 di dicembre. Nulla faceva prevedere qualche notevole cambiamento. Circa le vicende della guerra eravamo perfettamente all’oscuro. Ogni poco vi erano incursioni anglo-americane. Avuto il segnale d’allarme noi sospendavamo il lavoro e scendevamo nei sotterranei dello stabilimento, che costituivano un ottimo rifugio. Lo stabilimento però non fu mai colpito. Dalla regolarità e intensità con cui procedeva il nostro lavoro, la cui produzione era destinata alla guerra, si aveva l’impressione che la Germania fosse ancora fortissima. Gli italiani avevano scrupolo di lavorare per il nemico, ma io li assicuravo che le macchine da noi fabbricate sarebbero finite nella mani degli alleati e quindi anche dell’Italia. Intanto conveniva filar diritto, per evitare che il nostro trattamento peggiorasse. Ma in quei giorni mi capitò quello che non mi aspettavo. Il 12 dicembre ricevetti l’ordine di recarmi al comando delle SS. «Che cosa sarà?, pensavo tra me; perché io solo e non anche altri?». Ma ormai ero pronto a tutto. «Avvenga ciò che Dio vuole!». Nell’ufficio delle SS trovai altri due internati polacchi. Scambiateci poche parole, venni a sapere che erano due preti. Fino allora non ci eravamo riconosciuti, stando essi in una baracca diversa dalla mia. Mi dissero che stessi di buon animo, perché a vevano saputo dal capo-baracca polacco che noi eravamo destinati a Dachau, avendo la S. Sede ottenuto che i sacerdoti internati fossero raccolti tutti insieme in quel campo. Ricevuti poco dopo dal capo delle SS, questi confermò quanto mi avevano riferito i due sacerdoti polacchi e ci ordinò di tenerci pronti per il giorno seguente.
Soste a Norimberga e a Flossenburg
Il 13 mattina partimmo per Norimberga. Quando arrivammo a questa città, erano forse le quattro del pomeriggio. Tutto faceva credere che avremmo proseguito per Dachau; invece alla stazione ci fecero scendere dal treno e, condottoci in un piazzale appartato e libero dai binari, ci schierarono in attesa di ordini. Nel frattempo altri treni provenienti da ogni parte scaricavano nuovi internati che furono uniti a noi aumentando così enormemente il nostro numero. Poi si seppe che avremmo fatto sosta per qualche giorno a Nonmberga. La decisione non mi dispiacque. Avevo letto molto di questa città, certamente una delle più importanti della Germania, e desideravo molto vederla per farmene un’idea, sia pure superficiale. E’ curioso come bastasse un breve intervallo di respiro fuori dai campi per darci l’illusione di essere quasi dei liberi cittadini e provare la gioia di turisti in viaggio di piacere. La città di Norimberga contava allora 400.000 abitanti circa. Nonostante appartenga alla Baviera, notoriamente cattolica, è per due terzi protestante e per un terzo appena ha conservato la fede di Roma. E’ antica e moderna insieme. Nella parte medioevale è ricca di monumenti, di palazzi artistici, di chiese gotiche passate in gran parte al protestantesimo. Nella moderna prosperano invece molte industrie. Tradizionale è la produzione dei giocattoli, noti in tutto il mondo. Inquadrati come al solito, fummo fatti uscire dalla stazione attraverso un passaggio di servi zio e, percorse alcune vie secondarie, la grossa colonna infilò un magnifico viale fiancheggiato da palazzi moderni, tra cui una chiesa certamente cattolica, di proporzioni grandiose. Fatti quasi due chilometri, la colonna volse verso il centro, passando sopra un fossato simile al vecchio naviglio di Milano, sulle cui sponde, tra alberi e giardini ormai spogli per la fredda stagione, si annidavano linde casette in perfetto stile nordico, tutte cuspidi e balconi in legno, che in altri tempi dell’anno erano certamente carichi di fiori, come in Svizzera e nel Tirolo. Alcune rovine attestavano che anche a Norimberga erano giunti i bombardamenti alleati; ma in complesso la città vecchia era quasi intatta. Procedendo verso l’interno per strade dagli edifici severi, di colore scuro per la loro antichità e di aspetto molto signorile, giungemmo in una piazzetta austera e triste con a lato una chiesa gotica, forse protestante. Di fronte a questa sorge il massiccio e vecchio palazzo di giustizia, dove ci fecero occupare l’ampio cortile. Completate le solite formalità, fummo accantonati in alcune grandi baracche erette in fondo al cortile stesso. Qui non comandavano più le SS ma la gendarmeria del Reich, molto più umana e cortese. Le baracche avevano riscaldamento, e la cena quella sera sembrò quasi una leccornia, consistendo in un piatto di patate non mai viste fino allora se non per caso. La notte si potè dormire bene. Il giorno seguente però la sorte mutò. Dalle baracche del cortile fummo trasferiti al quinto piano del palazzo, cioè negli abbaini, aperti a tutti i venti e con il pavimento di cemento, sul quale dovevamo dormire senza pagliericci e senza coperte. In vita mia non ho forse mai sofferto tanto freddo come in quell’occasione. Di giorno, movendoci, ci si poteva discretamente difendere, ma di notte ci sentivamo come in una cella frigorifera e fu un vero miracolo se al mattino non ci trovarono tutti stecchiti. A Dio piacendo la mattina del quarto giorno, 16 dicembre, venne l’ordine di riprendere il viaggio. Ma ecco altra sorpresa. Anzichè partire per Dachau si ritorna a Flossenburg. Questo campo non era sulla linea Norimberga-Dachau, ma fuori mano, fra i monti Sudeti, che dividono la Baviera dalla Boemia e, per arrivarci, bisognava prendere la linea secondaria di Flossen e da qui percorrere parecchi altri chilometri a piedi. Mi venne il sospetto che ci avrebbero di nuovo installati in quel campo. Ma non tutto il male vien per nuocere; a Flossenburg avrei potuto avere notizie dei compagni italiani che vi avevo lasciati due mesi prima. Rifacendo il cammino dal palazzo di Giustizia alla stazione di Norimberga, rilevai che si era assai meno di quanti eravamo arrivati quattro giorni prima. Notai pure che alla nostra colonna erano stati aggiunti parecchi ungheresi, tra i quali apparivano persone distinte, forse arrestati da poco e, per loro disgrazia, destinati proprio a Flossenburg. Essi avevano dignità e fierezza che non si notavano nei comuni prigionieri. Anche l’ungheria partecipava alla dolorosa sorte dell’Europa. Giunto a Flossenburg, fu il generale Armellini che incontrai per primo. Mi salutò affettuosamente e in un momento di libertà mi diede un pezzo di pane e mi preparò una bibita. Venni assegnato nuovamente alla baracca 23 e sotto il medesimo capo, che però verso di me, questa volta, usò un contegno diverso dal precedente: mi trattò con particolare gentilezza, forse perché ero solamente di passaggio. Nella baracca trovai subito il caro amico Semeria. Ci abbracciammo con grande effusione. Era un vero scheletro e appena stava in piedi. Quando egli seppe che ero diretto a Dachau, malinconicamente mi disse: «Caro Padre, lei va verso la vita, mentre io presto andrò al crematorio». Parole che mi si confissero come una spina nel cuore e suonarono come un rimprovero a me, che potevo considerarmi un priviligi ato. Pur ignorando ciò che mi aspettava a Dachau, avrei desiderato restare con lui e gli altri italiani a Flossenburg per condividere la loro sorte. Più tardi, informatomi di loro, venni a sapere che la maggior parte, purtroppo, erano morti. Una vera ecatombe! I pochi superstiti, tranne il generale Armellini, il maggiore (ora colonnello) Pesapane, Dante Graziani e pochissimi altri, erano tutti ammalati o addirittura moribondi. Particolarmente pietose le condizioni di quattro italiani nella stessa baracca 23: un triestino, un comasco, uno di Somma Lombardo e uno di non so quale luogo. I primi tre erano ridotti all’estremo. Mi avvicinai a loro e feci in modo di rimanere sullo stesso loro castello per quei pochi giorni che mi sarei trattenuto a Flossenburg. Il triestino vaneggiava di continuo e, purtroppo, non diceva che bestemmie. Si protestò comunista; ma credo che non avesse piena coscienza di quello che diceva. Gli altri si sono confessati ancora in piena cognizione e mostravano di essere perfettamente rassegnati alla morte. Quello di Somma Lombardo mi raccontò che in giornata, sul lavoro, era stato battuto a sangue ben quattro volte. Infatti presentava su tutto il corpo molte e gravi lividure. La febbre lo divorava. Il poverino accusava freddo. Gli procurai due coperte, ma mentre mi allontanai per un istante, alcuni comunisti russi che gli erano vicini, gliele strapparono di dosso. Presi allora una specie di pagliericcio e glielo stesi addosso e per aiutarlo a scaldarsi mi coricai al suo fianco. Parve che si addormentasse: ma verso la mezzanotte, svegliatomi a caso, m’accorsi d’avere al fianco un cadavere. Lasciava moglie e quattro o cinque figlioli. Il triestino e il comasco morirono all’alba. Tre cadaveri in una notte e in un solo angolo della baracca. Ma non fu questo il mio dolore più grande. Il capo-baracca mi avvertì che all’infermeria era degente un giovane italiano e mi pregò di andare a fargli visita. Mostrava m olta pena nel darmi la notizia. L’insolita premura e tenerezza in un uomo simile mi parvero subito assai sospette. Non potendo andar solo attesi che lui stesso mi conducesse o mi facesse accompagnare presso l’ammalato. Il giorno seguente, però l’ammalato mi fece dire che, se gli avessi fatto visita come semplice compatriota o amico, la cosa gli sarebbe stata tanto gradita, ma che non mi presentassi come sacerdote. Una tale dichiarazione accrebbe il mio timore che il povero ragazzo fosse già stato pervertito dal diabolico capo-baracca. Lo conoscevo bene; viaggiammo assieme da Bolzano a Flossenburg, dove trascorsi con lui quasi un mese nella stessa baracca 23. Si era sempre mostrato religioso, partecipando volentieri alle preghiere che un gruppo di compagni recitava di frequente. Benchè fosse nipote di un noto fascista, diceva di essere stato arrestato e internato per i suoi sentimenti anti-tedeschi. Gli italiani, rimasti con lui al campo, confermarono il mio dubbio che si fosse eccessivamente legato al capo-baracca; anzi mi dissero che, per far piacere a costui, il disgraziato aveva cooperato ai maltrattamenti dei suoi stessi compatrioti. Io non posso attestare nulla in proposito. Sopravvissuto all’internamento e tornato in Italia fu denunciato ed ebbe anche qualche condanna. Cristiana e patria carità mi vietano di rivelare il suo nome, che ricordo bene. La sosta a Flossenburg durò quattro giorni. Il 18 dicembre venne l’ordine di riprendere il viaggio per Dachau. Due altri sacerdoti, uno lazzarista e l’altro francescano, furono uniti a noi tre. Il lazzarista mi disse che era rettore del seminario di Cracovia. Parlava bene il tedesco, il francese e l’italiano ed era molto colto e affabile. Il francescano mostrava tanta bontà e carità da vero e degno figlio di s. Francesco. Partimmo soltanto noi cinque chiusi in un furgone, ammanettati e legati l’uno all’altro, accompagnati, si intende, dai soliti angeli custodi delle SS. Viaggiam mo così fino a Norimberga. Qui fummo caricati su un treno-prigione e pigiati in uno sgabuzzino capace di una sola persona. Soltanto uno di noi poteva sedere tenendone un altro sulle ginocchia; gli altri tre dovevano stare in piedi stretti stretti con la schiena contro le pareti. Ma la compagnia era tanto cara e fraterna che nessuno si lamentava per il disagio della situazione. Giungemmo a Dachau-stazione verso le tre pomeridiane. Il treno riversò una fiumana di altri prigionieri e poi si ripetè lo spettacolo della colonna in marcia verso il campo. Così terminava il mio ultimo Transport, perché il campo di Dachau sarà l’ultima tappa della mia prigionia.
Le marce della morte
Per gli ex-internati nominare i Transport è far loro rizzare i capelli in testa. Con tal nome i tedeschi indicavano il trasferimento di alcune centinaia o migliaia di intemati da un campo a un altro. Tale trasferimento sarebbe dovuto essere un sollievo per i poveri disgraziati, sempre chiusi entro i campi, sotto la continua pressione di sevizie o di pesanti lavori. Ogni cambiamento di prigione dà ai carcerati speranza di andare a star meglio. Se non altro, lungo il viaggio si rivede il mondo civile, si respira un po’ d’aria libera, si contempla qualche bel panorama della natura, che Dio ha fatta così bella. Ma i Transport erano ben altro che un sollievo! Abbiamo visto come fu organizzato e condotto il Transport da Bolzano a Flossenburg. Chiusi, senz’aria e senza luce, in carri-bestiame, con una finestrella ben difesa da filo spinato, attraverso alla quale poco o nulla si vedeva, senza possibilità di riposare, neppure sul pavimento, per mancanza di spazio, costretti a restarvi più giorni digiuni, perfino di acqua, e impiegare giornate e giornate per arrivare alla meta, mentre sarebbe bastato un giorno solo. Così pure ho descritto il Transport < /I>da Zwickau a Dachau, non certo migliore. Gli internati, al termine del viaggio, erano sfiniti. Però casi di morti, nei due trasferimenti suaccennati, non ce ne furono, che io sappia; e, anche in altri Transport in ferrovia, sono sempre stati relativamente pochi, salvo negli ultimi tempi. Ma quando i Transport si facevano a piedi (e verso la fine era quasi sempre così), essi si convertivano in vere marce della morte. Parevano fatti apposta, non per sistemare l’affluenza, sempre più alta, dei nuovi arrivati ai Lager, ma per disfarsi dei meno validi più in fretta e senza mostrare la ferocia dei campi, dove ormai i crematori non bastavano più. Io personalmente non ho partecipato, se non per brevi tratti, ai Transport a piedi, ma potei udire mille volte dalla viva voce dei superstiti la descrizione impressionante di queste marce della morte. Quello che si è scritto sul durissimo trattamento degli schiavi nei tempi passati, è poco in confronto di questi spettacoli di efferatezza nazista contro gente libera e civile, colpevole solo di amare la propria patria e di aver cristianamente aiutato i perseguitati a morte. D’ordinario i Transport venivano annunziati nel campo un giorno o due prima, senza dire per dove erano diretti o chi vi sarebbe stato compreso. Naturalmente nasceva in ognuno una viva ansietà di sapere quale sarebbe stato il proprio destino. Alla vigilia vi era una specie di visita medica, che non si sa bene se doveva servire per scegliere i forti e robusti (se ancora ve n’era alcuno), oi più deboli e invalidi. A volte si chiedeva al prigioniero la professione o il mestiere, ma in pratica, come notai altrove, non se ne teneva conto, mandando un sacerdote a fare il meccanico (come lo scrivente), e un meccanico a scavare nelle gallerie. I prescelti per il Transport, non avendo nulla di nulla, non avevano bisogno di far valigie. Al mattino presto partivano incolonnati, avendo avuto, al più, la solita razione di the e niente altro. Inquadrati dalle SS col mitra spianato, dopo qualche diecina di chilometri qualcuno cominciava a venir meno per la fatica del cammino. I compagni lo sostenevano, spesso lo portavano in spalla per lunghi tratti; ma anch’essi, a poco a poco, sentivano le forze mancare e dovevano abbandonare lo sventurato sui margini della strada. Era la fine. La SS che veniva in coda al macabro corteo gli sparava un colpo di rivoltella alla nuca e lo rotolava a calci nel fosso o nel campo vicino. Riporto qui, a conferma, una lettera che, dopo quindici anni dai dolorosi avvenimenti, mi scrisse Tomasi Bruno, il quale fu per qualche tempo mio compagno a Dachau nella baracca della quarantena. In tutti questi anni io non sapevo se piangerlo morto o pensarlo emigrato all’estero. Ma neppur lui sapeva la mia sorte e mi scoperse al leggere sopra un giornale di Trento la recensione del mio libro nella sua prima edizione. «Caro p. Giannantonio, La devo ringraziare molto della sua squisita gentilezza per l’invio del bel libro, che mi ha riportato, seppur a malincuore per le traversie subìte, al tempo del nostro internamento. Ho letto e ammirato la sua mancanza di risentimento ed odio per quelli che suscitarono ed eseguirono un tale massacro, ma soprattutto concordo nel non dover condannare un’intera nazione per i crimini commessi da una cricca, seppur numerosa, di sadici e criminali. Ormai sono passati molti anni e molte acque torbide si sono decantate e perciò resto nell’avviso di allora, di perdonare, anche se non si deve e non si può dimenticare, affinchè il sacrificio comune nostro e di molte altre nazioni - compresa la Germania - serva ad evitare un maggiore e indiscriminato sterminio. Mi sono ritrovato particolarmente alla pagina dove descrive la comunione della fine anno 1944 (precisamente era il giorno di Natale); c’ero anch’io fra quelli e mi ricordo che mi diede l’assoluzione dei peccati senza nemmeno confessarmi, perché in pericolo continuo di morte, e potei essere fortificato dalla sacra Ostia nascosto sotto un castello, attorniato da parecchi altri internati, per non farci scorgere da qualche eventuale informatore. Verso la metà di gennaio del ’45 io partii con un Transport, denominato (13 Bau Brigade SS), ed inviato verso il fronte francese. Partimmo da Dachau in circa 513 internati e si arrivò a Buchenwald, proprio nel giorno di Pasqua, in soli 86. Il tifo petecchiale, la fame, la nefrite, i mitragliamenti o bombardamenti e le pistole delle SS avevano lavorato a dovere. Qui qualcuno degli 86 rimase per sempre ad aspettare la fine. Io invece fui inviato con un altro Transport - quanti morti durante il viaggio! - a Leitmeritz in Cecoslovacchia - altro massacro, forse il peggiore e più grande che abbia visto - per essere inviato poi verso la Slesia Inferiore, dove finalmente venni, ormai moribondo, liberato e salvato dalle truppe russe. E aveva solo 20 anni il caro giovane trentino! Egli è veramente un testimonio a cui si può prestar fede, perché, scrivendo a distanza di anni con assoluta calma di spirito, senza il minimo risentimento di odio, e a uno come me, che ben conosce per altre vie come stavano le cose, non può dire che la verità. Un’altra testimonianza autorevole sul modo col quale si svolgevano i Transport a piedi é quella del generale Candido Armellini, del quale ho fatto cenno parlando di Flossenburg. E’ una lettera scritta da Venezia e che riporto pure integralmente, perché dice intero il suo animo profondamente religioso e l’affetto fraterno che mi portava, e perché, essendo stato scrivano nel campo, documenta certi particolari che spiegano le divergenze di cifre degli internati e dei morti anche di altri campi. Lido (Venezia), 20-11-1946. «Sia lodato Gesù Cristo. Carissimo Padre e carissimo amico, quale gioia è stata la m ia nel ricevere la tua lettera che mi dava la prova che la mia cartolina ti era giunta e che, d’ora in avanti, potevo corrispondere col mio caro Padre: te lo potrebbero confermare i miei famigliari, ai quali ho letto le tue belle parole. Io tornai alla metà di luglio, e poco dopo venne a trovarmi un mio cugino che sta a Milano, che aveva saputo che io ero vivo, scampato, meglio, perché un cappuccino, a Milano, lo aveva detto in chiesa - e quel cappuccino dovevi essere tu. Si, la nostra salvezza è un regalo del Signore, che nella sua infinita clemenza non ha voluto che restassimo vittima di quei miscredenti, noi che in Lui abbiamo riposto e riponiamo tutta la nostra Fede. Caro amico, io ti ho sempre ricordato e ti ricordo nelle mie preghiere, e son certo che tu non mi dimenticherai nelle tue. Quando tu partisti da Flossenburg (in catene - assassini!), io continuai a fare lo scrivano. Seguivo ansiosamente le mosse degli Alleati. Alla fine di marzo si sentiva già tuonare sempre più prossimo il cannone. Gli aeroplani americani volavano quotidianamente e sempre più numerosi sul nostro cielo. Le SS ci fecero distruggere tutti i bollettini dei vivi e dei morti, nonchè i registri (questi ultimi però noi li nascondemmo in un posto che io, più tardi, comunicai agli Americani), ci cambiarono i numeri (di matricola), ed il 20 aprile, via il campo, in marcia verso Dachau! Marciammo tre notti (dalle 19 alle 7 del mattino), sotto una pioggia dirotta e con freddo gelido. Eravamo in circa 15.000 divisi in scaglioni: chi si fermava per esaurimento era abbattuto con una fucilata nella testa. Migliaia furono ammazzati in tal guisa, e nessuno ne saprà mai i nomi - era di notte, e chi aveva forza e cuore di cercare di conoscerli, premuti da ogni parte dalle SS? Poi partenza il mattino del 23 aprile. Mentre eravamo in marcia, una "cicogna" ci scorse e ci segnalò ad una colonna americana, che affrettò la sua corsa (era una infinita colonna di car ri armati) e ci raggiunse. Quello che successe allora, non si può descrivere - eravami liberi... Liberi! Sia lode al Signore! Rimasi quasi due mesi e mezzo cogli americani; poi un missionario, don Luigi Albrigo, mi portò in Italia, ove giunsi il 14 luglio. Ma quanti poveretti e cari amici sono rimasti là! Che Iddio abbia pietà di loro, l’inferno lo hanno fatto in terra. Ti sono grato della tua benedizione, anche a nome di mia moglie che ti saluta. Io ti abbraccio». Candido Armellini «Sia lodato Gesù Cristo». La storia di questi Transport è presso a poco quella di tutti gli altri. Quando negli ultimi tre giorni prima della liberazione si tenterà di portar via da Dachau tutti gli internati, non c’è dubbio che ci fosse l’intenzione, anzi l’ordine, come dirò, di fucilarci tutti in massa. La via del male è lubrica e scivolosa. Chi la imbocca impazzisce e precipita fino in fondo. Dio ci liberi da simili follie, per le quali non c’è al mondo né manicomio adatto né psichiatria capace di guarirle. Solo Dio può, con qualche catastrofe finale, spazzar via tanta inconcepibile insania e depravazione: ciò è avvenuto dei nazisti e loro complici a salvezza della povera umanità.
Dachau
Riprendiamo il nostro racconto. Legati con una catena a due a due, la mano destra con la mano sinistra, dovevamo percorrere quattro chilometri ancora, quasi quanto dista il campo dalla cittadina di Dachau. Avevo per compagno nientemeno che un monsignore, cioè il lazzarista di cui ho parlato più addietro. Mettendoci in cammino, gli dissi: «Possiamo dirci legati come Gesù nell’orto. Saliremo con Lui anche il Calvario?». «Pronti a tutto!», mi sussurrò l’ottimo ministro di Dio. La strada al campo era ben asfaltata e larga da sembrare un viale di parco. Basse colline, coperte dal verde cupo delle pinete, la fiancheggiavano; qua e là, tra gli alberi, bian cheggiavano lussuose ville, le abitazioni delle SS. Vicino al campo un gruppo di caserme per la bassa forza delle stesse SS. Un massiccio fabbricato in pietra al termine della strada ci annunciò che eravamo arrivati al campo. Un sottopassaggio, attraverso tutto l’edificio, immetteva nell’interno del campo. Nonostante l’estrema debolezza e i ferri che ci legavano l’un l’altro, vi passammo in bell’ordine, a passo cadenzato, come reduci da battaglie, vinti ma non domi, pronti anzi a nuovi sacrifici. Le SS locali, che ci attendevano, ci squadravano con un sorriso di soddisfazione e d’ironia. Al di là del sottopassaggio ecco prospettarsi dinanzi a noi una immensa piazza, e poichè era ormai notte, grossi lampioni la illuminavano a giorno. Fu difficile però farci un’idea del campo in quei primi momenti, perché all’inizio della piazza ci fecero sostare in attesa di ordini. E così ce ne rimanemmo per ben due ore. Il freddo era acuto e i ferri ai polsi bruciavano come fossero incandescenti. Finalmente ci liberarono dalle manette e ci condussero nel grande salone del bagno, dove fummo accolti dall’addetto con discreto buon garbo. Dopo la doccia, ci venne distribuita una minestra abbastanza buona, somministrata con belle maniere, senza schiamazzi e bastonate. Verso l’una, nello stesso salone, potemmo accomodarci per terra e riposare. Un gradevole tepore conciliava il sonno. Al mattino fummo condotti in una baracca completamente vuota, in attesa delle solite pratiche di immatricolazione al campo. Il mio numero di matricola fu 136.986. Era già la quinta volta che mi cambiavano il numero di matricola. Ero ansioso di vedere e conoscere i sacerdoti e i compatrioti del campo che, si diceva, erano assai numerosi. Nella mattinata infatti venne a farci visita il capo della baracca 26, detta «la baracca dei preti». Era prete egli stesso, della diocesi di Mùnster. Ci assicurò che dopo qualche settimana saremmo passati alla sua baracca assieme a tutti gli altri sacerdoti. Ci raccomandò frattanto pazienza, promettendo di essere per noi, più che confratello, buon padre. La visita inaspettata e la bontà e tenerezza usataci dal futuro nostro capo-baracca trasfusero in noi, in buonissima dose, gioia e coraggio. Il buon sacerdote si rivolse a me in modo particolare, informandomi dei sacerdoti italiani presenti nel campo e dei numerosi cappuccini tedeschi e polacchi della sua baracca. Nel pomeriggio, noi cinque sacerdoti fummo destinati alla baracca 19, per la quarantena. Vi trovammo un gruppo di Fratelli della Dottrina Cristiana, francesi, professori in diversi collegi della loro patria. Anche il capo di questa baracca ci accolse con molta gentilezza, destinandoci alla stessa camerata e sul medesimo castello coi Fratelli della Dottrina Cristiana. Ci fu ben presto possibile constatare che nella nuova baracca vi erano differenze sostanziali in confronto alle baracche degli altri campi. Prima di tutto il cibo era assai più scarso, forse appunto per dieta di quarantena; poi le bastonate e ogni altra pratica tormentosa qui non si usavano; da ultimo, mentre negli altri campi, di giorno, non si poteva salire sui castelli a concedersi un poco di riposo e la notte, eccettuato il breve periodo di lavoro notturno di Zwickau, il tempo di riposo era ridotto al minimo e spesso interrotto dal capriccio dei capi, qui invece bisognava stare giorno e notte su quella sorta di scaffale. Solo ci si poteva alzare per il rancio e per le necessità igieniche. Veramente sui castelli v’era abbastanza buona paglia e l’ambiente era riscaldato. In complesso non potevamo lamentarci, ma non avrei mai immaginato che il non far niente ed essere costretti a star sdraiati giorno e notte fosse un tormento, a lungo andare, insopportabile. Si escogitò il modo di passare il tempo con un buon sollievo. Noi sacerdoti, pur di diversa nazione, conoscendo tutti la lingua latina, introducemmo l’uso di recitare l’ufficio divino, all’inizio recitando solamente quelle parti che ricordavamo a memoria, ma in seguito ci servimmo dei breviari rifornitici dai confratelli della baracca 26. All’ufficio aggiungevamo di solito anche qualche altra preghiera, sempre in lingua latina: tornavamo ad essere sacerdoti! I Fratelli della Dottrina Cristiana pregavano in francese per conto loro. Alle preghiere alternavamo, per quanto lo comportavano ancora i nostri cervelli, gustose discussioni teologiche e scientifiche; i Fratelli della Dottrina Cristiana ci intrattenevano soprattutto su materie scolastiche secondo la loro specializzazione. Era meravigliosa la calma e la serenità che si godeva in queste ore di preghiera e di colloqui istruttivi. Si era tutti di ottimo umore, dovuto anche alle frequenti visite dei confratelli della baracca 26. Ne vennero, un giorno in buon numero. I sacerdoti polacchi s’interessavano subito dei loro connazionali che erano con coi, parecchi dei quali conoscevano personalmente. Da me vennero due giovani preti italiani, don Camillo Valotta, parroco di Frontale in Valtellina, e don Angelo Dalmazzo di Cuneo. Essendo rigorosamente vietato passare da una baracca all’altra, il capo-baracca usava spesso questo stratagemma per favorire i nostri contatti: incaricava i visitatori di speciali servizi alle baracche, come pulizia, sorveglianza, ecc. Non so dire quanta gioia provai in questi nostri fraterni incontri. Dopo San Vittore a Milano non avevo più avuto occasione d’intrattenermi così piacevolmente e a lungo con sacerdoti connazionali. Passando di emozione in emozione, eccomi il giorno seguente visitato da un padre cappuccino. Naturalmente non portava tonaca e non aveva la barba. Era il padre provinciale della provincia polacca di Varsavia, p. Costante, giovane d’anni, ma uomo maturo di senno e di carattere amabilissimo. Ci abbracciammo con grande effusione. Con comprensibile f ierezza mi informò che, in quei giorni, nelle baracche 26 e 28 c’erano ancora ben 18 frati suoi sudditi, mentre, negli anni precedenti, nello stesso campo ne erano morti almeno una trentina. Il buon padre si diede premura di procurarmi due maglie di lana e un paio di calze, che mi servirono egregiamente per tutto il tempo della mia permanenza a Dachau e che portai con me a Milano al mio ritorno. La mia gioia raggiunse il colmo alcuni giorni dopo il nostro arrivo, cioè il giorno di Natale. A ricordarci la dolce ricorrenza, di mattino presto un trio di strumenti a corda si soffermava presso ogni baracca, suonando inni giulivi e patetiche pastorali. Non mi fu mai possibile comprendere come i tre suonatori abbiano potuto permettersi una cosa tanto audace. Ed ecco a mezza mattina ci si avvicina un sacerdote polacco mormorando sottovoce: «Ho con me il Signore. Chi di voi desidera comunicarsi?». Levò dalla tasca interna della giacca una scatola in cui vi erano una trentina di Particole consacrate, prelévate dalla cappella della baracca 26. Fra tutti i campi di concentramento della Germania per internati politici, quello di Dachau era l’unico che avesse la cappella, dove si poteva celebrare una sola messa al giorno; e ciò per riguardo ai sacerdoti internati tedeschi. Era però vietato l’accesso agli estranei alla baracca. In ogni altra baracca atti religiosi e di culto erano assolutamente proibiti e puniti come crimini. Tutti noi sacerdoti e i Fratelli della Dottrina Cristiana potemmo così ricevere in quel santo giorno la comunione. Anche alcuni altri della baracca, tra cui il bravo giovane di Trento, Bruno Tomasi, poterono fare altrettanto. Oh, santo Natale di Dachau, non ti scorderò mai piu! Che Dio mi volesse riempire di tanta gioia per trarmi a sé? Proprio nella baracca della quarantena infatti fui portato quasi alle soglie dell’eternità. Sarebbe stato certamente quello il momento più opportuno per me. Un poco di penitenza per i mie i peccati mi pareva di averla fatta, almeno come deportato se non proprio come frate cappuccino. Così pure il distacco dal mondo non poteva essere più completo e perfetto. Il giorno di s. Stefano accusai un malessere generale. Non pensate che avessi trasmodato nel cibo e nel bere il giorno di Natale. Cinque o sei patatine e un pezzetto di carne (l’unico in tutto il tempo della mia prigionia). Non so perché, mi prese un dolore acutissimo a un fianco e contemporaneamente una forte dissenteria. Mi preoccupava più questa che quello, sapendola certamente mortale. Mi si consigliò una visita medica e ricovero in infermeria, ma era convinzione comune che dall’infermeria più nessuno usciva vivo. Preferii dispormi alla morte rimanendo in baracca, dove sicuramente avrei beneficiato dell’assistenza dei miei confratelli sacerdoti. Ero ormai agli estremi. Il padre minore che era con me, avendo avuto da un suo confratello polacco un pezzetto di pane bianco e secco come una pietra, spezzatolo per metà, mi obbligò con fraterna fermezza a mangiarlo. Con quanta fatica e ripugnanza ve lo potete immaginare. Di lì a poco ebbi l’impressione di essere perfettamente guarito dalla dissenteria. E, grazie a quel pezzo di pane, lo fui veramente. Il dolore al fianco mi durò ancora per alcuni giorni, ma ero salvo. Un atto di carità può essere davvero prodigioso!

Il campo farnigerato
La nostra quarantena terminò, prima del previsto, il 6 gennaio 1945. Una buona parte dei detenuti della baracca 19 venne smistata nelle altre baracche. Noi cinque sacerdoti, venuti da Zwickau e da Flossenburg, fummo trasferiti alla barac ca 26, riservata ai soli sacerdoti, o meglio ai ministri di religione, essendovi anche alcuni preti ortodossi e parecchi ministri protestanti. Dei cinque tuttavia rimasi solo io in quella baracca; gli altri quattro vennero definitivamente destinati alla baracca 28, succursale della 26. Alla 28 erano radunati tutti i preti polacchi. Non potevo fare a meno, nel separarmi dai quattro confratelli, che, pur conosciuti da poco, mi erano tanto cari, di constatare come la vicenda della mia prigionia e deportazione non fosse che un continuo farmi amici per doverli poi lasciare più o meno presto, e nella mia ultima destinazione restar solo, avendoli perduti tutti, e così ricominciare da capo come fossi al mio primo giorno di internamento. Un po’ come la nostra vita, fatta d’incontri e di distacchi, che si alternano successivamente fino alla solitudine assoluta, la morte. Con debite riserve in confronto fra passato e futuro, per me l’entrata alla baracca 26 fu come l’entrata in paradiso! Ma prima di parlare delle accoglienze liete fattemi, credo opportuno dare una particolareggiata descrizione del famigerato campo di Dachau. Tra i Lager tedeschi quello di Dachau era certamente uno dei più famosi. Nella prima edizione di questi miei ricordi ne ho data una descrizione sommaria. Ora posso disporre di una breve ma preziosa pubblicazione sullo stesso campo. L’autore vi fu internato dal 12 luglio 1941 al 24 aprile 1945, tedesco, sacerdote, attualmente vescovo ausiliare di Monaco: mons. Johann Neuhàusler, di cui ho già fatto cenno. Egli ha scritto un volumetto denso di notizie e referenze documentarie, servendosi di pubblicazioni fatte da ex-internati, particolarmente di quella del polacco Jan Domagala, Die durch Dachau gingen (Coloro che passarono per Dachau) e di quella di Franz Goldschmitt, Zeugen des A bendlandes (Testimoni dell’Occidente). L’opuscolo di mons. Neuhàusler si intitola So war es in Da chau (Così era a Dachau). E’ uno scritto sereno, obbiettivo, documentato. Al titolo, variato nell’interno (Wie war das in Dachau? - Come era a Dachau?), l’autore aggiunge: Un tentativo di avvicinarsi alla verità; perché molte cose ancora del famigerato campo, egli osserva, rimangono misteriose. Da questa fonte ricavo i particolari che non ho potuto conoscere personalmente. Il campo di Dachau fu il primo dei campi di concentramento costruiti in Germania appena salito al potere il nazismo con Hitler e compagni. Fu ordinato dallo stesso Himmler, allora presidente commissariale di polizia della città di Monaco (Baviera), poi capo delle SS di tutta la Germania. Egli ne annunziò l’apertura il 21 marzo 1933 con la seguente comunicazione, pubblicata dal Munchner Neuesten Nachrichten: «Mercoledì 22 marzo 1933 nelle vicinanze di Dachau si aprirà il primo Lager di concentramento. Ha la possibilità di capienza di 5.000 uomini. Abbiamo adottato queste misure senza tener conto delle opposte osservazioni di poco rilievo, persuasi di agire così per la tranquillità e secondo il desiderio della popolazione civile di tutta la nazione. Heinrich Himmler». Si noti che il Lager fu preparato non per i prigionieri di guerra oi ribelli politici di altre nazioni, ma per i tedeschi che avessero avversato il nuovo regime nazista. Il campo distava da Monaco circa 18 chilometri e 4 circa da Dachau. Ho già descritto la bella strada che vi conduceva, tutta asfaltata, e il massiccio fabbricato, con sottopassaggio all’entrata, il quale serviva di abitazione alle SS, con i rispettivi uffici di direzione e amministrazione del campo. Tutto il campo formava un rettangolo di circa 300 metri di larghezza e 600 di lunghezza. Un alto muro lo recingeva ai quattro lati. Oltre il muro del lato settentrionale si estendeva una specie di parco, egualmente cintato e riservato alle SS, senza alcuna comunicazione col campo. Una pa rte di questo era adibito a magazzino di guerra e depositi di benzina. Lungo il muro di cinta sorgevano, ogni cento metri circa, alte e massicce, le torrette delle sentinelle. Nell’interno, tra il muro e le baracche, vi era uno spazio libero che serviva anche da strada, un fossato con acqua alta più di mezzo metro e finalmente un filo spinato con la corrente ad alta tensione. Innanzi, all’edificio posto sull’entrata si estendeva una vastissima piazza - forse quattro volte quella del duomo di Milano -. Sul lato destro di essa, oltre il salone delle docce, erano sistemate le numerose baracche per magazzini e laboratori d’ogni genere. Alla sinistra, invece, si staccava un largo viale alberato, ai due lati del quale si allineavano, in profondità, le baracche di abitazione. Erano circa una trentina, segnate con numero progressivo pari o dispari secondo che si trovavano sulla sinistra o sulla destra. Il viale delle baracche terminava su una piazza, meno vasta della prima, oltre la quale c’era un orto riservato alle SS, alcune baracche per donne deportate o per l’allevamento di animali da pelliccia e d’esperimento. Tornando alle baracche del viale, le prime due del lato sinistro erano adibite a biblioteca e a servizi vari; le prime cinque del lato destro, invece, fungevano da infermeria, detta in tedesco - quasi per ironia - Revier (Riviera)! Le baracche di abitazione erano lunghe circa 100 metri e larghe dieci, disposte di fianco, sul viale. La piazzetta che si stendeva fra le baracche era chiusa verso il viale da un alto cancello, di modo che ognuna di esse, con la rispettiva piazzetta, formava prigione a sé, né vi si poteva entrare od uscire senza il permesso del capo-baracca. Ancora. La baracca era divisa internamente in due parti, ciascuna con ingresso proprio. Ognuna delle due parti conteneva due camerate, cui si accedeva subito dopo l’ingresso. Fra le due camerate, in un locale abbastanza grande, vi erano i servi zi, comuni alle due parti. Le camerate, a loro volta, constavano di due stanzoni, uno per il soggiorno e l’altro per dormire. Mi dispenso dalla descrizione più minuziosa dei mobili esistenti nella stanza di soggiorno, come del tavolo, della stufa, degli armadietti per ripostigio degli oggetti personali. Ogni internato aveva una gamella militare per il rancio e una posata cori un armadietto a sua disposizione. Nel complesso si può dire che a Dachau le baracche erano costruite a regola d’arte, tanto che, a guerra finita, il governo tedesco se ne servì per dare alloggio ai profughi dei Sudeti e della Germania Orientale. Ottimi pure i servizi con abbondante acqua corrente. Ma nonostante la parvenza di cittadina rurale che rendeva, fino a un certo punto, meno triste il campo di Dachau, la sua fama di Lager di eliminazione, di Lager della morte, era ben meritata, come e più di quella di Mauthausen e di Buchenwald. Il bel viale e le belle baracche, le piccole comodità e qualche raro sollievo non ingannavano nessuno. Esisteva anche a Dachau quando io vi fui ospite, il cosiddetto Bunker (il carcere nel carcere) per gli internati speciali; esistevano e funzionavano le Dunkelzellen (celle oscure) e le Stehzellen (dove non si poteva stare se non in piedi). In esse fu rinchiuso per parecchio tempo il Neuhàusler e, a quanto si diceva, il vescovo di Clermont-Ferrand. Appena fuori del campo di concentramento, quasi nascosti fra gli alberi su una collinetta deliziosa, ben sei forni crematori lavoravano senza interruzione. Accanto sorgevano le camere a gas per far morire i vivi e i sani. Il crematorio constava di cinque stanze, una in fila all’altra e intercomunicanti. Nella prima i candidati alla morte erano raccolti in attesa; nella seconda venivano spogliati per la doccia; nella terza venivano ermeticamente rinchiusi: allora si aprivano numerosi rubinetti di gas e i poveri disgraziati vi mo ;rivano d’asfissia; nella quarta si accumulavano i cadaveri, e nella quinta venivano bruciati. I condannati a morte venivano illusi col far loro credere che andavano a fare una doccia e uscivano cenere! Durante la mia permanenza nel campo non potei, né volli subito dopo la mia liberazione, visitare quel triste luogo, ma sette anni or sono, recandomi a Monaco per una speciale missione, feci visita a Dachau e, mio malgrado, fui trascinato al crematorio. Vidi le bocche orrende dei forni, le camere a gas, l’albero delle impiccagioni, il muro delle fucilazioni, il fosso in cui si raccoglieva il sangue... Ritornai pentito della visita a quel luogo, di cui ancor oggi incancellabili mi restano il ricordo e la terrificante visione. Non per nulla i tedeschi, a guerra finita, avrebbero desiderato far scomparire subito quella terribile testimonianza della crudeltà nazista, ma ne furono impediti dagli americani occupanti. Non posso accertare se, nel tempo della mia permanenza a Dachau, gli internati fatti morire nelle camere a gas fossero numerosi, o se quel sistema di liberarsi dai prigionieri indesiderati fosse ormai solo il ricordo di un recente o lontano passato; ma era voce comune che continuasse ad essere applicato. Quanti poi siano periti, nelle diverse maniere, in quel campo famigerato, dalla sua fondazione alla fine della guerra, Dio solo lo sa. Il pastore protestante Niemòller, che pure fu internato in questo campo, narrò all’amico e compagno di prigionia mons. Neuhàusler che in una visita da lui fatta al crematono non molto dopo la liberazione, aveva visto appesa a un albero una tavoletta di legno con la scritta: QUI NEGLI ANNI 1939 - 1945 FURONO BRUCIATE 238.756 PERSONE. Non sono in grado di assicurare se questa cifra corrisponda al numero reale delle vittime immolate, ma dopo le rivelazioni dei giornali sulle prodezze di Eichmann non resta affatto incredibile. Eppure gli internati a Dachau, salvo qualche eccezione, non era no israeliti, ma europei o senz altro tedeschi, e tuttia avevano una famiglia, una patria, una civiltà da amare e difendere; tutti, tedeschi o meno, figli di Dio. Un particolare notai fin dai primi giorni, e cioè che gli internati a Dachau erano vestiti abbastanza decentemente, con berretti in capo e scarpe ai piedi. Di più, a loro disposizione v’era una baracca apposita destinata a biblioteca, dotata abbondantemente di volumi in diverse lingue, alcuni dei quali anche di una certa importanza scientifica e letteraria. Vi si poteva accedere liberamente in determinate ore ed anche asportare libri. Tutto considerato, il campo lasciava l’impressione di una perfetta organizzazione. Tutto si svolgeva con ordine e impeccabile regolarità. Le SS non comparivano che di raro per i viali e nelle baracche. Al funzionamento e all’ordine del campo provvedevano i capo-baracca e i loro aiutanti. V’era anche un corpo speciale di poliziotti, scelti fra gli internati stessi, tra cui anche qualche sacerdote che accettava un simile ufficio, per essere più facilmente di aiuto agli internati. L’alta sorveglianza era, tuttavia, nelle mani delle SS che, nelle adunate generali o nelle spedizioni fuori campo, erano sempre presenti, armate di tutto punto. Incontrandole sia in pubblico che in privato, bisognava togliersi il berretto e salutare militarmente. Era ormai famoso l’ordine secco dei capo-baracca, quando compariva una SS in piazza per gli appelli o per il controllo: Mùtze ab! (giù il berretto). Una volta poco mancò non mi buscassi non so quale grave punizione. In un momento di libertà passeggiavo, tutto solo, per il grande viale, quando vidi comparire innanzi all’improvviso una SS con il capocampo. Avrei dovuto, come prescritto, togliermi il berretto e mettermi in posa di saluto militare. Non so come, io che sono sempre piuttosto rispettoso ed ossequiente all’autorità comunque costituita e per natura piuttosto portato ad abbondare che a mancare in queste cose, in quel momento fui preso da un senso di naturale ribellione al dovere e rifiutai il saluto all’aguzzino di tanti poveri sventurati, e finsi di non accorgermi di lui. Il capocampo mi fermò irritatissimo e in tono aspro mi comminò l’arresto immediato. Tuttavia non fece nulla e mi lasciò alle mie contemplazioni. Invero, ripensandoci, mentre credevo di compiere un gesto di fierezza, dovetti constatare d’aver mancato di carità evangelica, che prescrive di amare quelli che ci perseguitano, e alla perfetta letizia francescana che fa gioire sopportando per amor di Dio... Varie erano le occupazioni nell’interno del campo. Oltre ai diversi servizi di cucina, di pulizia alle baracche e ai viali, bisognava pure attendere ai macchinari di alcune piccole officine. Molti degli internati erano addetti alla coltivazione degli orti, all’allevamento dei conigli e dei porcellini d’india. Fra questi ultimi era impegnato anche un cappuccino di Vienna, un certo p. Eberhard, di cui parlerò più avanti. Fuori campo si lavorava nelle vicine campagne, impegnati a dissotterrare patate, che i tedeschi, producendone in grande copia, conservavano sepolte in fosse scavate nella libera campagna. Ma il lavoro più pesante si compiva alla stazione ferroviaria e nel centro della città di Monaco, distante circa diciotto chilometri, caricando e scaricando vagoni, demolendo case in rovina, portando pesi talvolta impossibili, sgombrando le vie dalle macerie, spesso sotto l’infuriare dei bombardamenti. Quanti lasciarono la vita in queste ingrate e micidiali occupazioni! A questi lavori pesanti i sacerdoti non venivano costretti. Molti però vi andavano spontaneamente per essere d’aiuto ai compagni morenti. A cavar patate invece andavano tutti volentieri nella speranza di poterne sottrarre qualcuna da far cuocere poi e consumare nella baracca. Ma era questo un rischio molto grave, perché, se si ven iva scoperti, erano diluvi di bastonate o punizioni anche peggiori. Io, dopo la malattia, fatta alla baracca n. 19, sentendomi troppo debole, col beneplacito del capo-baracca, rimasi nella Stube tranquillo, passando il mio tempo a leggere o recandomi a pregare in cappella.
Tra i partigiani di Dio
Forse qualcuno, a sentir nominare i partigiani, arriccia il naso disgustato. Ma vi sono partigiani e partigiani. Partigiani del primo momento e partigiani dell’ultimo, a liberazione compiuta, che a Milano si direbbero gli eroi della sesta giornata. Partigiani semplicemente per salvare la pelle e partigiani generosi per salvare la patria e la libertà. Partigiani violenti, sanguinari, ladri, assassini, che presero volentieri l’occasione di cammuffarsi da patrioti per far d’ogni erba fascio da veri delinquenti; e partigiani onesti, disinteressati, pronti a dare la vita per salvare il prossimo. Partigiani che, invece della patria, amavano il partito al quale appartenevano; invece di militare sotto la bandiera nazionale, levavano alta la bandiera rossa del comunismo; invece di combattere per la libertà invocavano l’avvento di una schiavitù peggiore di quella incombente, il dominio di uno straniero più barbaro di quello che già ci stava sul collo. E vi furono anche «i partigiani di Dio». E’ questo il titolo di un libro uscito in lingua slava e tradotto in tutte le lingue d’Europa, brillante e impressionante. Chi erano questi partigiani? Erano quelli che al di sopra delle mischie fratricide, fra gli orrori delle persecuzioni civili e religiose, di fronte allo spavaldo paganesimo risorgente e al crasso materialismo distruttivo d’ogni senso umano e cristiano, tennero alti i valori dello spirito, la fiamma della fede e della umana fraternità. In mezzo ai popoli oppressi, o sotto la divisa del combattente o del clandestino, questi partigiani, espone ndo ogni momento la propria vita, come già i primi cristiani, vivevano, operavano, soffrivano col pensiero a Dio e al suo Regno d’amore, la Chiesa di Cristo. Numerosi e meravigliosi gli episodi descritti. Tra i coraggiosi «partigiani» dei quali narra questo libro emerge per primo lo stesso autore, un sacerdote jugoslavo, navigato nella vita e coraggioso fino alla temerità. Arruolatosi clandestinamente coi partigiani come medico, senza laurea, ma pratico di medicina e in tal veste, negli ospedali, nelle caserme, presso i comandi militari, nei tribunali e nelle prigioni, nella sua patria, in Cecoslovacchia, e perfino in Russia, si fece tutto a tutti come S. Paolo per guadagnare tutti a Cristo, finchè, dubitandosi della sua identità, fu egli stesso chiuso in prigione e torturato in mille modi, salvandosi infine miracolosamente per merito di altri «partigiani di Dio». Di questa stoffa erano certamente più o meno tutti i sacerdoti che io trovai quel giorno 6 gennaio 1945 alla baracca n. 26, nel campo di Dachau. Tutti potevano dirsi altrettanti «partigiani di Dio», perché non la politica, non il semplice nazionalismo o partitismo, ma idee e azioni ben più alte e nobili avevano condotto all’internamento quella schiera di ecclesiastici d’ogni grado e nazionalità. Io mi tenni onorato di entrare, senza mio merito, in loro compagnia. La festa che tutti mi fecero fu commovente. Tedeschi, franceso, belgi, croati, ungheresi, romeni, austriaci, cecoslovacchi mi accolsero come fossi uno dei loro, un loro fratello; ma soprattutto gli italiani mi circondarono ed abbracciarono con grande effusione di affetto. Fu per me una rivelazione. E’ ben vero che un proverbio latino dice: «Solatium miseris socios habere poenantes» ossia è un sollievo per i sofferenti aver compagni di dolore, ma più che la comune sorte di pena, mi parve che ci unisse il vincolo della stessa fede, l’essere figli e sacerdoti della stessa Chiesa. Forse n on mai come a Dachau compresi il sublime significato delle parole del Credo: Unam, Sanctam, Catholicam ed Apostolicam Ecclesiam... La Chiesa era presente nella sua svariata magnificenza: dal vescovo all’ultimo curato di campagna, dal povero cappuccino all’abate di famose abbazie, dal cappellano delle carceri al professore d’università, al grande conferenziere, al compositore di musica, all’organizzatore dell’Azione Cattolica, al fondatore di opere benefiche e sociali; zelo apostolico, santità di vita, sapienza di governo, profondità di studi, attività religiosa d’ogni genere, fortezza di ardimento pastorale erano degnamente rappresentati in quella veneranda schiera di ecclesiastici, come non mai in nessun congresso o adunanza, fuori di Roma. Anche in questo il governo nazista involontariamente si prestò alla Provvidenza, strumento a più intima conoscenza fra il clero cattolico europeo, che vedeva spuntare, nel dolore del campo, la luminosa alba ecumenica della Chiesa. Non posso qui esimermi dal ricordare alcuni nomi, già noti fin d’allora all’estero e nel dopo guerra assurti ancora a maggior fama. Riporto integralmente l’elenco dei sacerdoti italiani presenti con me a Dachau. In confronto degli stranieri, eravamo pochi, solo perché i nazisti, per la difficoltà dei transiti alpini battuti e rovinati dall’aviazione alleata, si videro costretti a trattenerli in prigioni italiane. Dopo di me, non ne giunsero che tre o quattro ancora, provenienti dal Veneto. Devo mettere il mio nome a capolista, semplicemente rispettando l’ordine alfabetico e come figurava nell’elenco del caporale Franz il giorno della nostra partenza da Milano. Premetto pure che non tutti i sacerdoti qui elencati erano nella mia stessa camerata, la seconda, ma in quelle accanto, rispettivamente terza e quarta, e alcuni in altre baracche, tuttavia sempre nello stesso campo di Dachau. 1 Agosti p. Giannantonio, cappucc ino, enitenziere per le imgue estere nel duomo di Milano; 2 Aldregretti don Lodovico, arciprete di Soave - Vernna; 3 Angeli prof. don Roberto, parroco di S. Jacopo, professore al seminario Livorno; 4 Bellotto don Giacomo, pievano di Meduno, diocesi di Concordia, Belluno; 5 Berselli don Costante; Curia vescovile di Mantova; 6 Bonzi don Mauro, rettore del collegio Pio XI di Desio, Milano; 7 Campi don Andrea, professore nella scuola governativa, Genova; 8 Crovetti don Mario, parroco di Ronciscaglia, Modena; 9 D’agostini don Enrico, parroco di Campofrrmido Udine; 10 Dalmazzo don Angelo, parroco in citta - Cuneo; 11 Elli don Giuseppe, cappellano delle carceri, Bologna; 12 Fabbro don Albino, parroco di Vendoglio, Udine; 13 Foglia don Francesco, parroco di Moncenisio, Torino; 14 Fortini don Giovanni, parroco di S. Gaetano in Terra Negra, Padova; 15 Girotti p. Giuseppe, domenicano, scrittore, Torino; 16 Grazioli don Mario, profrssore, parroco di Canolo, Reggio Emilia ; 17 Liggeri don Paolo, direttore della Cardinal Ferrari, Milano; 18 Manziana p. Carlo, superiore dei Filippini della Pace, Brescia; 19 Marini don Eugenio, parroco di Moron, Udine; 20 Neviani don Ezio, cappellano dell’ospedale di Correggio, Reggio Emilia; 21 Paternò don Pietro, parroco di Vivastrio, Sarsina, Imola; 22 Pedrotti don Guido, cappellano degli Italiani, Bolzano; 23 Pinamonti p. Luigi, professore, superiore, degli Oblati di Maria, Chiavari; 24 Posch don Rodolfo, giornalista, direttore delle «Dolomiten», Bolzano; 25 Seghezzi don Antonio, segretario dell’Azione Cattolica, Bergamo; 26 Tavasci don Giovanni, parroco di Piuro, diocesi di Como, Sondrio; 27 Valotta don Camillo, parroco di Frontale di Sondalo, diocesi di Como, Sondrio; 28 Vismara don Agostino, segretario Unione Missiona ria, Bergamo. Come è facile rilevare, questi sacerdoti, eccettuato il prof. don Roberto Angeli di Livorno, sono tutti dell’Alta Italia. I sacerdoti dell’Italia meridionale, incriminati dai tedeschi, o caddero presto sotto il dominio degli alleati e furono liberi, o furono addirittura passati per le armi dalle SS. Degli elencati, due morirono nel campo, come dirò più avanti: padre Girotti e don Segrezzi; tre morirono dopo il ritorno in patria: don Elli, don Paternò e don Bonzi, ai quali s’aggiunse più tardi anche don Posch di Bolzano; tutti gli altri, che io sappia, sono ancora vivi e ricoprono cariche ed uffici d’importanza o sono attivi nella cura delle anime e dell’apostolato. All’elenco dei sacerdoti italiani aggiungo almeno il nome di alcuni distinti sacerdoti stranieri: mons. Piquet, vescovo di Clermont-Ferrand (Francia); mons. Beran, divenuto, dopo la liberazione, arcivescovo di Praga, e in seguito tanto perseguitato dai comunisti; p. Riquet, gesuita francese, attualmente predicatore di Nòtre Dame de Paris; Reinhold Friedrichs di Mùnster i.W., capo-blocco, ora monsignore di quella cattedrale; mons. Otokar Svec. della metropolitana di Praga e già segretario del Nunzio Apostolico mons. Ritter. Vi era pure un arcivescovo greco ortodosso col suo segretario. Come ognuno vede, la nostra baracca era eminentemente internazionale; eppure si viveva tutti come in una sola famiglia.
Intimità sacerdotali
La nostra vita in baracca era fraternamente serena e pia, come si addice a sacerdoti, e talvolta quasi allegra. Se non ci fosse stata la fame, specialmente per noi italiani, e non avessimo avuto la preoccupazione dell’avvenire, poteva sembrare di trovarci a un convegno internazionale di sacerdoti, con relative pratiche religiose, ore di studio e di discussione. Già dissi che nella baracca n. 26 vi era una cappella, dove ogni matti na si celebrava la santa messa. Era stata concessa ai preti tedeschi; ma, sopravvenuti sacerdoti anche di altre nazionalità, serviva per tutti. Nonostante fosse consentita una messa sola, si trovò il modo di celebrarne un’altra: la prima per quelli che si recavano al lavoro, la seconda per coloro che, dopo l’appello, tornavano in baracca. Erano davvero edificanti la pietà e il fervore di quella moltitudine di sacerdoti, presenti alle due messe, e tanto sentita da tutti la pena di non poter celebrare. In realtà ci si alternava per turno all’altare, ma non tutti ebbero la buona occasione. Io lo potei solamente il giorno dopo la liberazione, all’arrivo degli americani, e in certe circostanze. Inoltre vi si tenevano prediche, conferenze, discussioni teologiche e scientifiche. In determi nati giorni, specialmente la festa, quando erano liberi anche i preti lavoratori, dopo le funzioni la cappella si convertiva in un’aula universitaria o meglio in una sala di congresso internazionale. Vi si parlavano tutte le lingue ma si riassumevano poi in latino le diverse relazioni. Un giorno un dottissimo sacerdote, professore di sacra Scrittura all’Università di Praga, ci mise al corrente delle più recenti scoperte nel campo dei manoscritti biblici. Un altro giorno un professore del seminario di Metz, conferenziere brillante ed arguto, ci intrattenne sull’ipnotismo, esibendosi anche in alcune esercitazioni pratiche. Un sacerdote di Parigi ci tenne un’ampia relazione sull’organizzazione cattolica dei medici francesi. Don Paolo Liggeri, direttore dell’Opera Cardinal Ferrari, ci illustrò le origini e le attività benefiche della grande e originale istituzione, in Italia e all’estero. Ricorrendo l’anniversario della elevazione al trono pontefi cio di Pio XII, si tenne addirittura un solenne pontificale, celebrante il vescovo Piquet, con un coro magnifico di sei o settecento sacerdoti, tra cui molti professori di musica e canto. U n sacerdote lesse in latino un meraviglioso panegirico sul Santo Padre, che commosse tutti. Si diedero anche concerti di musica sacra, specialmente dei nostri classici italiani, come Palestrina, Casciolini, P. Martini, eseguiti sul grande armonium di cui era dotata la cappella. Alla baracca n. 26, però, bisognava fare tutto con molta prudenza e circospezione. Se le SS fossero venute a conoscenza di quanto vi si svolgeva, sarebbero stati certamente guai seri e gravi. Perchè tutto si svolgesse nella massima segretezza, data l’imponenza delle manifestazioni e il numero dei partecipanti, bisognava disporre la cappella in modo che al primo allarme tutto si potesse troncare e nascondere. Anche il celebrante e i rispettivi parati sospendevano ogni cosa in un istante e si mostravano come semplici internati intenti a qualche normale lavoro. Ad evitare sorprese durante le sacre funzioni, convegni o trattenimenti, due sacerdoti erano normalmente di guardia, uno al cancello che metteva sul viale e l’altro nella piazzetta, alla porta della baracca. Il segnale convenuto dal primo al secondo, in caso di pericolo o di sospetto, era subito trasmesso in cappella. Così fu possibile non essere mai scoperti. Non solo però nella cappella, ma anche nel campo questa specie di vita catacombale doveva essere osservata. Anche a Dachau, come dissi parlando della comunione di Natale, era proibita ogni assistenza religiosa. Ciò non di meno si esercitava in pieno, di nascosto, senza suscitare sospetti. In questo si distinsero sopra tutti i sacerdoti polacchi e italiani. L’accordo fra tanti sacerdoti di così diverse nazionalità poteva dirsi perfetto. Non si parlava mai di politica, e molto meno di questioni religiose coi pastori protestanti o con i preti ortodossi. Soltanto un tedesco, una volta, rivolse a noi italiani il titolo di «badogliani», che egli forse credeva offensivo. Un’altra volta, certo perché deperivo ogni giorno più ed er o diventato nervoso, sentendo affermare, ancora da un tedesco, che la Germania era assai più civile dell’Italia, lo rimbeccai dicendo: vale più un pastore delle montagne di Sardegna che un vostro principe a Berlino; e la dimostrazione siamo noi e voi qui nel campo di concentramento. Ma in compenso di questi due unici casi di vicendevole punzecchiatura, che ovviamente non compromisero i nostri buoni rapporti, dei sacerdoti tedeschi potrei citare numerosi episodi di vera bontà e generosità di cuore. Non so se ho detto altrove che noi italiani, in tutto il tempo del nostro internamento, salvo qualche rara eccezione, non ricevevamo mai un pacco di qualunque genere. E sì che al ritorno, parenti e amici ci dissero di averne mandati non pochi. I tedeschi, invece, come i francesi e i polacchi, ne ricevevano con una certa frequenza. Era forse la vendetta di Hitler contro i «traditori italiani?». Non lo saprei dire. Comunque, la proibizione creava un certo imbarazzo in tutti, specialmente fra i sacerdoti tedeschi. Ma per solito la penosa differenza tra noi e loro dava origine a stupendi atti di carità. Ricorderò sempre quel sacerdote tedesco, il quale, ricevendo dei pacchi, ne faceva assai volentieri parte con uno di noi italiani, cambiando ogni volta la persona beneficata. E mi commosse ancora quel caro vecchietto tirolese, della valle dell’Inn superiore, al quale i parrocchiani ogni tanto inviavano un pacco molto ben fornito. Il buon sacerdote allora, felicissimo, ne chiamava quanti ne poteva attorno a sè e divideva quasi tutto, trattenendo soltanto una minima parte. E già che parlo di mangiare, mi si permetta di raccontare un tiro allegro ma un po’ biricchino, del quale io stesso fui complice. Il p. Luigi Pinamonti, degli Oblati di Maria - religioso pio e dotto e nativo, come me, della valle di Non - usciva tutti i giorni dal campo per lavorare volontario alle patate e ogni tanto riusciva a trafugarne due o tre, che poi cu oceva nella stufa e mangiava con vero godimento. Era un rischio, perché se fosse stato scoperto le SS gliele avrebbero fatte pagare care. Don Camillo Valotta era incaricato di attendere ai ripostigli della camerata e alla distribuzione del rancio di mezzogiorno: una sgradevole brodaglia che nessuno accettava oltre la misura della propria gamella. P. Luigi invece, poco interessato alle esigenze del gusto ma molto preoccupato di quelle dello stomaco, accettava assai volentieri gli avanzi degli altri e ne prendeva due o anche tre gamelle. Ebbene, che gli combinò don Camillo? Un giorno venne da me e mi disse: «P. Giannantonio, ci sta a fare un tiro a p. Luigi?» «E perché no?» «Ecco, io so dove tien nascoste due patate: le facciamo cuocere e le mangiamo; una lei e una io». «Ma... e p. Luigi?» «Gli darò una minestra in più» «Allora benissimo». Detto fatto. Quando la sera p. Luigi torna dal lavoro, cerca le sue patate e, non trovandole, corre da don Camillo. «Don Camillo, mi hanno rubate le patate!» «Davvero? Sono costernato! Però se le avesse date in custodia a me, nessuno gliele avrebbe toccate». «Beh! beh!», commenta rassegnato p. Luigi; per due patate non me ne importa. La settimana dopo don Camillo ripete lo scherzo e quando la sera il p. Luigi nuovamente si lamenta con lui, da ladroncello consumato gli fa notare: «Non te l’ho già detto che le dovevi dare in consegna a me se volevi ritrovarle?» Alquanto insospettito ma sempre calmo il p. Luigi commenta: «Vedremo al giudizio universale chi è stato il ladro delle mie patate!» Ma l’ha saputo prima e posso assicurare che ha già anche perdonato ai due complici, senza nemmeno l’obbligo della restituzione. In febbraio scoppiò nel campo un terribile tifo petecchiale, che mieteva ogni giorno da cinque a seicento vittime. Il nostro capo-baracca propose ai sacerdoti più giovani di prestarsi in qualità di infermieri. Come tali avrebbero potuto entrare e rimanere in qualunque baracca e n ella stessa infermeria. Quasi tutti accettarono di buona volontà. Mi prestai anch’io coadiuvato però da un altro più giovane, trovandomi malandato. Tutte le baracche ebbero così uno o più cappellani, che tutto osavano, ma con somma prudenza se non si voleva fallire nella santa missione. In questo fu possibile assistere e confortare con i SS. sacramenti un buon numero di moribondi. Molti di questi generosi sacerdoti, nonostante che la nostra baracca non fosse colpita dal terribile morbo, morirono contagiati assistendo con alto senso di sacrificio ed eroismo i poveri internati. Da notare che durante la gravissima epidemia nulla era mutato riguardo al trattamento alimentare; anzi si andava lentamente diminuendo e peggiorando il misero rancio quotidiano, per cui o di tifo o di fame, la morte per tutti non sembrava tanto lontana. Eravamo completamente esausti e paurosamente invecchiati. Io riuscivo a raggiungere con difficoltà la piazza per l’appello. Di notte non dormivo che pochissimo. Anche il buon umore, che avevo sempre cercato di conservare, mi abbandonava a poco a poco. Nella persuasione che difficilmente sarei sopravvissuto, procuratomi un pezzo di carta scrissi tre lettere: una al mio padre provinciale, una a mia sorella suor Salvatrice missionaria in Cina ed una ai miei nipoti residenti a Milano. Era un po’ come l’ultimo saluto che davo loro e il mio testamento spirituale. Consegnai le tre missive, semplicemente arrotolate, al giovane prete valtellinese don Camillo Vallotta. «Senti, don Camillo», gli dissi, «tu sei giovane e potrai certamente resistere e uscire incolume da questo tormento; io no, sono troppo vecchio. Se rivedrai la nostra bella patria fa recapitare agli interessati questi ultimi scritti». Vorrei tornare nella cappella di Dachau e vivamente ringraziare il Divin Prigioniero, che, più potente delle SS, non permise allora che questo povero frate rimanesse vittima in quel c ampo. Così le tre lettere mi vennero restituite al nostro ritorno.
«Guardate, o stelle, un poco sulla terra!»
Durante i mesi di gennaio e febbraio 1945 nulla accadde di particolare nel campo che portasse mutamento alle nostre condizioni, se non peggio. Notizie confuse dicevano che la Germania stava per riprendersi con potenti controffensive, specialmente sul fronte occidentale. Il giornale nazista Der Volkische Beobachter, che le SS lasciavano facilmente girare fra gli internati, nel suo numero di Capodanno aveva salutato euforicamente il 1945 come l’anno della vittoria tedesca. Un complesso di cose pareva dar ragione al giornale. Naturalmente ciò per noi significava essere definitivamente perduti. Anche solo il prolungarsi della guerra ci sarebbe riuscito fatale, consumandoci giorno per giorno colla fame e le malattie. Ma verso i primi di marzo la situazione cambiò rapidamente. I dirigenti del campo divennero nervosi, diffidenti, preoccupati. Sospettavano che gli internati stessero organizzando delle ribellioni. Particolarmente temevano di noi sacerdoti. Una notte, circa l’una, fummo svegliati di soprassalto e cacciati mezzo nudi fuori baracca. Erano venute d’improvviso le SS a fare una ispezione per scovare armi che dicevano avessimo nascoste. Non trovarono nulla. Un’altra volta ci aduranarono tutti sulla piazzetta e una SS ci passò uno per uno, scrutandoci lungamente in faccia. Voleva trovare il delinquente che il giorno avanti si era reso colpevole di un fatto gravissimo. Un sacerdote infatti percorrendo il grande viale, aveva scorto un poliziotto del campo maltrattare bestialmente un internato. Egli non ci vide più. Corse in aiuto del malcapitato, afferrò il poliziotto e lo schiaffeggiò, gettandolo per terra e strappandogli di mano il povero compagno. Non fu subito riconosciuto dal poliziotto; per questo ora egli, a ccompagnato dalle SS, era venuto per identificarlo. Ma non lo seppe distinguere. Però il sacerdote a evitare un castigo collettivo, si presentò spontaneamente. Era un francese. Fu processato, ma ebbe pochi giorni di arresto. In altri tempi sarebbe stata certamente la fucilazione. Altro segno che le cose stavano mutando. Ma l’indice più certo che gli avvenimenti precipitavano era il continuo afflusso a Dachau di convogli, ossia di Transport dai campi della Germania nord-occidentale. Con l’avanzarsi degli alleati anglo-americani, quei campi venivano fatti sgombrare e gli internati condotti verso l’est, in Baviera o in Tirolo, dove i tedeschi intendevano resistere fino all’estremo. I nuovi arrivati raccontavano apertamente che la sorte della Germania era ormai segnata e che le truppe liberatrici, nonostante gli sforzi del nemico, valoroso e tenace ma esaurito, non erano molto lontane. Una mattina, mentre stavamo lavorando nella cappella, convertita in sartoria, sentimmo dei grossi boati. Sulle prime non si badò. Credevamo fossero delle mine fatte saltare in qualche cava di sassi oltre le colline che circondano Dachau, ma i colpi continuarono il giorno dopo e per parecchi giorni di seguito. Nel campo si propagò la voce che erano i cannoni degli alleati, i quali si trovavano nelle vicinanze di Norimberga. I cannoneggiamenti cessarono per una decina di giorni, poi ripresero più violenti e più vicini. Ormai non c’era dubbio: la gigantesca battaglia si spostava rapidamente verso di noi e aveva per obbiettivo la capitale della Baviera, Monaco, e l’aggiramento del Tirolo, per poi marciare su Vienna. L’8 aprile vissi una giornata che sembrava il finimondo. Durante il mattino erano giunte parecchie migliaia di internati da altri campi; si parlava di otto o diecimila. Io fui comandato di andare in piazza per l’immatricolazione degli italiani. L’immensa piazza era affollatissima e lo spettacolo era impressionante. Una buona metà dei nuovi arrivati giacevano per terra, incapaci di levarsi; molti i moribondi. Quelli che stavano in piedi sembravano scheletri ambulanti coperti di stracci, non pochi erano mezzo nudi. Mi sedetti a un tavolo e invitai gli italiani a venire da me. Il primo che si accostò diede un grido di sorpresa: «Oh! Padre Giannantonio!». Era uno di quelli che erano partiti con me da Milano e rimasto in mia compagnia fino a Flossenburg. «Da dove vieni?», gli chiesi. «Da Hersbruck». «In quanti siete?» «Qui siamo una trentina». «Quanti eravate a Hersbruck?» «Cento e ottanta circa». «Vi furono dei morti in quel campo?» «Molti, tra cui l’Olivelli». «Olivelli morto?» «Si, morto». «E in quanti sieti partiti con questo Transport?» «Circa un centinaio». «E dove sono gli altri?» «Morti in viaggio. Siamo partiti a piedi, senza mangiare e lungo il viaggio non ci hanno dato nulla. Ogni tanto molti restavano indietro e cadevano sfiniti. Le SS li finivano con un colpo di rivoltella». Questo barbaro trattamento fu confermato da altri compagni e da partecipanti ad altri convogli. Non avevo compilato che cinque o sei matricole quando un forte urlo delle sirene annunciò l’avvicinarsi di bombardieri alleati. Questi infatti apparvero improvvisamente a grande altezza, accompagnati dai rispettivi caccia, che volteggiavano sopra il campo. L’artiglieria antiaerea incominciò a sparare rabbiosamente. Caccia tedeschi accorsero da ogni parte e in cielo si accese una violenta battaglia. Al crepitio delle mitragliatrici in alto e ai secchi colpi dell’antiaerea ben presto si aggiunsero i sibili e i boati delle bombe sganciate dai bombardieri, fortunatamente tutte fuori campo. Colossali incendi si svilupparono subito nei dintorni, e il fumo, salendo altissimo, oscurava il cielo. Scena terrificante che durò parecchio e terminò, si disse, con l’abbattimento di due bombardieri e di non so quanti caccia. Noi restammo come impietriti dal terrore. Le SS si erano tutte allontanate per ent rare nei rifugi. L’operazione delle matricole fu sospesa e quanti potevano camminare si ritirarono confusamente nelle baracche. Queste furono così affollate che era impossibile muoversi. Dopo quella battaglia aerea, gli ammalati e i moribondi furono trasportati un po’ dovunque senza distinzione di baracche. Io, andando a visitarli, ne riportai un’impressione paurosa. Erano letteralmente accatastati uno sull’altro nei castelli, sul pavimento, nei corridoi di passaggio, in tutti gli angoli. Mandavano gemiti strazianti, imploravano qualche cosa da mangiare, acqua da bere, medicine. I più giovani invocavano la mamma, altri nominavano moglie e bambini. E poichè molti erano colpiti da dissenteria, il sudiciume regnava dovunque. Io cercavo di incoraggiarli, ma non potevo far nulla per loro. Ai più gravi impartivo l’assoluzione, esortandoli a confidare in Dio. Tutti si mostravano credenti e sensibili alle mie parole; ma non posso esprimere il senso di desolazione che, tornando in baracca, mi opprimeva. Calata la notte, una notte serena e stellata, che potevo contemplare dal vicino finestrone, non riuscendo a dormire, mi vennero spontanee le seguenti strofe, fissate al mattino sul primo pezzo di carta che potei trovare. Le ripeto, non perché valgano qualcosa, ma perché esprimono abbastanza lo stato d’animo di quel momento. Guardate, o stelle, un poco sulla terra, Mentre la notte a voi dà tanta pace. Guardate giù, guardate, se vi piace, Ciò che accade fra noi: l’orrenda guerra. Il bel pianeta, ch’era un paradiso Quando fede e ragion tenean governo, Fatto s’è d’improvviso un grande inferno E gli uomini demòni all’improvviso. Fuoco d’odio nei cuori, ferro e fuoco Sulla terra, sui mari, giù dal cielo. Tutto è rovina, tutto è uno sfacelo, E strage e sangue e morte in ogni loco. Che d’ogni mal precipiti nel fondo Quest’empia umanità cieca e ribelle? Che siano i giorni del giudizio, o stelle? Che l’anticristo sia già noto al mondo?
Un «ribelle per amore»
Ho già accennato al caro Olivelli parlando dei campi di Bolzano e di Flossenburg. Egli era una persona che, una volta conosciuta, si ama e non si dimentica più. Già al primo incontro con lui l’impressione che se ne riceveva era profonda, ma vivendogli accanto quell’impressione diventava ammirazione e venerazione. In vita mia ho incontrato poche persone di così alte doti morali, di virtù così generose, di un fascino spirituale così irresistibile. Tutti coloro che lo ebbero compagno, prima come studente, poi come soldato, infine come prigioniero e internato, furono conquistati dalla sua decisa superiorità intellettuale e morale. Nacque a Bellagio Borgo il 7 gennaio 1916, ma può considerarsi di Mortara, in Piemonte, dove la sua famiglia si trasferì quando egli aveva dieci anni. Iniziati gli studi, si distinse subito per intelligenza e tenacia. Fu allievo dell’oratorio locale, al quale, dopo che allo zio, l’arciprete di Tremezzo, deve la sua formazione cristiana. Dalla sua biografia appare che fu sempre tanto esemplare, primo nelle scuole comunali, primo in collegio, primissimo all’Università di Pavia. Fece parte della gioventù fascista e del GUF, perché tale era l’esigenza del tempo, riportando sempre alti premi, ammirazione dai compagni, lodi dai professori e dirigenti. Ma apparteneva pure alla Gioventù Cattolica, dove si distingueva per lo studio e la pratica religiosa. Nel 1938 si laureò brillantemente in legge. L’anno dopo lo troviamo professore assistente di diritto alla Università di Torino; scrive, fa conferenze, partecipa a convegni scientifici nazionali e internazionali, conoscendo bene diverse lingue. Scoppiata la guerra, partì volontario, diventando un ufficiale brillante e coscienzioso, amante dei soldati, attivissimo e fedele nei suoi compiti militari e cristiani. Avrebbe potuto facilmente esimersi dal ser vizio militare, ma non volle far uso del diritto che ne aveva. Il prof. Camillo Pellizzi, suo presidente, scrive: «Teresio fu volontario come soldato e come combattente. Senza far nulla di indecoroso, avrebbe potuto facilmente esimersi dall’una cosa e dall’altra. Fu anzi pregato di chiedere l’esonero, essendo l’opera sua necessaria a Roma, insostituibile. Rispose: Sarei un vile. Non ho sposato l’ideale: Armiamoci e partite! E quando in un’adunata di personalità si lamentava l’esiguo numero degli universitari volontari, Teresio non temette dire loro: «La colpa èvostra. Voi avete insegnato ai giovani a fare della coreografia, delle comparse fantasmagoriche; non avete plasmato l’anima loro, non avete formato delle coscienze, non avete fatto degli uomini, dei cittadini: avete fatto dei giullari e ora li trovate. Secondo il Dughera fu il pensiero dei morti, l’avvenire dei vivi, l’onore della bandiera, l’amore della patria che spinsero l’Olivelli ad arruolarsi volontario; ma non defletteva dai principi cristiani e dall’accorata invocazione del Papa, che deprecava la guerra e predicava la pace. Venne assegnato al III Reggimento Artiglieria Alpinajulia, Batteria Udine e fu sbalzato da Gorizia ad Aosta, da Lucca a Roma, da Venaria Reale a Merano. Nel 1942, alla fine di luglio, partì per la Russia. Campagna terribile, dove rifulse il suo valore militare assieme al suo profondo senso di umanità e all’inesauribile carità cristiana. Nella tragica ritirata del Don salva molti soldati nostri portando feriti e moribondi al sicuro, dove poter assisterli e curarli personalmente. Furono «2400 chilometri di marcia in quella steppa bianca e sconfinata, sulla neve farinosa, flagellata dal vento gelido e dalla tormenta, fra un combattimento e l’altro che si succedevano quasi ininterrottamente. Eppure mai un naufragio del corpo e tanto meno dello spirito. Sempre dominatore della situazione, sempre in movimento ed in aiuto, sempre sp ezzatore dei cerchi di ferro duramente saldati dal nemico. Egli s’innalza simbolo luminoso della grandezza d’Italia sventurata, dellafrde ai tronfi avvezza». Ritornato in Italia, ebbe una discreta licenza come reduce dalla Russia. Nel frattempo venne nominato rettore del collegio Ghisleri di Pavia, del quale, prima di recarsi in Russia, aveva vinto il concorso. Contava solo 27 anni! Ritornato nell’esercito, fu inviato successivamente a Bolzano, a Merano e a Vipiteno. Qui lo colse l’8 settembre 1943.1 tedeschi, con mossa fulminea, arrestarono lui e tutto il suo presidio. Furono condotti in un campo di concentramento vicino a Innsbruck. Per ben otto volte tentò la fuga. In una riuscì a venire fino a Bolzano, ma fu scoperto e ricondotto in Germania. Un’altra volta, partito da Regensburg, con un viaggio romanzesco attraverso le montagne bavaresi e tirolesi, arrivò in Italia e giunse fino a Milano. Poteva dunque restarsene nascosto e tranquillo ad aspettare la fine della guerra, ma vedendo lo sfacelo e la schiavità dell’Italia, si unf alle formazioni partigiane tra le Fiamme Verdi del bresciano, divenendone la forza animatrice. Fondò «Il Ribelle», foglio clandestino, scritto da lui stesso con spirito di ardente patriota cristiano. Arrestato per l’ottava volta nell’aprile del 1944, fu chiuso in San Vittore a Milano e poi trasferito al campo di concentramento di Fòssoli. Compreso fra i 71 condannati alla fùcilazione, seppe sottrarsi con altri due all’esecuzione, ma non potè fuggire dal campo. Poi condotto a Bolzano, dove lo incontrai la prima volta, tentò nuovamente l’evasione, ma invano: era troppo sorvegliato e portava sul dorso il disco dei fuggitivi: rosso-verde. Già in questo campo, come dice il compagno di sventura Augusto Cognasso di Varallo Sesia, si dava tutto alle opere di pietà e misericordia e costituiva per gli internati il simbolo della patria, il conforto, il sollievo dei dolori fisici e moral i e, per molti, era padre, madre e fratello. E l’amico Bonfanti aggiungeva: «Olivelli si prodigava per tutti. Era lui che andava a chiedere alle SS per gli ammalati. Era lui che si privava del suo scarsissimo cibo per chi ne aveva la sua stessa quantità, ma che, come lui, ne aveva bisogno di più. E l’andare a chiedere alle SS la benchè minima cosa significava sempre, come minimo, pugni e calci. Ma Olivelli era sempre solo lui che chiedeva. E chiedeva sempre, ma mai per lui! Mai Olivelli chiese per sé anche quando ne aveva assoluto bisogno. Tutto per gli altri, per sé mai nulla». Con quale deferenza e particolare rispetto prendesse a trattar me, come sacerdote, fin dal primo nostro incontro, l’ho già narrato a suo luogo. Io trovai subito in questo giovane così religioso, così franco, così cordiale e caritatevole, non solo un amico, ma un vero aiuto nella missione spirituale che sentivo di dover compiere in mezzo agli internati e che si faceva di giorno in giorno più difficile. Un gesto che mi riguarda personalmente dice tutto il suo animo cristiano. Un giorno, dopo la distribuzione della solita razione di pane, mi si avvicina e con tutta semplicità, porgendomi la sua fetta: «La prenda lei, padre», mi disse. «Per me non basta per vivere; per lei, invece, questo pezzetto unito alla sua porzione può essere sufficiente a tirar avanti, perché lei potrà fare ancora del bene a molte anime». Naturalmente non accettai, come non ho mai accettato da nessuno la già misera porzione che a ciascuno toccava; ma lo ringraziai ammirato e commosso dalla sua eroica generosità. Quando passammo a Flossenburg, la sua opera di bontà, di carità e di dedizione per i fratelli italiani - e quando si presentava l’occasione anche per quelli di altre nazionalità - s’intensificò e moltiplicò fino a raggiungere l’eroismo. Questo campo, assai peggiore di quello di Bolzano, presentava tale spettacolo di miseria, di angosce e di morte che l’ani mo sensibile e generoso di Olivelli non si dava pace, se non immolava tutto se stesso per i compagni di sofferenza. Rimase a Flossenburg una quarantina di giorni. Quando venne trasferito in un Transport, al campo di Hersbruck, lasciò a Flossenburg un vuoto incolmabile, da tutti vivamente sentito. Nel nuovo campo, assai più duro del precedente, salì davvero la cima del Calvario per compiere il supremo sacrificio. A Hersbruck, osserva il Dughera, non c’era nessun sacerdote, neppure tra i deportati. Olivelli, nella sua viva fede e religiosità cristiana, si preoccupò di supplire, per quanto gli era possibile, al ministero sacerdotale preparando i morenti al grande trapasso. Assistette, in particolare, il caro suo amico Focherini di Carpi, padre di sette figli, spirato con una commovente professione di fede in Dio, nella religione cattolica e nel Papa, come testimonia il maresciallo dei carabinieri Becciu. Ma Dio ormai non voleva più le opere sante di Olivelli, voleva lui stesso. Estenuato e sfinito, fu ricoverato in infermeria, dove non faceva che pregare. Mormorava spesso una sua preghiera particolare: «Pro teggi, Signore, i miei cari, gli amici, i compagni di lotta, i nemici...». Si, anche questi, perché egli non li odiava, ma li amava. Non dice il Vangelo: «Amate i nemici vostri e pregate per quelli che vi perseguitano?». Li aveva combattuti, ma per amore della giustizia, per la libertà della patria, per la difesa dei fratelli italiani. Era stato ed era sempre un ribelle per amore! A chi lo esortò un giorno a chiedere, in alto, una ben meritata ricompensa per ciò che aveva fatto in Russia, rispose: «Come militare ho fatto semplicemente il mio dovere; come cristiano ho cercato di praticare il Vangelo alla perfezione, ponendo la vita in pericolo per salvare quella degli altri. Di questo la ricompensa non viene dall’alto, ma dall’Altissimo». La sua anima italiana e cris tiana vibra intera e si eleva ai più alti sentimenti nella preghiera che compose, nei momenti più difficili della Resistenza, per sé e per gli altri. Essa svela il suo entusiasmo giovanile e la fedeltà agli ideali supremi. Signore, facci liberi! «Signore, che fra gli uomini drizzasti la Tua Croce segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità della massa, a noi oppressi da un giogo numeroso e crudele che in noi e prima di noi ha calpestato Te, fonte di libere vite, dà la forza della ribellione. Dio, che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi, àlita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della Tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore! Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocefisso, nell’ora delle tenebre ci sostenti la Tua vittoria: sii nell’indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell’amarezza. Quanto più s’addensa e incupisce l’avversario, facci limpidi e diritti! Nella tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fà che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente e a quello dei nostri Morti a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti: "Io sono la resurrezione e la vita", rendi nel dolore all’Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti: veglia Tu sulle nostre famiglie! Sui monti ventosi e nelle catacombe delle città dal fondo delle prigioni, noi Ti preghiamo: sia in noi la pace che Tu solo sai dare. Dio della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi ribelli per amore». Tutti i compagni superstiti dell’internamento, tutti senza eccezione, lo ammirano come eroe, lo venerano come santo.
Pasqua a Dachau
La Pasqua del 1945 cadde il 10 aprile. Come ho già detto, nonostante tutte le p roibizioni, nella cappella della nostra baracca si celebravano spesso e con molta serenità i giorni di festa e le altre date cristiane. A Natale io non potei assistere, perché mi trovavo in quarantena nella baracca 19. A Pasqua invece vi partecipai dall’inizio alla fine. Per tutti i cristiani la Pasqua ricorda il tronfo di Cristo nella sua Resurrezione. Per noi, in quelle condizioni, richiamava piuttosto l’ultima cena, perché la nostra passione non era finita, né compiuta con il sacrificio che forse Iddio ci richiedeva. Ciò però non diminuiva il nostro entusiasmo per la grande solennità. Si decise di celebrarla con tutta la pompa dei sacri riti e di invitare in antecedenza i compagni laici a un triduo di predicazione per prepararli a compiere il loro dovere pasquale. Questa ammissione, in cappella, dei laci delle altre baracche era ormai possibile, sia pure con prudenza, data la confusione che regnava nel campo e la rallentata vigilanza delle SS. Per la maggior riuscita del triduo i sacerdoti delle diverse nazionalità dovevano pensare ai propri compatrioti e predicare nella rispettiva lingua. Per gli italiani l’impegno della preparazione fu assunto da p. Manziana, sacerdote attivo, prudente, zelantissimo, amato da tutti per la sua bontà e carità. Fu coadiuvato da don Fortin, da don Liggeri e da don Tavasci per la propaganda. La predicazione fu affidata a don Aldrigetti, parroco di Soave, ottimo pastore d’anime. Io raccolsi i frutti delle fatiche altrui, confessando quanti desideravano fare la loro Pasqua. L’intervento dei borghesi di tutte le nazionalità a questi tridui fu davvero consolante. Ed era uno spettacolo edificante durante tutti i tre giorni assistere al succedersi di preghiere, di canti, di prediche in tutte le lingue d’Europa. Ma dovunque vi è Dio, vi è la unità della fede e dell’amore. Molti di quei poveri nostri compagni di sventura erano ottimi cristiani. Altri da anni non avevano fatto la Pasqua e si m ostravano felici della buona occasione. Tra questi vi fu il mio buon amico comunista Barbin, il vice cuoco di San Vittore, che si accostò ai sacramenti con viva devozione. Attraverso la dura esperienza dei campi aveva imparato che, senza Dio, non si può far nulla. E da quel giorno l’ideale comunista svanì dalla sua mente come un brutto sogno e non ne parlò più. La sua amicizia per me divenne affetto filiale, che conservo sempre anche dopo il nostro ritorno a casa. Più volte ci rivedemmo a Busto Arsizio dove risiedeva con la sua numerosa famiglia, e dove, da capo operaio, era stato promosso istruttore tecnico in una scuola professionale. Purtroppo, dopo essersi salvato dai campi di concentramento, perì in un incidente stradale, e io ebbi il dolore di accompagnarlo all’ultima dimora. Per noi sacerdoti la preparazione alla Pasqua consistette in una solenne Via Crucis predicata in latino da un padre gesuita belga. Questo padre, dottissimo, parlava con facilità sei o sette lingue, ma quando si rivolgeva a tutti, usava sempre il latino, maneggiandolo con tale sicurezza, spontaneità ed eleganza da far meraviglia. Era diventato perciò il nostro oratore ufficiale delle grandi circostanze. Non sto a descrivere i riti e le cerimonie con le quali fu soennizzata la Pasqua. Grande ponteficale, musica sacra sceltissima, cori magnifici. La cappella era zeppa di sacerdoti, essendosi radunati insieme quelli della baracca 26 e i polacchi della baracca 28.1 borghesi furono esclusi, per mancanza di posto. Commovente la comunione generale di quella grande adunata di ministri di Dio, i quali si preparavano con santa fede e serenità agli eventi che si presentavano assai prossimi e di eccezionale gravità. Così, tra lo splendore mistico dei sacri riti e con la soddisfazione di aver fatto un po’ di bene spirituale a noi sacerdoti e ai compagni laici passò quella Pasqua del 1945 a Dachau. Ma per noi italiani era riservata una dolorosa notizia. A lle funzioni del pomeriggio il capo-baracca ci comunicò la morte del nostro amato p. Girotti, ricoverato fin dal gennaio in infermeria. Tutti lo dicevano religioso esemplare e dottissimo in scienze bibliche, tanto che in patria attendeva alla edizione della Sacra Bibbia con commenti di p. Sales, al quale era succeduto con non minor competenza. Il capo-baracca ne fece un breve elogio e indisse per il giorno seguente un solenne ufficio di suffragio, come del resto si faceva per il decesso di ogni sacerdote. Solidarietà e fraternità spirituale, caratteristica singolare e suggestiva di quella famiglia di sacerdoti di tutta Europa, fino allora sconosciuti l’uno all’altro. Con la morte di p. Girotti crebbe in noi italiani l’apprensione per altri due del nostro gruppo, degenti in infermeria: don Seghezzi e don Vismara, entrambi della diocesi di Bergamo. Don Seghezzi, già ammalato di tisia polmonare, andò peggiorando di giorno in giorno e morì poche settimane dopo, proprio il giorno della liberazione. Don Vismara, colpito da una tenace e pericolosa risipola, potè resistere fino all’arrivo degli americani, che in pochi giorni lo curarono e guarirono completamente. Non mancò quel giorno di Pasqua anche qualche sollievo materiale. I sacerdoti tedeschi e francesi ricevettero buona quantità di pacchi alimentari, che generosamente, nonostante fossero essi stessi affamati come tutti, divisero con i confratelli. Il buon vecchio parroco tirolese, di cui ho già parlato, in quella solenne circostanza fece parte del suo pacco speciale a quanti potè con più gioia e generosità. Mi commosse pure il gesto di un nostro confratello cappuccino di Vienna, p. Eberhard, che in quella Pasqua aveva ricevuto una dozzina di uova. Corse felice a darmene cinque. Un vero tesoro, che mi sarebbe gravato eternamente sulla coscienza se anch’io in quel momento non avessi sentito il dovere di distribuirne ad altri bisognosi, riservando mene uno solo. E così fummo in cinque a dividerci l’aiuto della carità fraterna. Perciò la nostra Pasqua 1945 fu spiritualmente più gioiosa e materialmente meno triste degli altri giorni.
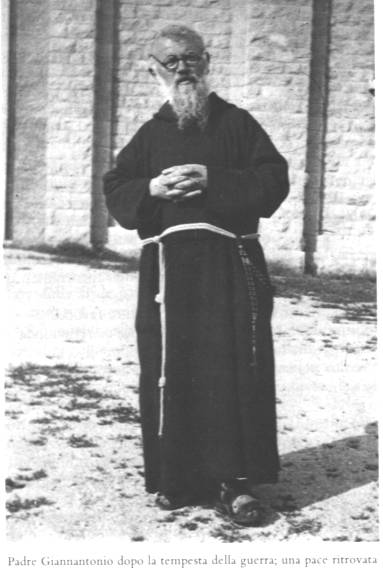
La tragedia precipita
Alle scene di terrore dell’8 aprile seguirono due settimane di relativa tranquillità. La tragedia però era al suo ultimo atto, anzi all’epilogo finale, e a noi interessava sapere come si sarebbe chiusa. Saremmo stati liberati, o saremmo morti prima della liberazione? Nella cappella si intensificavano le preghiere. Tutti i sacerdoti, e anche molti civili, passavano lunghe ore davanti al SS. Sacramento e alla Madonna, per invocare una speciale protezione in quei gravissimi momenti. La sera del 25 aprile, appena coricati, il capo-baracca ci avvertì che, per ordine superiore, il mattino seguente dovevamo tenerci pronti per partire verso ignota destinazione. Ci era permesso prendere una coperta piegata a tracolla sulle spalle ed eventualmente qualche pezzo di pane avanzato. Il 26, alzatici prestissimo e ascoltata la santa messa, uscimmo dalla baracca per l’adunata comune in piazza. Restarono sui tavolati gli ammalati gravi e i vecchi che non potevano camminare, in attesa di controllo. Speravamo che ci fosse qualche mezzo di trasporto perché l’ordine era di partire tutti, senza eccezione. In piazza eravamo circa 30.000, bene inquadrati e pronti. Nelle diverse baracche ne rimasero circa 7 o 8 mila. Dopo quasi tre ore giunse inaspettatamente l’ordine di tornare tutti in baracca, fuorchè i tedeschi e i russi, i quali solamente dovevano partire. La cosa ci parve misteriosa. Se fossero stati scelti soltanto i russi si po teva pensare a un Transport di particolare prudenza o castigo; se solo i tedeschi a un riguardo speciale; ma che gli uni e gli altri partissero insieme era incomprensibile. Alla sera del 26 un altro ordine che interessava unicamente noi italiani: bisognava esser pronti alla partenza per il giorno dopo. Questo ordine ci impressionò enormemente. Sapevamo di essere malvisti come e più dei russi; sapevamo che le SS ci chiamavano badogliani e traditori e volevano ammazzarci in blocco. Dopo l’adunata del mattino nessuno venne in baracca a controllare i rimasti. Allora ci accordammo col capo-baracca di non presentarci tutti, ma solo quelli che si sentivano spontaneamente di partire. Ci offrimmo tutti, furono però scelti solo i più giovani; gli altri furono annoverati tra i vecchi e gli ammalati. Ogni separazione è dolorosa. Non ci si poteva staccare dai compagni di sventura. Per questo insistemmo ancora tutti, ma non ci fu nulla da fare. «Noi resistiamo meglio alle fatiche del viaggio», risposero i giovani, «e se si deve morire, è meglio morire in pochi che tutti». Il mattino seguente essi si presentarono in piazza. Noi rimasti (evidentemente io ero del numero) sentimmo rimorso e vergogna, perché o si doveva vivere tutti o tutti morire. Noi anziani dovevamo anzi dar buon esempio, salvando i giovani, i quali, tornati in patria, potevano fare ancora molto bene. Il rimorso fu così forte che pensammo di liberare i compagni o di unirci a loro. Tra i poliziotti del campo vi era un sacerdote polacco. Lo pregammo di far tutto per strappare dal gruppo dei partenti i nostri cari compagni. Pensavamo che ciò fosse possibile, data la confusione che ormai regnava nel campo e soprattutto tra le SS. Egli si assunse l’impegno, ma il tentativo non riuscì. Mentre, con suo e nostro dispiacere, ci raccontava in baracca come erano andate le cose, aggiungendo che i partenti erano eroicamente lieti del sacrificio cui andavano incontro, ecco questi com parire al completo in camerata. Festa vivissima non solo per noi italiani, ma per tutti i compagni di baracca. Di più, avendo essi ricevuto (cosa mai accaduta prima) una scatola di carne ciascuno come viatico, per festeggiare anche materialmente la riunione fraterna vollero farne partecipi tutti. Giurammo che, accadendo di dover partire di nuovo, non ci saremmo più separati. L’occasione si presentò subito, il giorno dopo. La sera del 27 - è la terza volta! - nuovo ordine di partire l’indomani: tutti indistintamente, di ogni lingua e nazione, vecchi, ammalati e moribondi. Ormai i dirigenti del campo non sanno più quello che vogliono. Il mattino nuova adunata in piazza, nuova attesa di due ore, nuovo mistero. Si parte? Si parte davvero?... le SS non si vedono; i capo-baracca non parlano, i poliziotti si nascondono. Ad un dato momento cadde uno scroscio di pioggia violento. «Coraggio», ci diciamo l’un l’altro, «oggi è sabato. La Madonna troverà qualche mezzo per impedire la nostra partenza». Aspetta! Aspetta! Siamo stanchi. D’improvviso le file si scompongono, i quadrati si sciolgono e, senza che nessuno dica una parola, tutta quella massa di uomini, come nulla fosse, si avvia lentamente per il grande viale a gruppetti, commentando pacificamente la situazione. Prima che giungessimo alle rispettive baracche, altra sorpresa. La sirena suona il grande allarme con un fischio lungo, acuto, lacerante; non si era mai sentito l’uguale. Bombardamento? Non si vede nulla in alto, nessun motore né vicino né lontano si fa sentire; la contraerea tace. Mistero! Un giovane si arrampica su un pioppo del vialone e dà un grido: «Carri arma-ti americani, carri armati americani!». Si seppe poco dopo che c’era stata veramente una scorribanda di carri armati americani a scopo di ricognizione; subito però si ritirarono. Chi può descrivere la nostra gioia? «Sono vicini», ci diciamo l’un l’altro, «e ora sanno dove siamo». Tuttavia bisogna essere ancora guardinghi perché eravamo sempre sotto il tiro delle mitragliatrici puntate in permanenza contro di noi dalle torrette, e le SS non avevano ancora sgombrato il posto di guardia all’entrata del campo. Occorrevano ancora prudenza e pazienza! Per tutto quel giorno non ci fu altra disposizione. Ci fu dato il solito rancio a mezzogiorno e a sera fummo lasciati in pace nelle camerate. Il mattino della domenica seguente nessun appello, nessuna adunata. I più mattinieri poterono uscire liberamente dalla baracca e avvicinarsi pian piano alla porta di entrata delle SS. Non videro nessuno, salvo le sentinelle dei posti di guardia. Ma improvvisamente videro sventolare in alto, all’estremità della sede di comando, una bandiera bianca. La notizia corse in un baleno per tutto il campo, di baracca in baracca, di camerata in camerata. Tutti si svegliarono, balzarono dai castelli, uscirono sui viali, scesero in piazza. Ognuno voleva vedere con i propri occhi, constatare se la notizia era vera. Ma pian piano il movimento si calmò, perché qualcuno espresse il dubbio che fosse un inganno delle SS. Del resto le sentinelle e i mitra, sempre piazzati, non ispiravano gran fiducia. Ritornammo in baracca; uscimmo di nuovo a passeggiare su e giù per il viale; andammo a trovare gli amici, specialmente gli ammalati, scambiammo con tutti la nostra gioia, sempre però con una certa cautela e prudenza. A mezzogiorno ci fu la distribuzione regolare del pranzo. I cuochi, veramente previdenti, non aspettarono il rancio dei liberatori, ma incominciarono a non far mancare la giornaliera razione. Ore 17,30. Sul poggiolo interno del palazzo delle SS sventola la bandiera americana. Un generale americano, dallo stesso poggiolo, dichiara decaduto il comando tedesco. Tutti gli internati liberi, sotto il comando americano, hanno però l’obbligo di restare in campo fino a nuove disposizioni. Un cappellano militare belga invita tutti i presenti a ringraziare Dio della vittoria degli alleati e della liberazione. L’immensa folla degli internati accorsi in piazza innalza grida altissime di gioia e di entusiasmo. I sacerdoti, seguiti da moltissimi presenti, corrono in cappella a intonare il Te Deum. Proprio quel giorno 29 aprile, dopo lunga malattia e gravi sofferenze, moriva in infermeria don Seghezzi, del nostro gruppo italiano. Il sacrificio della sua vita sacerdotale ha certo contribuito alla salvezza comune, come il suo olocausto ha suggellato il giorno della nostra liberazione. Una notizia di estrema gravità corse per il campo in quello stesso giorno e nei giorni seguenti: il triplice tentativo di trasportarci dal campo aveva lo scopo di rendere esecutivo l’ordine spiccato e firmato da Himmler di fucilarci tutti. La gravissima notizia trovò conferma, come scrive Paolo Liggeri nel suo bellissimo libro Triangolo rosso, da documento autentico trovato in minutissimi pezzi nell’appartamento delle SS. Personalmente stento a credere a tanta ferocia. Comunque sia, questa era nel campo la convinzione comune e non penso che Liggeri, sempre così preciso, abbia voluto dar credito nel suo libro a una notizia infondata.
Liberazione!
Per la prima volta, ritiratici in baracca, pensavamo di essere al sicuro e di dormire sonni tranquilli. Ma a notte avanzata fummo sorpresi dall’improvviso rintronare dei cannoni. I loro cupi boati sembravano tanto vicini che pareva scoppiassero entro il recinto del campo. I bagliori delle esplosioni lampeggiavano di continuo attraverso le ampie finestre. Fummo presi dal terrore davanti all’orrida prospettiva di dover essere massacrati dai cannoni o di bruciare vivi tra le macerie delle aride pareti di legno delle nostre baracche. Che cosa era successo? Le SS, nonostante l’esposizione della bandiera bianca, si erano solo ritirate, ma non arrese. Le sentinelle delle torrette erano addirittura rimaste alloro posto. Col favore delle tenebre il grosso delle formazioni, che si era nascosto dietro le colline circostanti, tentò una controffensiva. Così si accese un’aspra battaglia che durò fino alle quattro del mattino. Infine gli americani ebbero il sopravvento. Sbaragliarono definitivamente le ostinate SS, fucilando un buon numero di quelle che facevano da sentinella al campo, per evitare quanto si diceva essere accaduto a Buchenwald, dove le SS con le sentinelle, dopo la resa, erano venute meno alla parola data, massacrando degli internati. In giornata si diffuse nel campo la notizia che Monaco aveva capitolato ed era già stata occupata dai vincitori. Chi può descrivere il tripudio, anzi l’esaltazione di tutti gli internati in quel memorabile 30 aprile? Il primo pensiero di noi sacerdoti fu quello di celebrare più sante Messe che fosse possibile in ringraziamento a Dio. La maggior parte di noi non saliva più l’altare da molto tempo. Io dal giorno della mia partenza da Milano, ossia dal 16 agosto 1944. Si apprestarono in cappella una ventina di altari. I paramenti e tutto l’occorrente furono procurati nella vicina parrocchia di Dachau e in altre chiese. Si celebrò ininterrottamente fino a sera. Ebbi anch’io la grazia di entrare nel turno. E fu questa la prima e l’ultima S. Messa che io potei celebrare al campo, perché nei giorni seguenti dovemmo lasciare il posto agli altri, molti dei quali non celebravano più da due e anche da tre anni. Intanto nel campo le manifestazioni di gioia assumevano forme estremamente grandiose. In un batter d’occhio apparvero su tutte le baracche selve di bandiere di ogni colore e nazionalità. Sulla nostra e su quella vicina dei sacerdoti polacchi furono stesi striscioni bianchi e gialli: i colori del Papa. Purtroppo moltissime erano le bandiere rosse comuniste, non perché i comunisti fossero in maggioranza, ma perché, im portando loro ben poco il rispetto per l’opera degli altri, volevano affermare con prepotenza il loro partito, come se il merito della liberazione fosse stato esclusivamente loro. La baldoria con canti, suoni e schiamazzi, nella più grande confusione di lingue, iniziata quel mattino, durò parecchi giorni. Nonostante l’ordine impartito dagli americani di restare nel campo, molti internati fuggirono, sperando di tornar subito a casa; ma la maggior parte dei fuggitivi ebbe spiacevoli peripezie e giunse in patria dopo gli altri. Come era da aspettarsi gli americani mutarono radicalmente il regime e la disciplina interna dei campi. Non più adunate, controlli, punizioni, ma cibo sano e abbondante, carne in scatola, minestra ben condita e pane buono a volontà. Ma la troppa abbondanza costituì un pericolo. Avvezzi ormai da lunghi anni al digiuno, l’improvvisa abbondanza fu per alcuni una tentazione troppo forte. L’imprudenza e l’avidità causarono indigestioni che, ad alcuni, costarono la vita. La gioia della liberazione non fece dimenticare i compagni che caddero prima di vedere il gran giorno. Unanime fu il pensiero di ricordarli solennemente e di suffragare le loro anime: si stabilì perciò di celebrare una santa Messa da morto in mezzo alla grande piazza. A tale scopo un gruppo di artieri polacchi approntò una tribuna di legno, alta parecchi metri. Alla sommità della tribuna innalzò un altare. A semicerchio, dietro la tribuna, furono issate sette lunghissime antenne, portanti altrettante bandiere delle maggiori nazioni, tra cui l’Italia. Sopra ogni cosa troneggiava una gigantesca Croce. Il 2 maggio, verso sera, fu celebrata la Messa in suffragio di tutte le vittime della prigionia, presenti oltre un migliaio di sacerdoti e un numero strabocchevole di internati civili. La scena era impressionante. Pioveva. Il pensiero dei morti rendeva l’ora più triste; ma una manifestazione di fede così solenne e pubblica, là dove fino allora era stato delitto fare il segno di croce e non si erano sentite che bestemmie, a chi aveva fede, recava un immensa soddisfazione. Lo spettacolo si rinnovò il giorno dopo, 3 maggio, con un tempo magnifico: fu celebrata un’altra messa sul medesimo altare, ma questa da vivo, in ringraziamento per la liberazione ottenuta. Col primo maggio si era anche iniziato nella cappella l’omaggio serale alla Madonna. La sacra funzione si chiudeva sempre col canto, in diverse lingue, di inni mariani. Così la situazione morale e religiosa si era capovolta, e tutto concorreva a rendere più gioioso il nostro soggiorno nel campo, e più serena l’aspettativa della completa liberazione che doveva concludersi col nostro ritorno in patria. Nel frattempo il comando americano organizzò una vasta azione di risanamento del campo; grosse pattuglie di soldati di sanità incominciarono a disinfettare i singoli internati e le rispettive baracche, per impedire che il tifo petecchiale facesse nuove vittime. Sgombrarono poi tutti gli ammalati dall’infermeria e dalle altre baracche in cui erano degenti, trasportandoli fuori campo, nelle vicine caserme delle SS, che erano state trasformate in ospedali. Per parecchi giorni vi fu un via vai di autoambulanze. Molti sacerdoti, già addetti al servizio degli ammalati, seguirono come infermieri e come cappellani gli ammalati stessi. I morti, anche quelli del corpo sentinelle, fucilati per punizione, vennero onorevolmente sepolti. Al servizio del campo furono obbligate le SS che, da padroni, dovettero umiliarsi a servire i loro schiavi di ieri. Va notato che gli internati furono generosi e non abusarono della loro nuova condizione per insultare o maltrattare i loro aguzzini. Salvo qualche raro caso non vi furono vendette. Gli americani ci trattarono con tanta umanità, anzi con tale fraternità che ne restammo commossi. Essi, pur essendo vincitori e nostri liberatori, non si davano alcuna importanza , fraternizzavano con coi, come fossimo vecchi conoscenti e amici. E’ vero che molti di essi erano oriundi europei, ma la loro educazione era prettamente americana, esente da quelle passioni ed esaltazioni nazionalistiche che, purtroppo, rovinano l’Europa. Riordinato il campo e calmatesi le dimostrazioni di gioia per la riconquistata libertà dal dominio tedesco, la nostra più grande preoccupazione era di sapere cosa era accaduto e che cosa accadeva in Italia, e quando avremmo potuto ritornare. Qualche notizia l’avemmo subito dagli americani. Fummo informati che l’Italia era già stata liberata il 25 aprile, che il povero Mussolini aveva fatto una cattiva fine, che il Papa stava predisponendo grandiosi mezzi per accelerare il nostro rimpatrio. Un certo monsignor Carrol, americano, residente a Roma, venne un mattino in baracca e ci confermò tutte queste notizie. Anche un cappellano francese nell’esercito americano ci assicurò che il comando americano intendeva rilasciarci il più presto possibile. Solo la difficoltà dei mezzi di traspòrto e lo stato pietoso delle comunicazioni ritardarono il nostro rimpatrio. Egli annotò tutti i nostri nomi e promise che avrebbe dato notizia di ciascuno di noi a mezzo Radio-Parigi. Mantenne la promessa. La sua comunicazione portò in Italia il primo annuncio che noi eravamo ancora vivi.
Addio a Dacliau
Una delle prime conseguenze della riacquistata libertà nell’interno del campo fu di poterci organizzare in gruppi nazionali. Finchè avevano imperato i tedeschi, gli internati delle diverse nazionalità erano mescolati insieme e sperduti nella massa, divisi e suddivisi nelle diverse baracche e sul lavoro, senza possibilità di trovarsi coi propri connazionali. Gli americani lasciarono invece che tutti facessero ciò che loro piaceva. Così avvenne che, per una spontanea e rapida selezione, si formarono le comunit à nazionali, costituendosi per ciascuna un comitato direttivo, con un presidente a capo e il rispettivo segretario. L’insieme poi dei presidenti si riuniva in un supercomitato internazionale col compito di provvedere al bisogno di tutti e trattare con la nuova direzione americana del loro sollecito rimpatrio. Per il comitato del nostro gruppo italiano fu eletto il sig. Melodia, presidente, e padre Manziana, vice presidente e segretario, con alcuni altri membri, tra cui il colonnello Scotti di Milano. Il comitato si interessò subito di tutti i connazionali, pubblicando insieme un bollettino dattiloscritto con le poche notizie che si potevano avere dell’Italia e la cronaca del campo. Le promesse degli americani, di rimpatriarci quanto prima, incominciarono a realizzarsi verso la metà di maggio. I primi ad uscire dal campo e a ritornare alle loro case furono i lussemburghesi. Essi formavano un piccolo gruppo in confronto degli altri, ma il governo di quello stato minuscolo fu il più sollecito a venire a prendere i suoi figli. Una mattina apparvero due o tre grandi autopullman, caricarono l’intero gruppo e se ne andarono quasi alla chetichella. Qualche giorno dopo partirono i francesi, che, essendo in molti, fecero più chiasso e lasciarono maggior vuoto. Venne quindi la volta dei cecoslovacchi. Questi, parlo dei compagni di baracca sacerdoti, usarono verso di noi sacerdoti italiani una particolare attenzione. Vollero salutarci tutti insieme, come segno di viva amicizia. Uno di loro, monsignor Swec, già segretario della Nunziatura di Praga, ci rivolse parole commoventi, dicendo che, in tutto il tempo della nostra comune prigionia egli e i suoi fratelli cecoslovacchi avevano ammirato la pietà, il buon esempio e lo zelo dei sacerdoti italiani. Questo lusinghiero e affettuoso saluto e l’abbraccio fraterno che ne seguì toccò il cuore, dimostrando insieme lo spirito sacerdotale e profondamente cattolico romano che animava quei futuri martiri del comunismo, più tardi violentemente installatosi al governo della loro patria. Dopo queste partenze al campo non rimanevano che i polacchi, gli iugoslavi e altri gruppi minori. Noi italiani eravamo impazienti che venisse la nostra volta, ma pareva che dovessimo restare gli ultimi. Si mormorava che in Italia nessuno pensasse a noi, che il nostro governo non si sognasse neppure di interessarsi della nostra sorte, che gli americani, nonostante le promesse, ci lasciassero proprio all’ultimo posto. Ma venne anche la nostra ora. Il 26 maggio, per noi lombardi grande festa della Madonna di Caravaggio, ci fu dato l’ordine di adunarci tutti in piazza. Dopo una lunga sosta davanti al palazzo delle SS, ecco finalmente l’ufficiale americano dare il segnale di metterci in moto e passare il portone. Appena fuori provai la sensazione che provò Dante uscendo dall’inferno. Ora ero proprio convinto di essere liberato per davvero, di non finire al crematorio. Sapevamo però che non si sarebbe partiti in giornata, ma che avremmo dovuto fare ancora una sosta fuori del campo, per una speciale toilette, prima di rientrare in Italia. Difatti fummo condotti nelle caserme delle SS situate nelle adiacenze del campo, bei fabbricati, più da palazzi privati che da caserme, con tutte le comodità possibili: letti con piumino, coperte, posaterie e attrezzi d’ogni genere rubati in Italia. Nella vicina piazza d’armi scorgemmo accumulate alla rinfusa come rottami, migliaia e migliaia di macchine da cucire, pure italiane. Non mancavano qua e là, sparse al suolo, armi abbandonate e nelle stesse stanze piccole bombe a mano. Una di queste, presa da un compagno nostro fu causa della sua morte, perché volendola far scoppiare in segno di gioia gli esplose in mano e lo straziò in un modo tale che nonostante l’intervento del medico americano il poveretto morì. A parte il doloroso incidente passammo una notte dormendo beatamente sui s offici letti. Il giorno seguente fu dedicato tutto alla famosa toilette. Con macchine speciali facemmo una doccia di acqua disinfettante, serviti di tutto punto dai soldati americani. Dopo la doccia ecco pronta la biancheria nuova fiammante, proveniente dai magazzini delle SS. E un vestito nuovo, una divisa al completo delle SS, anch’essa nuova di zecca. Ironia del caso! Mi avevano arrestato le SS ed ora io sarei tornato in convento in quella poco simpatica divisa! Vi strappai però la croce uncinata attaccata alla manica, parendomi una profanazione blasfema. La mattina del giorno dopo 28 maggio, ecco arrivare sulla piazza una settantina di autocarri americani. Ordine immediato di prepararsi alla partenza. Una immensa gioia si impadronì di tutti. Gli automezzi erano ornati con bandiere tricolori. In fretta e furia ognuno cerca di salirvi e prendere posto. Nell’attesa giungono dai campi vicini altri connazionali, cantando a squarciagola e agitando bandierine. L’entusiasmo è al colmo quando alle dodici precise si dà il segnale della partenza. Addio, Dachau! Addio, campi di concentramento di tutta la Germania! Nel lasciarvi la nostra gioia è immensa. Ma è venata di dolore: quello di non vedere presenti in questo momento con noi tanti compagni di sventura. Che diremo alle loro famiglie appena arrivati in patria? E nella patria stessa troveremo tutti i nostri cari? La guerra è finita, ma è passata dovunque, distruggendo, massacrando, pervertendo la gente fino in fondo all’anima! Quant’è vero che in questo mondo nessuna gioia è pura! Ma la colonna degli autocarri marciava, correndo, con stupenda regolarità, sotto la guida degli americani, verso i confini d’Italia, e il pensiero che vi saremmo giunti in giornata assorbì ogni altro.
Ritorno al convento
Attraversammo Monaco. Alla periferia non si vedevano che macerie di interi rioni abbattuti dai massicci bombardamenti alleati degli ultimi giorni. Le poche persone che incontrammo sul nostro cammino ci sembravano come inebetite per la rovina della loro bella città, ma assai più, credo, per l’irreparabile sconfitta dopo tante illusioni di conquistare il mondo intero. Non bisogna dimenticare che Monaco fu culla e centro del nazismo. Per raggiungere i confini del Tirolo non prendemmo la via di Kufstein, ma imboccammo la magnifica autostrada che, partendo da Monaco e snodandosi fra le massicce e splendide Alpi bavaresi, raggiunge Sarnik, nella valle dell’Inn, a una decina di chilometri a monte di Innsbruck. Nel Tirolo la strada ci si presentò scoscesa e a volte molto stretta e qua e là resa impraticabile dai bombardamenti, a tal punto che metteva a dura prova la valentìa degli autisti americani. Non mancarono incidenti paurosi, ma senza serie conseguenze. Si oltrepassò Innsbruck e fummo sulla strada del Brennero. Profonda commozione ci prese tutti all’approssimarci al confine; non pochi compagni si unirono in una breve preghiera di ringraziamento a Dio. Breve sosta presso la stazione, dove i funzionari delle ferrovie della dogana ci furono tanto gentili. Ci impressionò l’assenza assoluta di movimenti di treni. Venimmo presto a sapere che la linea Brennero-Bolzano era stata completamente distrutta dai bombardamenti e che, a distanza di un mese dall’armistizio, non era ancora stato possibile riattivarla. Dal Brennero, scendendo per i paesi dell’Alto Adige, folle di gente ci salutavano con effusioni di sincera simpatia. Verso sera arrivammo a Bolzano e fummo alloggiati al centro di smistamento ex-prigionieri ed internati. Ci fu facile rilevare il senso di delicatezza usato nel non portarci al campo di concentramento, che avrebbe potuto suscitare in noi tristissimi ricordi. Con grande nostra meraviglia notammo, lungo la strada e nella piazza antistante la sede del centro di smistamento, ingente quantità di automezzi, su ognuno dei quali sventolava la bandiera pontificia accanto a quella nazionale. Ogni colonna era capitanata da un sacerdote. Una sola bandiera rossa su un autocarro, che pure aveva issata, accanto, quella del Papa. E’ qualcosa di incredibile, che meriterebbe un volume a sè, quanto fece in questa circostanza la commissione pontificia per noi ex internati. Mentre l’autorità civile era ancora in via di riorganizzazione, dopo il caos seguito al crollo tedesco, e certi partiti si stavano sbizzarrendo in vendette e lotte fratricide, la commissione pontificia, con larghezza di mezzi che le affluivano da ogni parte del mondo per la fiducia che aveva meritatamente acquistata, andava svolgendo fin dai primi giorni una vastissima assistenza. Se a Bolzano come in ogni altra località, gli internati non avessero avuto le prestazioni generose di questa benefica istituzione, sarebbe certamente avvenuto un vero disastro. Il capitano infatti, che dirigeva, a nome del Governo, il centro di smistamento, al nostro arrivo dichiarò che non era assolutamente possibile nè ospitare, nè rifocillare e nemmeno inviare a destinazione sì grande quantità di nuovi arrivati. E fu così che allora intervenne la commissione pontificia, che si caricò gran parte di noi, e gli autocarri americani che proseguirono fino a Pescantina e a Verona consegnando gli internati alla pontificia locale. Frattanto a noi che eravamo rimasti, eseguite le necessarie pratiche di controllo all’ufficio medico, venne distribuita una buona razione di pane bianco e un bicchier di vino generoso: il primo pane bianco e il primo bicchiere di vino dal giorno della nostra cattura e invio nei campi di concentramento. Fummo subito attorniati da un gruppo di milanesi venuti a congratularsi del nostro ritorno e a chiedere notizie di parenti e conoscenti. Vestito com’ero da SS, non era possibile riconoscermi, ma notai un prete che mi stava scrutando, perplesso. Poi, d’un tratto: «Ma lei è p. Giannantonio, vero?» «Si, e lei, se non erro, è don Arturo!» Il buon Arturo, parroco di Rovello Porro, che conobbi a Corbetta molti anni addietro durante la mia predicazione quaresimale in quella grossa borgata. Era venuto personalmente a prendere gli internati suoi parrocchiani. L’abbraccio fu assai caloroso e fraterno. Mi presentò a mons. Benetti, prevosto di Saronno. Entrambi mi proposero di rimanere a Bolzano con loro, che all’alloggio e al vitto avrebbero provveduto personalmente. Pur spiacente di lasciare i compagni di viaggio accettai, e mi fu oltremodo gradita la possibilità di respirare alquanto l’aria dei miei monti, che intravedevo oltre il Passo della Mendola. Rimase con me anche don Campi di Genova, il caro Paolo Liggeri e altri sacerdoti erano partiti sugli autocarri americani. Quella sera si cenò presso i Domenicani e pernottammo a Gries presso i Benedettini. Gli uni e gli altri ci furono gentilissimi. Il mattino seguente, celebrata la santa Messa e dopo un’abbondante colazione, si partì sull’autocarro di don Arturo alla volta di Milano. Nuovo ristoro presso la commissione pontificia di Trento, breve sosta anche a Verona ed eccoci a Brescia. Qui fui io a pregare la comitiva di fermarsi presso il convento dei Cappuccmi, volendo rivedere e salutare per primi quei confratelli. Fu una vera festa fraterna e fu necessario rimanere anche per la cena, imbandita dalla comunità per tutti noi. Verso sera ripartimmo per Milano. Eccoci finalmente verso le ore 23 nella capitale lombarda. Quale impressione! Le strade semioscure, perfettamente deserte, nessun movimento di tram o di macchine. Un profondo silenzio. Tutti morti a Milano? Percorso viale Piave, eccoci alla porta del convento. Con quanta trepidazione mi attaccai al campanello! Un breve tintinnio e altrettanti brevi minuti di attesa che mi sembrarono ore. Il cuore mi batteva forte forte. Ecco la porta finalm ente si apre. E fra Cecilio, il solito infaticabile portinaio del convento. Rimase stupito e confuso e, quasi non rendendosi conto di quanto faceva, prese lui a tirare la campana e suonò a lungo, come se fosse arrivato il padre generale o l’arcivescovo. I frati balzano dal letto e tutti scendono in portineria. Che c’è? Durarono fatica a riconoscermi in quella divisa di SS. Non so come, finii tra le braccia del padre provinciale, p. Guido da Curnasco, che mi strinse a sè con grande effusione, tra la commozione di tutti. Qualcuno certamente pensò all’evangelica scena del ritorno del figlio prodigo. Del resto anche di questo povero vecchietto si poteva dire: era

smarrito e fu ritrovato, era morto ed è risuscitato! Sciolto dall’abbraccio paterno, mi prostrai istintivamente a baciare la soglia del mio convento, grato a Dio di esservi ritornato dopo tante e sì dolorose peripezie
L’abbraccio del cardinale
C on l’arrivo al convento la storia delle mie peripezie sarebbe chiusa, ma fui pregato di narrare come passai quei primi giorni dopo il ritorno, così gravi e burrascosi per Milano e l’Italia tutta. Veramente questa è storia nota; però qualche episodio particolare può avere un certo interesse. Gratitudine mi obbliga a ricordare in primo luogo un grande atto di cristiana carità. Parlando di quanto si fece per liberarmi dalle carceri di San Vittore, accennai a una terziaria francescana della congregazione presso la nostra chiesa di Monforte, mia penitente, di vita esemplarissima, già impiegata alle Assicurazioni Generali, certa Amalia Costa. Quell’anima buona aveva offerto la sua vita per la mia liberazione dal carcere e, dopo la mi a deportazione in Germania, perché tornassi sano e salvo al convento. Non accontentandosi della sua offerta, per tutto il tempo del mio internamento, come mi raccontò il parroco di Comerio, ogni giorno, anche nel periodo più freddo, faceva la comunione e si fermava in chiesa per ben due ore a pregare per il medesimo scopo. Il Signore l’esaudì. In convento mi dissero che era morta pochi giorni prima, il 21 maggio, a Comerio, presso Varese, dove si trovava sfollata durante la guerra. La notizia della sua morte era giunta in convento lo stesso giorno e la stessa ora in cui vi giungeva notizia della mia sopravvivenza e del mio rimpatrio. Un mio nipote mi raccontò che, chiamato al telefono, ebbe prima la notizia del mio prossimo ritorno dalla Germania, e, appena deposta la cornetta, ricevette una seconda telefonata con la comunicazione, da altra fonte, che era morta la signorina Costa. Non fu per un riguardo personale che la buona terziaria s’indusse a quell’atto eroico, ma per la venerazione che aveva per tutti i sacerdoti. Essa giace nel cimitero di Comerio, venerata anche dalla gente locale come una santa. Più volte celebrai la santa Messa e mi intrattenni in preghiera sulla sua tomba, che io considero come quella di una vera martire della carità e dell’amore per la Chiesa. Mi feci un particolare dovere di presentarmi a Sua Em. il cardinale Schuster, sia perché, come penitenziere in duomo, ero sempre alle sue dirette dipendenze, sia per ringraziarlo di quanto aveva fatto per impedire la mia deportazione in Germania. Naturalmente avevo già sostituito l’abito francescano alla divisa delle SS. Mi recai insieme al nostro ex-padre provinciale, che fu poi eletto superiore generale dell’Ordine cappuccino, Benigno di S. Ilario Milanese. Salendo le scale dell’Arcivescovado, quanti incontravo, mi guardavano con una certa esitazione, mormorando: «E’ lui? Non è lui?». Vedendomi senza barba e magro sche letrito, anche gli addetti al duomo e all’episcopio avevano difficoltà a riconoscermi. L’anticamera del cardinale era affollata di gente in attesa. Il segretario don Terraneo ci annunciò e sollecitò il ricevimento. Appena Sua Eminenza mi vide, si alzò di scatto da sedere e mi venne incontro e, aprendo le braccia, mi strinse a sé e mi baciò affettuosamente. L’Eminentissimo, che nei ricevimenti di solito era breve e sintetico, mi trattenne in lunga conversazione, interessandosi delle mie vicende e di quelle degli altri confratelli sacerdoti deportati nei campi di concentramento. Alla fine mi congedò dicendomi: «Scriva, padre, scriva la storia delle sue peripezie. Lei in questo caso rappresenta la Chiesa colpita, perseguitata per le sue opere di carità; e, raccontando ciò che ha visto e sofferto e ciò che hanno sofferto gli altri sacerdoti, non glorifica se stesso ma la Chiesa, la cui storia si intreccia appunto di tali episodi». Lo stesso giorno, ritornando in convento, fui assalito da un gruppo di giornalisti ansiosi di notizie. Vi erano, tra gli altri, i corrispondenti de L’Italia, del Popolo di Milano, del Corriere della Sera, dell’Avanti! Alle loro interrogazioni cercai di rispondere evasivamente nel timore che, dati i tempi ancora così turbolenti, le mie dichiarazioni potessero uscire dannose ad alcuno. La domenica dopo fui invitato a fare un discorso nella basilica di S. Ambrogio. Trovai la vasta chiesa gremita all’inverosimile. Tutti si aspettavano che facessi particolari rivelazioni e descrizioni dei campi di concentramento, ma anche qui per un senso di prudenza e per non rattristare maggiormente i parenti dei compagni non ancora ritornati, toccai appena il tasto doloroso. A funzione finita non sapevo più come liberarmi da coloro che mi domandavano notizie di parenti e conoscenti. Questa penosa quanto legittima insistenza per avere informazioni dei propri cari internati, fatta a voce e in iscritto, durò per parecchi mesi, impegnandomi non poco e causandomi gran dispiacere nei casi, ed erano i più, in cui non potevo dare alcuna notizia confortatrice. Un’altra attività mi toccò di esercitare, ed esercitai volentieri, e fu quella di commemorare i compagni caduti nei campi di concentramento. Alcuni parenti di questi, specialmente a Sesto San Giovanni, la cosìdetta Stalingrado d’Italia, mi invitarono a benedire le lapidi ricordo, murate in diversi stabilimenti e lungo le vie di quella industrialissima cittadina. L’iniziativa dell’erezione di tali lapidi era partita dal C.L.N. e perciò era comune ai tre partiti, il democratico cristiano, il socialista e il comunista. Purtroppo i caduti appartenevano in maggior parte ai due ultimi partiti e questi si sarebbero ben poco interessati della benedizione delle lapidi, ma i parenti, quasi tutti abbastanza religiosi, si imposero, esigendo che intervenisse il sacerdote per la benedizione e pensarono a me, come a reduce dai campi. Io col permesso del cardinale arcivescovo accettai. La prima lapide inaugurata e benedetta fu quella murata nella via centrale della città. M’accorsi subito che i comunisti cercavano di farne monopolio del loro partito e occasione di propaganda. Il loro rappresentante alla cerimonia non mancò fra l’altro di lanciare una frecciata al cardinale, dicendo che questi non avrebbe voluto permettere la benedizione perché, legato ai padroni, si disinteressava dei poveri operai, mentre io meritavo una lode speciale per essere intervenuto. Con garbo, ma fermamente, dovetti rispondere io a tali insinuazioni, dicendo che se io ero presente, ne avevo l’incarico dallo stesso cardinale e che non era il caso, in tale circostanza, di far polemiche, poiché i caduti che si commemoravano erano stati dei cristiani, anche se per ignoranza, iscritti a partiti contrari alla fede. Parlai in modo da farmi applaudire dalla folla e il rappresentante socialista volle farmi le sue congratulazioni. Un’altra volta, per una simile cerimonia in un grosso stabilimento, mi trovai a fianco a fianco col comunista Terracini che però, nel discorso, si astenne da ogni accenno antireligioso. Qui pure parlai, richiamando il pensiero cristiano di pace e di carità. Insomma mi accorsi che il titolo di ex-internato mi apriva le porte verso gente che non avrei mai creduto di poter accostare, per dir loro qualche buona parola, la quale, presto o tardi, avrebbe potuto fruttificare. D’allora in poi un gruppo di mamme e spose di ex-internati mi invitarono tutti gli anni a celebrare la Messa nel duomo di Milano in suffragio dei loro cari.

Perché «Nei Lager vinse la bontà»
Forse a più di un lettore sarà parso un po’azzardato il titolo che ho voluto dare a queste mie memorie di prigionia; forse ad altri sarà sembrato che io abbia voluto piegare l’esposizione dei fatti a una tesi, la quale, mentre dichiara e conferma la mia appartenenza a un Ordine religioso che fa apostolato di fraternità, sottopone i fatti stessi a una versione che li stacca dalla reale loro verità storica; ma non è così. Di proposito ho voluto lasciare ad altri memoralisti la narrazione del male che gli internati - ed io con loro - hanno veduto e patito e ho scelto di osservare e riferire i tenui fili di bene che, prima nascosto, poi sempre più manifesto e infine trionfale, finì col convincermi che veramente anche la bontà è entrata nei campi di concentramento e n’è uscita, unica fra tutti i prigionieri, adulta, divenuta grande nel dolore e nella morte di milioni e milioni di vittime. Ed oggi, alla distanza di oltre vent’anni dal termine dell’immane tragedia, sono anche più convinto che la bontà ha trovato là dentro delle meravigliose manifestazioni, singole e di gruppo, ed ha gettato i germi della nuova età religiosa e politica del mondo. Questo - si badi - non è solo ottimistica meditazione storica; è anche voce di fatti passati e realtà presente. Nei giorni dell’oppressione si soffriva e moriva, ma accanto agli sventurati, tra loro così diversi per azionalità, religione e civiltà, c’era sempre chi soffriva con essi, chi aiutava se appena poteva, anche col rischio della vita. Nel più grande dolore si ebbero prove del più grande amore. Vi furono coloro che divisero lo scarsissimo cibo con chi ne aveva maggior bisogno, chi si espose a feroci percosse per entrare nelle infermerie a servire e consolare, chi affrontò la morte nell’assistenza degli infetti e dei contagiosi, chi sostituì i deboli nei lavori forzati, chi volontariamente si mise al posto dei condannati a morte affinché il condannato fosse lasciato in vita. Nei giorni della liberazione trionfarono le armi dei vincitori, ma lo spettacolo che veramente mi commosse e mi rese felice - assieme, e si comprende - alla gioia di essere prossimo al rimpatrio - fu la condotta degli internati verso i loro ex-aguzzini. Fu allora soprattutto che nei Lager vinse la Bontà. A Dachau infatti io non ho potuto constatare atti di reazione e di vendetta, mentre sarebbero stati così facili e sicuramente impuniti. Ricordo che, mentre alcune SS, superbe e prepotenti fino al giorno prima, passavano sui viali del campo obbligate a far pulizie, gli internati, da schiavi divenuti ospiti di riguardo, non ebbero nemmeno una parola offensiva per loro, ma solo qualche sorriso di commiserazione. Perché non raccontare la storia di questa bontà? E ancora. Perché non invitare le generazioni presenti e future a riflettere che l’immensa tragedia dei campi di sterminio è stata possibile solo in quanto l’uomo aveva accettato di svincolarsi da ogni dipendenza e di rompere ogni rapporto col soprannaturale, elevando se stesso e la propria razza al posto di Dio, facendo delle proprie sciagurate pretese lo scopo unico della propria violenza? L’imbestiamento feroce dei responsabili maggiori ha origine e spiegazione in questo rovesciamento di valori. Mai forse, nel corso dei secoli, si è avuta, a rovescio, una dimostrazione più persuasiva della necessità, per la convivenza dei popoli, della fede religiosa e dei valori dello spirito. Se non lo riconoscessimo, faremmo la maggior offesa ai milioni di uccisi, poiché è per questi valori che essi sono stati arrestati e deportati, è per essi che hanno patito tanta violenza e la morte stessa: per la fede religiosa, per la Chiesa, per il sacro amore dei fratelli ingiustamente perseguitati, per la patria offesa e calpestata, per il diritto alla libertà e alla vita. Sono motivi e interrogativi questi che oggi, con la crescente materializzazione della vita e la vasta sequela che alcuni partiti politici vanno acquistando fra le masse popolari, dovrebbero far pensosi un po’ tutti, impegnandoli a considerare i minacciosi traguardi verso i quali sospingono la società. Nè si dica che il passato non si ripete. Se si pongono le stesse cause si avranno identici risultati. L’uomo è un essere logico anche nella più tragica delle inconsapevolezze: se si mette nell’ingranaggio di una dialettica di morte non avverte nemmeno di ruotare verso il suicidio, morale e fisico. Nei Lager, che furono l’espressione più paurosa della potenza nazista, quando furono ridotti al nulla i primi dominatori con l’avvento dei liberatori, si innalzò trionfante la Croce e sorse un tempio, consacrato durante il Congresso Eucaristico Internazionale di Monaco nel 1960. Tutto questo, voluto e realizzato dalla Germania cattolica, è estremamente significativo, come lo fu il ges to, compiuto da tutti i nuovi parlamentari tedeschi, di offrire al suo presidente Adenauer una croce con Crocefisso. Quell’immagine non indicava soltanto le martirizzate condizioni nazionali; era pure e soprattutto l’indicazione della fonte a cui attingere per la nuova vita, libera fraterna e feconda. Prima di concludere vorrei pure accennare a una mia convinzione, che, nata nei Lager medesimi, si è andata sviluppando negli anni successivi alla prigionia ed ora è ferma, anche se resta del tutto personale. Voglio dire che nei milioni di uomilii condannati a morte nei campi di sterminio i popoli si sono incontrati e parlati, si son conosciuti e hanno riconosciuto i vicendevoli diritti alla vita e alla libertà, l’uguaglianza umana di tutte le razze e il valore di tutte le civiltà. E’ nei Lager che è stato gettato, certo per la prima volta così efficacemente, il germe di una moderna Europa unita, che ora va cancellando e riducendo le resistenti ostilità, superando le frontiere e le distanze. Voglia Iddio, che è amore, convincere una volta per sempre gli uomini che l’amore è infinitamente più ricco di beni e di vita che non l’odio e la guerra. Nell’interno della Chiesa cattolica poi questo fatto è ancora più evidente. Mai era avvenuto che si trovassero assieme tanti sacerdoti. A Dachau si ebbe, assai prima del Concilio ecumenico, una vera adunanza ecumenica. Nè mai tanti sacerdoti cattolici si erano trovati a contatto, per mesi ed anni, con tanti ministri del culto di altre confessioni cristiane e non cristiane. Oltre che ecumenico, quello fu anche - indubbiamente il primo nella storia - il tempo del dialogo religioso cattolico aperto ufficialmente dal Concilio con tutte le confessioni e con tutti i popoli del mondo. I piccoli gesti di bontà che ho ricordato nelle mie pagine non facciano velo su queste prospettive, che colgono l’autentica, anche se dolorosissima, fecondità di quella tragica es perienza umana. Esse aiutano a comprendere il valore della pace riconquistata e a scorgere, nelle sue cause profonde, le vie nuove del mondo. Esse si chiamano e sono: avvicinamento, dialogo, uguaglianza e rispetto, fraternità e amore. Questa bontà, che è entrata nei campi di morte coi suoi eroi immolati a milioni, ne è uscita gigante. Sia essa ora a ispirare e governare la vita dei popoli.
Date dell’arresto e dell’internamento
13 giugno 1944: arrestato nel duomo di Milano e portato alle carceri di San Vittore: I Raggio, Il piano, cella n. 72.
19 giugno 1944: riprende a celebrare la Santa Messa recandosi nella cappella delle Suore. E’ trasferito dal I al VI Raggio come lavoratore. Addetto alla biblioteca. Riceve l’ordine di lasciare l’abito religioso.
15 agosto 1944: serve la Messa a mons. Bicchierai che segretamente lo informa della prossima partenza per Bolzano. Porta la Santa Comunione a dieci ostaggi.
17 agosto 1944; partenza in autobus per Bolzano. Arrivo in giornata. Col sopraggiungere di altri gruppi di prigionieri dalle regioni dell’alta Italia, viene disposta la partenza per la Germania. Taglio della barba.
5 settembre 1944: partenza per la Germania, diretto al campo di eliminazione di Flossenburg, in carri bestiame. I primi morti.
8 settebre 1944: arrivo al campo di Flossenburg. Privato di ogni cosa personale. Gli indumenti dell’internato. Nel blocco peggiore del campo: n. 23. Morte del gen. Murer. ottbre 1944: ai primi di questo mese passa al blocco n. 17, considerato uno dei migliori. Impiegato in tessitura e in seguito al trasporto di grossi pezzi da costruzione. Il capo-blo cco gli è ostile.
2 ottobre 944: trasferito a Zwickau, dove giunge il giorno seguente. Lavora negli stabiimenti dell’Auto-Union come controllore dei pezzi per motore per 12 ore al giorno. Cibo scarso e maltrattamenti.
12 dicembre 1944: riceve la notizia del prossimo trasferimento a Flossenburg. Viene però informato che non vi si fermerà e dovrà raggiungere il campo di Dachau, dove è stato disposto il concentramento di tutti i sacerdoti.
13 dicembre 1944: partenza da Zwickau per Flossenburg, dove giunge il giorno dopo. Notte di Norimberga. Incatenati a due a due per le vie della città. Al campo di Flossenburg.
18 dicembre 1944: arrivo a Dachau. Quarantena. La prima visita del capo-blocco dei sacerdoti, sacerdote egli pure. Destinato al blocco n. 19. Le conferenze spirituali e scientifiche dei sacerdoti francesi. Conoscenze ed amicizie. La festa del Santo Natale. Comunione. Confratelli cappuccini di ogni nazione d’Europa.
6 gennaio 1945: trasferito al blocco n. 26. Il p. provinciale cappuccino di Varsavia. Preoccupante indebolimento generale e attenzioni fraterne dei compagni di prigionia. Comunione quotidiana. Messa mattina e sera. Concerti di musica sacra. Conferenza per l’anniversario della elezione di Pio XII.
marzo 1945: durante questo mese nel campo corre notizia di offensive americane e russe. Preghiere a S. Giuseppe. Partono i sacerdoti tedesebi, una ventina al giorno, in ordine alfabetico.
1aprile 1945: in infermeria muore il domenicano p. Girotti, noto biblista. Per molta parte di marzo e per tutto aprile c’è nel campo una grave infezione di tifo. Morti a migliaia.
2 aprile 1945: Pasqua degli ital iani.
6 aprile 1945: irruzione delle SS nella baracca dei sacerdoti, sospettati di tenere armi. Non trovano nulla.
9 aprile 1945: il padre Giannantonio è impegnato a prendere le generalità degli italiani giunti da altri campi, specialmente da quello di Hersbruck. Ha le prime dolorose informazioni sulla sorte toccata a tanti cari amici. Sofferenza per la morte di Teresio Olivelli. Allarme. Battaglia aerea. Da questo giorno si ode lontano il cannone. Gli alleati si avvicinano sempre più.
26 aprile 1945: ore 9: indetto per le ore 12 l’appello in piazza: tutti devono essere pronti per la partenza dal campo. Partono i russi ed i tedeschi rimasti.
27 aprile 1945: ordini e contrordini di adunate e partenze. Le SS per la prima volta dimostrano di non saper cosa fare. Gli americani sono ormai vicinissimi al campo.
28 aprile 1945: ore 10: grande allarme. Fuga delle SS.
29 aprile 1945: ore 9: gli americani incominciano l’attacco. Alle 17.30 entrano vincitori e liberatori nel campo. Nella notte le SS tentano di riprendere il campo per fucilare gli internati; ma sono vinte e passate per le armi. In infermeria muore don Seghezzi.
I maggio 1945: ore 11: parla in piazza del campo il comandante della 7a armata americana. Il discorso è tradotto in tutte le lingue.
3 maggio 1945: solenne Messa funebre per ricordare tutti i morti nel campo: ore 8 di sera. Tra le carte personali di una SS viene trovato l’ordine di Himmler di fucilare tutti gli internati. La eliminazione dei prigionieri era stabilita nei giorni 29 e 30 aprile.
4 maggio 1945. ore 11: festa dei polacchi. Messa solenne in piazza. Costituzione dei Comitati nazionali per il governo del campo. Miglioramento immediato del cibo. Cure mediche più urgenti.
11 maggio 1945: partenza degli olandesi.
12 maggio 1945: partenza dei belgi. In questi giorni, mentre molte delegazioni straniere vengono a visitare e confortare i loro connazionali, nessun italiano si fa vedere al campo. Umiliazione e avvilimento dei nostri.
24 maggio 1945: «Oggi ci si assicura che partiremo per il giorno 27».
25 maggio 1945. «Arriva una delegazione vaticana».
28 maggio 1945: partenza da Dachau per l’Italia su autocarri americani.
29 maggio 1945: ore 23: arrivo a Milano. L’abbraccio dei confratelli. Nei gioni successivi al suo rientro il padre Giannantonio si reca in visita a S. Em. Il card. Schuster, che lo trattiene a lungo e lo esorta vivamente a scrivere le memorie.
Padre Giannantonio da Romallo, si è spento alle ore 19.10 del 25 agosto 1967 nel Convento dei Cappuccini di viale Piave, 2 a Milano.