“He who controls the past controls the future.
He who controls the present controls the past.”
George Orwell, 1984
SOCIETA’ SEGRETE

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”
Franklin D. Roosevelt
“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.”
Giovanni Falcone
ai Magistrati e alle Forze dell'Ordine, che, quotidianamente, sono impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
A chi sostiene che tanto non cambierà mai nulla, vorrei dire:
“Il problema siamo tutti noi che non facciamo nulla.
Stabiliamo una presenza costante o avremo una costante violenza.
Meglio provare e non riuscire che non riuscire a provare!”
Daniela Zini
Crediamo, veramente, di conoscere tutto ciò che accade sul nostro pianeta?
Gli uomini che occupano uno spazio di primo piano sulla scena politica dispongono di un potere reale?
Il mondo degli affari è viziato da società segrete?
Molti sostengono che potenti personaggi esercitino un controllo assoluto su tutti gli eventi mondiali.
È il problema essenziale che tratteremo in questa inchiesta, dove si dimostra, attraverso una serie di esempi stupefacenti, che la sorte delle Nazioni dipende, sovente, dalla volontà di gruppi di uomini che non hanno alcuna funzione ufficiale. Si tratta di società segrete, veri cripto-governi, che reggono la nostra sorte a insaputa di tutti. La loro esistenza non può essere avvertita che quando un fatto imprevisto li obbliga ad agire alla luce del sole.
Circa due anni e mezzo prima del suo assassinio, il 27 aprile 1961, John Fitzgerald Kennedy tenne ai rappresentanti della stampa, riuniti presso l’Hotel Waldorf-Astoria di New York, un discorso incentrato sulla analisi e sul pericolo della Guerra Fredda [http://www.youtube.com/watch?v=PFMbYifiXI4] [1], tuttavia, alcuni suoi passaggi, sembrano alludere, non alla sfida acerrima contro l’Unione Sovietica, ma a qualcosa di altro di più oscuro e di più pericoloso.
“[…] La stessa parola “segretezza” è ripugnante in una società libera e aperta; e noi, come popolo, siamo intimamente e storicamente contrari alle società segrete, ai giuramenti segreti e alle procedure segrete. Abbiamo deciso, molto tempo fa, che i pericoli di un eccessivo e ingiustificato occultamento di fatti pertinenti superino, di gran lunga, i pericoli che vengono invocati a giustificazione. […]”
La storia è costellata di enigmi intorno alle società segrete, che si tratti di potenti organizzazioni economiche, sociali, politiche o di clubs privati riservati a una élite.
Pressoché tutte le civiltà sono state, in un’epoca o in un’altra, il rifugio di queste società dell’ombra: riunioni dietro porte chiuse, divieto di rivelare ciò che si dice all’esterno, sospetto a ogni gesto o parola di uno dei membri...
Il mistero di cui le società segrete si ammantano non è avulso dall’interesse che suscitano appena se ne parli.
E se si cercasse di squarciare questo mistero?
Che ne è della sedicente influenza delle società segrete attraverso la storia?
Sono state, sono così potenti come si pretende?
Vi è motivo di temerle?
Tante domande alla partenza di una appassionante incursione nel cuore delle società segrete più celebri della storia.
In questo reportage, solidamente documentato, penetreremo all’interno delle società segrete più conosciute, riassumendone la storia, descrivendone i riti di iniziazione, i segni e il linguaggio, che sono loro propri.
Se le voci che circondano le società segrete, rispondono, in parte, alla sete di meraviglioso, che ci viene dalla nostra infanzia, contribuiscono, troppo sovente, ad assumere un pensiero non critico, che degenera, facilmente, in paranoia.
Dedicare una inchiesta alle società segrete in un mondo, in cui la cultura del segreto [di Stato, scientifico, nucleare, ecc.] viene, incessantemente, a ricordarci che, in quanto semplici cittadini, noi restiamo fuori degli arcani di una conoscenza superiore, cui solo gli “eletti” [capi di Stato, militari, diplomatici, spie, ecc.] possono accedere, mi è sembrata una idea luminosa e illuminante.
Non sono, certo, la prima, tuttavia, i miei predecessori sono stati, sovente, credibili, ma discutibili, perché, occorrendo un inizio di cui non si aveva prova, questo è stato, sovente, su un continente scomparso o su un disco volante.
Una delle numerose tesi ricorrenti sulle società segrete è che le suddette società segrete funzionino come le nostre società “reali”, di cui rappresentano dei doppi sovversivi, critici, inaccessibili, ma anche necessari per controbilanciare l’ordine mondiale, governato dai poteri temporali, sensatamente trasparenti, perché eletti secondo principi democratici.
Scrive Georg Simmel:
“Le società segrete sono, per così dire, delle repliche in miniatura del “mondo ufficiale”, al quale resistono e si oppongono.”
L’inizio delle società segrete si perde, necessariamente, nella rarefazione delle tracce di un passato sempre più lontano: Grecia, Egitto dei faraoni neri, Sumer e, forse, oltre…
“In principio era il buio.”
Sarebbe stato più comodo iniziare dalla fine, giacché le società stesse sono alla ricerca delle loro origini.
“Poi fu la luce.”
"Allorché si ergeva nella direzione da cui veniva la luce, l’uomo era in contatto con il divino e le difficoltà materiali della vita, che, forse, formavano, allora, una unica cosa, ma che sarebbero divenute, con la nascita del verbo e il risveglio dell’uomo alla parola, i due poli della sua esistenza."
Nessuno sa quanto tempo l’uomo sia vissuto al riparo del dubbio neppure se ne sia stato, mai, abitato.
Ma che la sua prima parola sia stata un inno alla natura o una espressione del suo bisogno alimentare… ben presto, l’uomo iniziò a tentare di condividere le proprie idee con i suoi fratelli e, ben presto, i più sottili di questi concetti richiesero più che parole: la trasmissione dell’esperienza e, dunque, l’iniziazione.
È possibile che le prime iniziazioni abbiano riguardato il modo di sopravvivere nella divina natura circostante. O che abbiano trasmesso la certezza di un mondo spirituale nascosto dietro la materia.
Nell’Antichità, i culti misterici si svilupparono e conobbero un grande favore nel mondo greco-romano.
In seguito, il Medioevo, teatro di guerre di religione, dette vita ai misteriosi Templari.
Nel Rinascimento, le società segrete assunsero tutta un’altra dimensione con il leggendario ordine dei Rosa-Croce e, soprattutto, con la nascita della Massoneria.
Il XIX secolo segna, ancora, un’altra svolta: la proliferazione delle società segrete, che hanno, come corollario, legittimazioni, prestiti sempre più diversificati e una attrattiva per la razionalità scientifica.
Il periodo contemporaneo è segnato da una moltiplicazione di società segrete, in particolare nell’era di Internet, con possibili derive settarie a apocalittiche.
La storia delle società segrete ha una importante influenza sulla storia. Esiste una versione ufficiale della storia, versione detta esoterica, che tiene conto delle società segrete, perché sono, sovente, uscite dall’ombra.
Ma ciò che questa storia non dice sono le ragioni segrete dei loro interventi.
E, per comprenderle, è alla storia esoterica che bisognerà interessarsi.
Queste società segrete sono, profondamente, legate alla magia, a partire dai documenti più antichi in nostro possesso.
Vi farò la grazia, tuttavia, di farne ricadere la colpa, come è, sovente, il caso, sui massoni, sui sionisti o su Satana.
Andrò, subito, al cuore del problema, esprimendomi senza ambage, senza temere di affrontare i sistemi criminali, basati sul controllo, il potere e la manipolazione.
Un nuovo modo di considerare il mondo in cui viviamo!
I. LA CAMORRA
La camorra è, oggi, una grossa e grassa holding, che trae i principali proventi dal crimine e che controlla una serie di attività non necessariamente criminose, anche attraverso i normali canali di mediazione sociale, con il mezzo dell’intimidazione o dell’acquisizione del consenso politico. La camorra ha subito una evoluzione, nel secondo dopoguerra, al punto da perdere, anche se non completamente, quelle connotazioni che l’avevano resa nota e la distinguevano da altre manifestazioni delinquenziali come la mafia e la ‘ndrangheta. Dopo essere stata per anni subordinata alle oligarchie politiche locali, per ottenere appalti e controlli che hanno assunto il carattere della semiufficialità [quali quelli sui mercati ortofrutticoli, del pesce, delle carni, del lavoro, ecc.], la camorra, avendo, oggi, raggiunto una sua indipendenza finanziaria, può condizionare gli antichi padroni, che alla organizzazione criminosa sono costretti a ricorrere nei periodi elettorali, e imporre anche a loro le sue leggi e le sue tangenti.
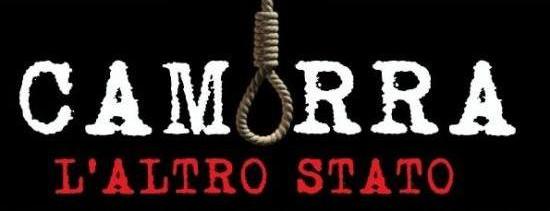
La camorra è un fenomeno meridionale dalle radici antiche: la sua origine risalirebbe, infatti, alla metà del Quattrocento. Istituzione repressiva con il crisma della semiufficialità, nel periodo borbonico, ha assunto, dal secondo dopoguerra, le dilaganti proporzioni di una holding della malavita organizzata, che ha esteso il suo capillare controllo sui rami attivi della società partenopea.
Se si legge lo statuto della camorra [il frieno, come veniva chiamato], reso noto in una storica assemblea di camorristi che si tenne, il 12 settembre 1842, nella chiesa di Santa Caterina, a Formello, si potrà notare che molti usi, allora in vigore, siano scomparsi, ma che, nei comportamenti dei camorristi di oggi, non è scomparso lo spirito informatore di quell’eccezionale documento, forse l’unica “legge fondamentale” della camorra giunta fino a noi.
Quello che si è conservato, fino ai nostri tempi, è un certo senso dell’onore – almeno, così, lo intendono i camorristi – di fedeltà alle leggi, che regolano la associazione criminosa o, più genericamente, una semplice omertà.
Fondamentale, tuttavia, è una particolare diversità tra la situazione attuale e quella che si può dire storica: mentre fino al periodo fascista la organizzazione della camorra, a Napoli, fu, strettamente, verticistica [un capintesta e dodici capintrini o capisocietà, quanti erano i quartieri storici napoletani], oggi la camorra è divisa in famiglie, delle quali una sola è autenticamente napoletana [urbana], mentre tutte le altre sono del circondario e della provincia napoletana, pur avendo, tutte, alcune zone di Napoli, quale principale campo di operazione.
Così non esiste più, a esempio, uno degli usi fondamentali: l’olio alla Madonna, che era la contribuzione richiesta a tutti i carcerati per tenere accesa davanti all’immagine sacra una lampada, ma, in effetti, per dividersi tutto quello che eccedeva quella piccola spesa e per imporre, comunque il dominio della camorra sulla vita carceraria.
Ma se le nuove tecnologie hanno fatto cadere in disuso l’olio alla Madonna, è proprio il carcere – e non deve essere, necessariamente, un carcere napoletano – che mantiene le caratteristiche di “conservatorio” di certi costumi camorristici. È là che il camorrista apprende il rispetto dovuto al suo capo, un rispetto che si concretizza in una serie di obbedienze e servizi [un capo, in carcere, non si rifarà mai il letto, trovando, sempre, chi è disposto a farlo per lui].
Degli antichi riti, usi e costumi della camorra vi è testimonianza in uno dei molti volumi sulla malavita a Napoli, pubblicati da Abele De Blasio, negli ultimi anni dell’Ottocento. De Blasio fu fondatore e direttore dell’Ufficio Antropometrico della Questura di Napoli e, quel che più conta, seguace di Cesare Lombroso, al quale dovette fornire, per la particolarità del suo osservatorio, molti dati, sui quali lo studioso fondò le sue teorie di antropologia criminale.
Negli anni in cui De Blasio lavorò alla Questura di Napoli, non vi fu cranio di camorrista che sfuggisse alle sue misurazioni, o confidenza che non venisse, attentamente, trascritta.
Una attenzione particolare De Blasio prestò al tatuaggio dei camorristi, al punto da darne una copiosa catalogazione: tatuaggio religioso, d’amore, di nomignolo, di graduazione, di disprezzo, di professione, di bellezza, di data memorabile, osceno, simbolico misto.
Sovente, il tatuaggio era indicativo della specializzazione del camorrista e, molte volte, indicava la sua particolare devozione. Uno dei camorristi osservati da De Blasio aveva sul torace la seguente iscrizione: “A.S.D.P. [Anima Santa Del Purgatorio] – allicordati [ricordati] – di – me – perché io – penso a te.”
Un rituale particolare era usato per le cerimonie di ammissione alla Società Minore [picciotto] e a quella Maggiore [camorrista], entrambe fondate su formule prese in prestito da altri ambienti sociali e, quindi, auliche, spagnolesche o, comunque, cortesi. Il camorrista doveva, in ogni caso, dimostrare il proprio coraggio e, in molti casi, la propria ferocia, caratteristiche che vengono richieste anche oggi.
Una delle prove più usuali era quella di mettere una moneta al centro di un tavolo: il candidato doveva prenderla, mentre tutti gli altri convenuti alla cerimonia, armati di coltello, dovevano impedirglielo colpendolo. Molte volte la mano del candidato veniva trapassata da una coltellata.
Altre volte la prova di coraggio si svolgeva durante una zumpata, duello al coltello, che finiva, di solito, almeno con uno sfregio al volto, quando la società non aveva deciso che uno dei due dovesse soccombere.
Prova finale per l’ammissione al grado di camorrista era la tirata a dovere, un duello simbolico, alla fine del quale il candidato doveva ferire all’avambraccio lo sfidante.

Uomini e donne della camorra sfregiati
Che cosa è la camorra?
Qualcuno potrebbe pensare all’attività, certamente illecita, di chi guadagna indebitamente sul lavoro di altri. Il discorso non è così semplice: il camorrista minaccia e intimidisce, e, non sempre, per il solo guadagno; impone tasse, prende le cose altrui senza pagare. Non solo, ma impone ad altri di commettere delitti, ne commette egli stesso, obbligando altri a dichiararsene autori; protegge i colpevoli contro la giustizia, esercita il proprio mestiere di camorrista su tutto, nelle vie, nelle case, nei ritrovi, sul gioco, sul lavoro, sugli stessi delitti. L’organizzazione più perfetta della camorra è nelle carceri e, così, quando si crede di punire un camorrista mettendolo in galera, non si fa che dargli modo di continuare, in maniera migliore, a esercitare l’opera sua.
Questa definizione, che mi pare corrisponda con grande approssimazione alla realtà odierna, fu formulata, nel marzo del 1875, e pubblicata su L’opinione di Torino. Autore ne è Pasquale Villari, uno dei patrioti fuggiti da Napoli, dopo la rivoluzione del 1848, allievo di Francesco De Sanctis, docente di storia a Pisa e, poi, a Firenze, esponente del positivismo in Italia, deputato della destra, rappresentante dell’opposizione meridionale.
Sulla camorra, uno dei mali maggiori, insieme con il brigantaggio e la mafia, nell’Italia meridionale, all’indomani dell’unificazione, Pasquale Villari aveva, già, scritto un articolo intitolato La camorra e il progresso del popolo, pubblicato, il 5 ottobre 1861, da La perseveranza di Milano. Ma quel che, nel 1861, è soltanto una testimonianza o una denuncia, quattordici anni dopo, assume i contorni di una analisi molto più motivata, condotta con una metodologia che, chiaramente, appare accompagnare i primi passi delle scienze sociali, tendenti a riconoscere i contorni precisi del fenomeno e a identificarne le cause. Queste analisi sono raccolte in un volume pubblicato, nel 1878, con il titolo Lettere meridionali. Vale la pena di leggere qualche brano, sottolineando la carica esplosiva di certe rivelazioni per i ceti sociali contro i quali tali denunce erano dirette.
“La camorra”,
scrive Villari,
“non si esercita solo negli ordini inferiori della società: vi sono anche camorristi in guanti bianchi e abito nero, i cui nomi e i cui delitti da molti pubblicamente si ripetono.”
Non è necessario qui notare l’attualità di una simile affermazione.
Ma proseguiamo.
“Perché la camorra divenga possibile, occorre che vi sia un certo numero di cittadini, o anche una classe intera, che si pieghi alle minacce di pochi o di molti, che siano organizzati.”
Pare di sentir parlare della Nuova Camorra Organizzata, di Raffaele Cutolo, uno dei più temuti capi della camorra negli Anni Ottanta.
“Una volta che questo fatto, per qualche tempo, si avvera in proporzioni abbastanza larghe, riesce facile assai capire in che modo la malattia si estenda a poco a poco, e pigli forme diverse, secondo che penetra nei diversi ordini della società. Il male è contagioso come il bene”,
sentenzia Villari,
“e l’oppressione, specialmente quella esercitata dalla camorra, corrompe l’oppresso e l’oppressore, e corrompe ancora chi resta lungamente spettatore di questo stato di cose, senza reagire con tutte le sue forze.”
Sono gli stessi concetti – il fondamentale pericolo dell’assuefazione – affermati alla televisione il 10 giugno 1982 – e, quindi, più di cento anni dopo] dal prefetto di Napoli, Riccardo Boccia, che parlava all’indomani della chiusura di tutti i negozi di un quartiere napoletano, chiusura imposta dalla camorra, in ossequio alla morte di uno dei suoi capi.
Villari identifica, fin da allora e chiaramente, le origini sociali della camorra, come del brigantaggio postunitario. Nella miseria estrema del popolo, nel degrado morale, nella sopraffazione la camorra nasce “come forma naturale di questa società”.
Che fare?
Studiare il male per cercarne i rimedi e, quindi, innanzitutto, comprendere il fenomeno.
“E voi, mi si dirà, avete l’ingenuità di credere”,
conclude lo scritto di Villari,
“che in breve si può rimediare a mali così gravi e profondi? Non vedete che ci vuole un secolo? Sì, lo vedo, ma vedo ancora che se cominceremo domani, ci vorrà un secolo e un giorno.”
Sono trascorsi più di centocinquanta anni da allora e la camorra, incredibilmente, è ancora padrona incontrastata di Napoli e di quella vastissima area che la circonda, un ininterrotto agglomerato di centri abitati, nei quali la densità della popolazione è tra le più alte del mondo.
Come la mafia, la camorra ha una lunga storia. Tanto che la stessa origine della parola è incerta.
Secondo alcuni deriva da un antico tema mediterraneo, mor[r]a, che significa gregge, banda e la radice sarebbe parallela a nur[r]a, da cui nuraghe, mucchio di pietre. La parola esiste anche in spagnolo, ma con il significato di rissa, lite, e, quindi, gli studiosi hanno cercato ancora, ma con esiti incerti.
Marc Monnier, scrittore svizzero, che fu, a Napoli, a lungo, prima e dopo il 1860, autore del noto L’Italia è terra dei morti? e di due studi fondamentali sul Brigantaggio, pubblicato nel 1862, e sulla Camorra, apparso l’anno successivo, dice anch’egli dell’origine spagnola della parola, derivante dal vocabolo gamurra, che indica un rozzo abito spagnolo. Giustamente Marc Monnier si richiama ad alcune novelle di Miguel de Cervantes Saavedra, che fu, a lungo, a Napoli per riferire di alcune imprese prettamente camorristiche, perpetrate a Siviglia, e a una delle sentenze di Sancho nella sua isola di Baratteria, per rilevare l’origine spagnola della camorra. Baratteria viene definita, in una prammatica siciliana del Cinquecento, la camorra sulle case da gioco e, in un’altra prammatica del 27 settembre 1573, firmata dal vicerè cardinale Gran Vela, l’estorsione ai danni di carcerati:
“A nostra notizia è pervenuto che dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria si fanno molte estorsioni dai carcerati, creandosi l’un l’altro priori in dette carceri, facendosi pagare l’olio per le lampade e facendosi dare altri illeciti pagamenti, facendo essi da padroni in dette carceri.”
L’alto prelato immaginò un singolare mezzo per domare la camorra: la sottopose a due tratti di corda. Ma sembra che il supplizio non bastasse, se in un altro documento, conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, Relazione dello stato delle carceri della G. C. della Vicaria di Napoli e delle mutazioni fatteci e mantenute sino al presente 1674 per mezzo della missione perpetua istituitavi dai PP. della Compagnia di Gesù, si legge:
“Nelle prigioni i furti erano tali, che appena entrato uno nelle carceri s’eran già venduti li vestiti e quel che è peggio si trovava spogliato senza accorgersene, e se ben s’accorgeva non poteva parlare per timore della vita, poiché con più facilità si facevano omicidi, avvelenazioni ec. dentro le carceri che fuori. E grandi erano i maltrattamenti che si facevano a quelli che venivano carcerati o per occasione di torgli qualche danaro sotto colore che ognuno, quale entra di nuovo carcerato, li facevano pagare la lampa, o sotto altro titolo che si tace per modestia.”
Ma i sermoni dei Gesuiti non sortirono migliore effetto della corda del cardinale. Si narra, infatti, che uno dei padri, intento a redimere un detenuto, parlandogli della grazia di Dio, ottenesse per tutta risposta un poco collaborativo ed offensivo:
“Padre, se tu mi dai un carlino per comperarne tanta salsiccia, ti darò tutta questa grazia di Dio che tu mi hai offerta.”
Marc Monnier si domanda, poi, se non sia il caso di far risalire l’istituzione della camorra a Napoli, perfino, alla metà del Quattrocento, poco dopo la fondazione della Honorata Compagnia de la Guarduna, in Spagna, nel 1417. Questa compagnia riuniva in una temibile associazione i “baratori di carte, i ladri delle vie, i tirannelli delle prigioni, e tutti i sanguinari del paese”.
Lo statuto della Guarduna, pubblicato, integralmente, da Vittorio Paliotti, nella sua Storia della camorra, sembra il modello dell’organizzazione delittuosa napoletana, con le sue gerarchie e i suoi riti.
Si può dire che, dall’arrivo degli aragonesi a Napoli [1442], e più ancora per tutto il periodo della dominazione spagnola, i riferimenti all’attività criminale della camorra, anche se il nome, raramente, si trovi nei documenti, siano costanti. Non ci sembra qui il caso, né si avrebbe lo spazio, di farne l’elenco. Converrà giungere all’epoca borbonica e al 1820 generalmente considerato la data della costituzione ufficiale della Bella Società Riformata [riformata sta per confederata], che prese dalle società segrete i rituali e certe regole.
Gli esponenti della camorra dei dodici quartieri napoletani si riunirono nella chiesa di Santa Caterina, a Formello, e, nel corso di una solenne cerimonia, diedero un nuovo statuto alla loro organizzazione che era retta da un capintesta, e da dodici capintrini o capisocietà, uno per quartiere. Ogni capintrino aveva il suo segretario [contaiuolo] e poteva disporre di un certo numero di capiparanza [capigruppo] e di un camorrista di giornata [una specie di ufficiale di picchetto].
La camorra era, essenzialmente, apolitica, anche se approfittò, sempre, delle contingenze politiche. È del 1821 [l’epoca dei moti rivoluzionari napoletani] la canzoncina che vale la pena di riferire per il suo valore documentario:
“Nui nun simmo cravunare
Nui nun simmo realiste
Nui facimmo ‘e cammurriste
Iammo ‘nculo a chillo e a chiste.”
Il riferimento alla Carboneria e ai Calderai borbonici è evidente.
Questa organizzazione criminale si reggeva su regole ferree [le cosiddette leggi d’onore] e su una struttura piramidale divisa, si può dire, in due parti: una Società maggiore, di cui facevano parte tutti i camorristi, e una Società minore, la quale comprendeva tutti coloro che, pur essendo stati ammessi nell’associazione criminosa e pur lavorando per essa, non ne facevano parte a pieno titolo. La Società minore era una zona di parcheggio, o meglio, una specie di scuola di perfezionamento, nella quale si entrava con il titolo di giovanotto onorato per guadagnare, via via, i galloni di picciotto e di picciotto di sgarro. La permanenza in questo stato di minorità, a volte, era molto lunga e, soltanto alla fine di una lunga e provata milizia, dopo aver superato severe prove, si poteva assumere il titolo ufficiale di camorrista.
Data una occhiata sommaria all’organizzazione della camorra, torniamo alla nostra storia, che vede uno dei momenti fondamentali dell’associazione nel 1860 e, precisamente, nei mesi che precedettero e seguirono l’arrivo di Giuseppe Garibaldi, a Napoli, il 7 settembre. Il passaggio al nuovo stato di cose era, generalmente, auspicato in odio alle atrocità borboniche del 1848, ma anche per quella diffusa attesa del nuovo che prese i napoletani, come aveva preso, in quegli anni fatali, tutti gli altri italiani.
Ma si aveva paura.
Paura che la plebe approfittasse dell’evento e dei momenti di vuoto di potere, per abbandonarsi a saccheggi e a uccisioni, come era avvenuto a Napoli, nel 1799, e, in misura minore, nel 1848.
E, allora, che fare?
Dalle rivelazioni di un camorrista pentito – così lo definisce Marc Monnier: con il passare degli anni certe definizioni non cambiano – si apprende che, al tempo dei Borbone, la setta era posta sotto la sorveglianza della polizia. Il prefetto non si limitava a prendere la sua parte di barattolo [il danaro estorto dai camorristi], ma “presiedeva all’organamento della società segreta e nominava egli stesso i capi dei dodici quartieri, ciascuno de’ quali avea una provvisione di cento ducati al mese, pagata sui fondi segreti della polizia. In ricambio i funzionari governativi incaricati di vegliar alla pubblica sicurezza non sdegnavano di riempir le loro tasche con il denaro estorto ai poveri da questi malandrini a ciò autorizzati. Quando si divideva il carusiello [salvadanaio] un terzo dei benefici era religiosamente portato al commissario, che a sua volta lo divideva coll’ispettore di servizio e col caposquadra”.
In questo clima di collusione, ben si comprende come i liberali dovessero sottostare a ogni ricatto, sotto la minaccia di una denuncia alla organizzatissima polizia di Ferdinando II. Le vittorie di Garibaldi in Sicilia, la caduta di Palermo, in particolare, fanno accettare a Francesco II, da poco salito al trono, il suggerimento francese di dare la costituzione. Proclamata la costituzione, il 25 giugno 1860, le prigioni si aprirono e ne uscirono frotte di camorristi.
“Il loro primo atto”,
scrive Marc Monnier che fu testimone dei fatti,
“fu di assalire il commissariato di polizia e di abbruciare tutte le carte; dopo di che presero gli sbirri a colpi di bastone. Lasciati a se stessi avrebbero messo Napoli a ferro e fuoco.”
E, qui, si impone la figura di Liborio Romano, una delle più contraddittorie della storia napoletana, nominato in quei giorni prefetto di polizia da Francesco II e, successivamente, ministro dell’interno. Liborio Romano, aveva inequivocabili precedenti politici e, per questi, era stato scelto dal re Borbone; aveva preso parte alle rivoluzioni del 1820-21 e del 1848 ed era stato, ogni volta, arrestato e imprigionato per lunghi anni. Nel 1860, sarà ministro di Francesco II [al momento della partenza il re gli dirà: “Don Liborio, guardatevi il collo!”] e, poi di Garibaldi, ma, tra l’una cosa e l’altra, troverà modo di tradire tutti, accordandosi, perfino, con Camillo Benso di Cavour nel tentativo di provocare l’annessione di Napoli al Piemonte, prima dell’arrivo delle Camicie Rosse; e questo, mentre aveva contatti segreti con Alexandre Dumas, ancorato con la sua goletta, nel porto di Napoli, per preparare l’arrivo di Garibaldi.
Liborio Romano, tuttavia, è il vero artefice dal passaggio indolore del Regno di Napoli dai Borbone ai Savoia, nel senso che, come ministro dell’interno del re, che andava via, e, poi, di Garibaldi, riuscì a fare in modo che quei saccheggi, che si temevano, non avvenissero, e che Garibaldi entrasse a Napoli, seguito solo da dodici persone, tra le quali, lui, Liborio Romano, sotto gli occhi dei soldati borbonici, armati di tutto punto.
E questo riuscì a farlo con l’aiuto della camorra.
Ma cediamo la parola al testimone dei fatti, Marc Monnier:
“Don Liborio… immaginò una guardia cittadina composta di questi malfattori, che sperava così arruolare nella società onesta. I picciotti di sgarro tenevano il luogo dei birri violentemente cacciati: ogni camorrista in capo divenne caposquadra. Fu una rivoluzione subitanea nel servizio della pubblica sicurezza. E debbo dirlo, tale rivoluzione riuscì pienamente nei primi mesi. La camorra non si servì soltanto della sua influenza per prevenire le rivolte, ma impedì fino ai più piccoli delitti: non vi fu mai un sì piccol numero di furti quanto nei primi giorni della sua sorveglianza imperiosa e diligente. La guardia cittadina non aveva ancora uniformi, discipline, regolamenti stabiliti: si componeva di popolani vestiti da semplici operai, armati di grossi bastoni, non aventi altro segnale di riconoscimento fuor di una coccarda tricolore ai loro baschetti [sic]. Pure essa si fece rispettare e temere più assai dei “feroci” a malgrado del vestiario, delle fisionomie, della daga, del fucile, del volto severo e truculento di questi antichi sbirri. Essa si condusse coraggiosamente, e ciò che sembrerà più strano onestamente.”
Ma questa buona condotta durò poco:
“Addivenendo poliziotti avevano cessato di essere camorristi, tornarono camorristi senza cessare di essere poliziotti”,
in altri termini, si misero accanto ai doganieri a prelevare una loro privata gabella. All’arrivo delle merci ai varchi doganali si avvicinavano ai doganieri imbracciando i fucili e dicevano:
“Lasciate passare, appartiene a Garibaldi.” [È roba d’o si’ Peppe.]
I doganieri erano costretti ad allontanarsi e il tributo veniva pagato ai camorristi. Finché, un giorno il dazio incassò soltanto 25 soldi e, in una notte, vennero arrestati 90 camorristi. Il giorno dopo, si incassarono 3400 lire.
A infliggere quel colpo alla camorra, e, a dichiararle, da quel momento, una guerra senza quartiere fu Silvio Spaventa, condannato a morte dai Borbone ed esiliato dopo otto anni di galera. Era, come il fratello Bertrando, uno studioso di filosofia, ma, fino dal tempo della luogotenenza, accettò di essere ministro di polizia.
Il tentativo di Garibaldi di raggiungere Roma consente al governo di dare a La Marmora tutti i poteri sulle province meridionali e, il 24 agosto 1862, il generale proclama lo stato di assedio. Efficace contro Garibaldi, ferito ad Aspromonte, efficace contro il partito di azione, di cui molti esponenti furono imprigionati senza nessun ricorso all’autorità giudiziaria, lo stato di assedio fu efficace anche contro la camorra. Non lo fu contro il brigantaggio e, per questo, quando, nel mese di novembre, lo stato di assedio fu tolto, si vide la necessità di prolungarne gli effetti, facendo ricorso a una legge speciale, la legge 15 agosto 1863, n. 1409, nota come legge Pica, dal nome del suo promotore, il deputato abruzzese Giuseppe Pica. Come lo stato di assedio, la Legge Pica fu estesa anche alla camorra. Ma le cose dovettero tornare al punto di partenza se, nel giugno del 1875, il presidente del consiglio Marco Minghetti faceva approvare una legge, composta di un unico articolo, con la quale “nelle province e nei comuni dove la sicurezza pubblica sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti e da altri reati contro le persone e contro le proprietà” [si intendeva operare nelle province meridionali per stroncare mafia e camorra] furono sospese le garanzie costituzionali e i prefetti ebbero la facoltà di inviare a domicilio coatto da uno a cinque anni, con semplice decreto.
Come sempre, la camorra riprende forza quando, attraverso i deputati locali, serve il potere. Per questo, a ragione, Gaetano Salvemini definì Giovanni Giolitti “il ministro della malavita”. Della camorra ci si serviva non soltanto al momento delle elezioni, ma anche per muovere dimostrazioni di piazza, come accadde nell’agosto del 1893, a Napoli, per i fatti di Aigues-Mortes. Il 15 agosto, un gruppo di operai italiani, che lavoravano nelle saline di Aigues-Mortes, si scontrarono con operai francesi: sette italiani vennero uccisi e trentaquattro gravemente feriti.
La Francia ebbe, in quella occasione, uno dei suoi ricorrenti rigurgiti di intolleranza!
Giolitti ebbe bisogno di manifestazioni popolari contro la Francia, che, a Napoli, furono organizzate dai camorristi, tornati a essere agli ordini delle prefetture e delle questure nei centri del Mezzogiorno. Malauguratamente, il 25 agosto, in via Foria a Napoli, dal moschetto di un carabiniere partì un proiettile che uccise un ragazzo di tredici anni. Un giornalaio mise in una cesta quel corpo e si mise alla testa di un corteo che si diresse verso la prefettura.
Tutta la città era in sciopero e in tumulto.
Il prefetto convocò nel suo ufficio quello che era allora il capo della camorra napoletana, Ciccio Cappuccio.
Un’ora dopo la città era tornata tranquilla.
Un colpo decisivo alla camorra lo dettero, nel primo decennio del secolo scorso, i carabinieri e per loro il capitano Carlo Fabbroni, che, indagando sul delitto Cuocilo, l’uccisione di un ricettatore e della sua donna, portò le prove, criticate e non ritenute autentiche da molti, sulle quali fu imbastita l’accusa al processo celebrato a Viterbo, dall’11 marzo 1911 all’8 luglio 1912: il famoso processo Cuocolo, che fu detto anche “il processo alla città”, per le collusioni che le indagini rivelarono tra la camorra e una certa parte della società napoletana.
Quando, nel 1927, Gennaro Abbatemaggio, che era stato il principale testimone di accusa, presentò un memoriale, nel quale si dichiarava che tutti gli imputati erano innocenti e che le sue affermazioni contro di loro erano solo frutto di fantasia, la camorra era quasi inesistente a Napoli. Tanto che Mussolini sulle domande di grazia poté scrivere:
“Si provveda, spaziando i provvedimenti nel tempo.”
La camorra ricompare a Napoli soltanto nel secondo dopoguerra, prima occupandosi, quasi esclusivamente, del contrabbando di sigarette, poi, estendendo il suo controllo agli appalti, al commercio del latte, della frutta, del pesce, delle carni.
Solo più recentemente, in collegamento con la mafia siciliana e con la malavita statunitense, arriva al contrabbando della droga e, quindi, estende alle corse dei cavalli, alle sale da gioco e all’edilizia il suo enorme giro di affari.
Ma questa è storia dei nostri giorni.
Una storia insanguinata da centinaia e centinaia di morti.
Note:
[1]
President John F. Kennedy
Waldorf-Astoria Hotel, New York City
April 27, 1961
Mr. Chairman, ladies and gentlemen:
I appreciate very much your generous invitation to be here tonight.
You bear heavy responsibilities these days and an article I read some time ago reminded me of how particularly heavily the burdens of present day events bear upon your profession.
You may remember that in 1851 the New York Herald Tribune under the sponsorship and publishing of Horace Greeley, employed as its London correspondent an obscure journalist by the name of Karl Marx.
We are told that foreign correspondent Marx, stone broke, and with a family ill and undernourished, constantly appealed to Greeley and managing editor Charles Dana for an increase in his munificent salary of $5 per instalment, a salary which he and Engels ungratefully labelled as the “lousiest petty bourgeois cheating.”
But when all his financial appeals were refused, Marx looked around for other means of livelihood and fame, eventually terminating his relationship with the Tribune and devoting his talents full time to the cause that would bequeath the world the seeds of Leninism, Stalinism, revolution and the cold war.
If only this capitalistic New York newspaper had treated him more kindly; if only Marx had remained a foreign correspondent, history might have been different. And I hope all publishers will bear this lesson in mind the next time they receive a poverty-stricken appeal for a small increase in the expense account from an obscure newspaper man.
I have selected as the title of my remarks tonight “The President and the Press.” Some may suggest that this would be more naturally worded “The President Versus the Press.” But those are not my sentiments tonight.
It is true, however, that when a well-known diplomat from another country demanded recently that our State Department repudiate certain newspaper attacks on his colleague it was unnecessary for us to reply that this Administration was not responsible for the press, for the press had already made it clear that it was not responsible for this Administration.
Nevertheless, my purpose here tonight is not to deliver the usual assault on the so-called one party press. On the contrary, in recent months I have rarely heard any complaints about political bias in the press except from a few Republicans. Nor is it my purpose tonight to discuss or defend the televising of Presidential press conferences. I think it is highly beneficial to have some 20,000,000 Americans regularly sit in on these conferences to observe, if I may say so, the incisive, the intelligent and the courteous qualities displayed by your Washington correspondents.
Nor, finally, are these remarks intended to examine the proper degree of privacy which the press should allow to any President and his family.
If in the last few months your White House reporters and photographers have been attending church services with regularity, that has surely done them no harm.
On the other hand, I realize that your staff and wire service photographers may be complaining that they do not enjoy the same green privileges at the local golf courses that they once did.
It is true that my predecessor did not object as I do to pictures of one's golfing skill in action. But neither on the other hand did he ever bean a Secret Service man.
My topic tonight is a more sober one of concern to publishers as well as editors.
I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The events of recent weeks may have helped to illuminate that challenge for some; but the dimensions of its threat have loomed large on the horizon for many years. Whatever our hopes may be for the future - for reducing this threat or living with it - there is no escaping either the gravity or the totality of its challenge to our survival and to our security - a challenge that confronts us in unaccustomed ways in every sphere of human activity.
This deadly challenge imposes upon our society two requirements of direct concern both to the press and to the President - two requirements that may seem almost contradictory in tone, but which must be reconciled and fulfilled if we are to meet this national peril. I refer, first, to the need for a far greater public information; and, second, to the need for far greater official secrecy.
I
The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it is in my control. And no official of my Administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know.
But I do ask every publisher, every editor, and every newsman in the nation to reexamine his own standards, and to recognize the nature of our country's peril. In time of war, the government and the press have customarily joined in an effort based largely on self-discipline, to prevent unauthorized disclosures to the enemy. In time of “clear and present danger,” the courts have held that even the privileged rights of the First Amendment must yield to the public's need for national security.
Today no war has been declared - and however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger. And yet no war has been declared, no borders have been crossed by marching troops, no missiles have been fired.
If the press is awaiting a declaration of war before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of “clear and present danger,” then I can only say that the danger has never been more clear and its presence has never been more imminent.
It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions - by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence - on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.
Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with a war-time discipline no democracy would ever hope or wish to match.
Nevertheless, every democracy recognizes the necessary restraints of national security - and the question remains whether those restraints need to be more strictly observed if we are to oppose this kind of attack as well as outright invasion.
For the facts of the matter are that this nation's foes have openly boasted of acquiring through our newspapers information they would otherwise hire agents to acquire through theft, bribery or espionage; that details of this nation's covert preparations to counter the enemy's covert operations have been available to every newspaper reader, friend and foe alike; that the size, the strength, the location and the nature of our forces and weapons, and our plans and strategy for their use, have all been pinpointed in the press and other news media to a degree sufficient to satisfy any foreign power; and that, in at least in one case, the publication of details concerning a secret mechanism whereby satellites were followed required its alteration at the expense of considerable time and money.
The newspapers which printed these stories were loyal, patriotic, responsible and well-meaning. Had we been engaged in open warfare, they undoubtedly would not have published such items. But in the absence of open warfare, they recognized only the tests of journalism and not the tests of national security. And my question tonight is whether additional tests should not now be adopted.
The question is for you alone to answer. No public official should answer it for you. No governmental plan should impose its restraints against your will. But I would be failing in my duty to the nation, in considering all of the responsibilities that we now bear and all of the means at hand to meet those responsibilities, if I did not commend this problem to your attention, and urge its thoughtful consideration.
On many earlier occasions, I have said - and your newspapers have constantly said - that these are times that appeal to every citizen's sense of sacrifice and self-discipline. They call out to every citizen to weigh his rights and comforts against his obligations to the common good. I cannot now believe that those citizens who serve in the newspaper business consider themselves exempt from that appeal.
I have no intention of establishing a new Office of War Information to govern the flow of news. I am not suggesting any new forms of censorship or any new types of security classifications. I have no easy answer to the dilemma that I have posed, and would not seek to impose it if I had one. But I am asking the members of the newspaper profession and the industry in this country to re-examine their own responsibilities, to consider the degree and the nature of the present danger, and to heed the duty of self-restraint which that danger imposes upon us all.
Every newspaper now asks itself, with respect to every story: “Is it news?” All I suggest is that you add the question: “Is it in the interest of the national security?” And I hope that every group in America - unions and businessmen and public officials at every level - will ask the same question of their endeavors, and subject their actions to the same exacting tests.
And should the press of America consider and recommend the voluntary assumption of specific new steps or machinery, I can assure you that we will cooperate whole-heartedly with those recommendations.
Perhaps there will be no recommendations. Perhaps there is no answer to the dilemma faced by a free and open society in a cold and secret war. In times of peace, any discussion of this subject, and any action that results, are both painful and without precedent. But this is a time of peace and peril which knows no precedent in history.
II
It is the unprecedented nature of this challenge that also gives rise to your second obligation - an obligation which I share. And that is our obligation to inform and alert the American people - to make certain that they possess all the facts that they need, and understand them as well - the perils, the prospects, the purposes of our program and the choices that we face.
No President should fear public scrutiny of his program. For from that scrutiny comes understanding; and from that understanding comes support or opposition. And both are necessary. I am not asking your newspapers to support the Administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed.
I not only could not stifle controversy among your readers - I welcome it. This Administration intends to be candid about its errors; for as a wise man once said: “An error does not become a mistake until you refuse to correct it.” We intend to accept full responsibility for our errors; and we expect you to point them out when we miss them.
Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed - and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment - the only business in America specifically protected by the Constitution - not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply “give the public what it wants” - but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate and sometimes even anger public opinion.
This means greater coverage and analysis of international news - for it is no longer far away and foreign but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels, must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security - and we intend to do it.
III
It was early in the Seventeenth Century that Francis Bacon remarked on three recent inventions already transforming the world: the compass, gunpowder and the printing press. Now the links between the nations first forged by the compass have made us all citizens of the world, the hopes and threats of one becoming the hopes and threats of us all. In that one world's efforts to live together, the evolution of gunpowder to its ultimate limit has warned mankind of the terrible consequences of failure.
And so it is to the printing press - to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news - that we look for strength and assistance, confident that with your help man will be what he was born to be: free and independent.
Daniela Zini
Copyright © 12 febbraio 2014 ADZ


Chi può dire se, quando le strade si incontreranno, questo Amore sarà nel tuo cuore?
Giovedì 13 Febbraio,2014 Ore: 20:24